 VARTHEMA, Lodovico de. – Viaggiatore italiano del sec. XVI. Sembra probabile (in via congetturale) che nascesse a Bologna, intorno al 1465-1470. Ed è anche da credere che avesse per qualche tempo seguito il mestiere delle armi. Sappiamo che nel 1500 si partì da Venezia e, sbarcato in Egitto ad Alessandria, si recò al Cairo, poi, ripreso il mare, a Beirut e a Tripoli di Siria, e di qui ad Aleppo e a Damasco, dove si trattenne fino all’aprile del 1502 per apprendere l’arabo. Stretta qui amicizia con un cristiano rinnegato che guidava una numerosa carovana di pellegrini mussulmani, si condusse insieme con questi alla Mecca, compiendo per primo fra gli occidentali quel viaggio e per primo lasciandoci della regione e delle cerimonie religiose cui fu presente, una viva e fedele descrizione. Invece di tornare poi in Siria, si unì ad altri pellegrini diretti in Persia, ma ad Aden, accusato di essere spia dei Portoghesi, fu gettato in prigione e poi condotto a Rada (Rauddha), a N. di San’ā, dove riuscì a entrar nelle grazie della sultana, e così a farsi rimettere in libertà. Poté anzi a suo agio scorrere in lungo e in largo lo Yemen, che nessun Europeo aveva visitato prima di lui; quindi passò in Persia, si spinse fino a Herāt, e da Hormuz volse in India, in compagnia di un mercante persiano conosciuto a Shirāz. Costeggiato il Malabar, approdò a Ceylon, e da Ceylon risalì il Coromandel fino a Palicat, traversò quindi il Golfo del Bengala per toccar terra a Tenasserim nel Siam, e poi, con altre navigazioni, a Chittagong (Banghella) e a Pegù. Continuò quindi il suo itinerario per Malacca, Sumatra, le Molucche, Borneo e Giava, donde tornò a Malacca e a Calicut. A Calicut il Varthema s’incontrò con due mercanti di Milano, che avevano accettato di aiutare, fabbricando pezzi d’artiglieria, i preparativi degl’Indiani contro i Portoghesi, e si condusse in modo da meritare la fiducia di questi, al cui fianco combatté nello scontro navale di Cananor (16 marzo 1506). Ne ebbe in compenso dal viceré F. d’Almeida la carica di sorvegliante dei mercanti, ma tornò presto alle armi, portandosi così valorosamente, che venne dal viceré stesso creato cavaliere sul campo di battaglia. Ottenuto alla fine di rimpatriare, lasciò l’India il 6 dicembre 1507 con una squadra di navi portoghesi comandata da Tristan d’Acunha. Compiuta la circumnavigazione dell’Africa, approdò a Lisbona nel giugno del 1508 e si ebbe a Cintra dal re Manoel la conferma del titolo concessogli dal D’Almeida. Da questo momento si perdono le tracce del Varthema; si sa solo che nel novembre dello stesso anno era a Venezia a riferire in Consiglio dei suoi viaggi. È sicuro però che passò gli ultimi anni della sua vita a Roma dove morì certo innanzi il giugno del 1517.
VARTHEMA, Lodovico de. – Viaggiatore italiano del sec. XVI. Sembra probabile (in via congetturale) che nascesse a Bologna, intorno al 1465-1470. Ed è anche da credere che avesse per qualche tempo seguito il mestiere delle armi. Sappiamo che nel 1500 si partì da Venezia e, sbarcato in Egitto ad Alessandria, si recò al Cairo, poi, ripreso il mare, a Beirut e a Tripoli di Siria, e di qui ad Aleppo e a Damasco, dove si trattenne fino all’aprile del 1502 per apprendere l’arabo. Stretta qui amicizia con un cristiano rinnegato che guidava una numerosa carovana di pellegrini mussulmani, si condusse insieme con questi alla Mecca, compiendo per primo fra gli occidentali quel viaggio e per primo lasciandoci della regione e delle cerimonie religiose cui fu presente, una viva e fedele descrizione. Invece di tornare poi in Siria, si unì ad altri pellegrini diretti in Persia, ma ad Aden, accusato di essere spia dei Portoghesi, fu gettato in prigione e poi condotto a Rada (Rauddha), a N. di San’ā, dove riuscì a entrar nelle grazie della sultana, e così a farsi rimettere in libertà. Poté anzi a suo agio scorrere in lungo e in largo lo Yemen, che nessun Europeo aveva visitato prima di lui; quindi passò in Persia, si spinse fino a Herāt, e da Hormuz volse in India, in compagnia di un mercante persiano conosciuto a Shirāz. Costeggiato il Malabar, approdò a Ceylon, e da Ceylon risalì il Coromandel fino a Palicat, traversò quindi il Golfo del Bengala per toccar terra a Tenasserim nel Siam, e poi, con altre navigazioni, a Chittagong (Banghella) e a Pegù. Continuò quindi il suo itinerario per Malacca, Sumatra, le Molucche, Borneo e Giava, donde tornò a Malacca e a Calicut. A Calicut il Varthema s’incontrò con due mercanti di Milano, che avevano accettato di aiutare, fabbricando pezzi d’artiglieria, i preparativi degl’Indiani contro i Portoghesi, e si condusse in modo da meritare la fiducia di questi, al cui fianco combatté nello scontro navale di Cananor (16 marzo 1506). Ne ebbe in compenso dal viceré F. d’Almeida la carica di sorvegliante dei mercanti, ma tornò presto alle armi, portandosi così valorosamente, che venne dal viceré stesso creato cavaliere sul campo di battaglia. Ottenuto alla fine di rimpatriare, lasciò l’India il 6 dicembre 1507 con una squadra di navi portoghesi comandata da Tristan d’Acunha. Compiuta la circumnavigazione dell’Africa, approdò a Lisbona nel giugno del 1508 e si ebbe a Cintra dal re Manoel la conferma del titolo concessogli dal D’Almeida. Da questo momento si perdono le tracce del Varthema; si sa solo che nel novembre dello stesso anno era a Venezia a riferire in Consiglio dei suoi viaggi. È sicuro però che passò gli ultimi anni della sua vita a Roma dove morì certo innanzi il giugno del 1517.
L’itinerario che di lui ci rimane (ultima ed. italiana, a cura di P. Giudici, Milano 1928) e al quale è affidata la sua fama raccoglie ed espone i risultati di una lunga esperienza di viaggi, relativi a regioni che in parte venivano per la prima volta rivelate agli Europei. Come ad altri viaggiatori di quell’epoca, non sono mancati al V. critiche e rimproveri, specialmente per quanto si attiene alle notizie che egli ci dà sulle Isole della Sonda, nelle quali egli avrebbe preceduto di qualche poco l’arrivo dei Portoghesi (v’è anche un accenno esplicito alle stelle visibili nel continente australe, e uno un po’ vago dell’esistenza di un continente abitato, a mezzogiorno di Giava, sulla cui identificazione tuttavia non possono cader dubbî). Ma in realtà lacune e contraddizioni, che non meravigliano in chi, a tanta distanza di tempo, deve render conto di peregrinazioni così lunghe e movimentate, non possono toglier fede a un racconto nella sua semplicità schietto e dimesso, quanto pochi di quello e del secolo seguente. Uomo d’arme e spirito pratico senza pastoie dottrinali né borie cavalleresche, il V. appartiene a quella numerosa schiera d’Italiani che hanno saputo porre il proprio acume di osservatori, il proprio buon senso e soprattutto la propria eccezionale intuizione a servizio di una curiosità istintivamente volta a nobilitare e potenziare la dignità umana. La sua semplicità e naturalezza non sono segno di povertà spirituale, ma di un’immediatezza e di una concretezza che attestano, al contrario, una natura complessa, da cui l’esperienza distilla un raro approfondimento dell’uomo e del mondo in cui opera. L’Itinerario costituisce un prezioso riflesso dell’Oriente arabo e indiano, non veduto soltanto, ma vissuto e penetrato dal didentro, e perciò colorito da un brio che trapassa qua e là in una temperata e diffusa ironia. Pubblicato per la prima volta nel 1511, ebbe un enorme successo: quaranta edizioni a stampa nel sec. XVI, senza contare i numerosi estratti, e una decina nel successivo. Oltre che in latino (1511), fu tradotto in tedesco (1515), in spagnolo (1520), in fiammingo (1544): in francese (1556) e in inglese (1577) e utilizzato così dai geografi come dai cartografi per almeno due secoli.
(Giuseppe CARACI per l’Enciclopedia Treccani)
DISCORSO SOPRA LO ITINERARIO DI LODOVICO BARTHEMA.
Questo Itinerario di Lodovico Barthema bolognese, nel qual tanto particularmente si narrano le cose dell’India e isole delle speciarie, che da niun degli antichi si trovan scritte così minutamente, è stato molti anni letto con infiniti errori e incorrezioni; e ancor nell’avvenir così si leggeria, se ‘l nostro Signor Iddio non ne avesse fatto venir alle mani un libro de un Cristoforo di Arco, clerico di Sibillia, il quale, avendo avuto un esemplar latino di detto viaggio, tratto dal proprio originale dirizzato al reverendissimo cardinal Carvaial di Santa Croce, lo tradusse in lingua spagnuola con gran diligenzia. Dal qual abbiamo avuta commodità di corregger ora la presente opera in molti luochi, la qual fu dal proprio auttor scritta nella lingua nostra vulgare e indirizzata alla illustrissima madonna Agnesina, una delle singulari ed eccellenti donne che a quelli tempi in Italia fusse, che fu figliuola dell’illustrissimo signor Federico duca de Urbino, e sorella dell’excellentissimo signor Guidobaldo, e moglie dell’illustrissimo signor Fabricio Colonna, e madre dell’excellentissimo signor Ascanio Colonna e della signora Vettoria marchesa dal Guasto. E il prefato Lodovico divise questo Itinerario in sei libri, nel primo delli quali narra dell’andar suo in Egitto, Soria e Arabia Deserta; nel secondo tratta dell’Arabia Felice; nel terzo della Persia; nel quarto e quinto scorre tutta l’India e l’isole Molucche, dove nascon le spezie; nell’ultimo si contien il ritorno suo in Portogallo, passando appresso le marine dell’Etiopia, Capo di Buona Speranza, con alcune isole del mar Oceano occidentali.
[Dedica]
Alla illustriss. ed eccellentiss. Signora la Signora contessa di Albi e duchessa di Tagliacozzo, Madama Agnesina Feltria Colonna, Lodovico di Barthema bolognese.
Molti uomini sono già stati, li quali si sono dati alla investigazione delle cose terrene, e per diversi studii e mezzi e fidelissime relazioni si sono sforzati pervenire al lor desiderio. Altri poi di più perspicace ingegno, non li bastando la terra, cominciorono con sollecite osservazioni e vigilie (come Caldei e Fenici) a discorrere le altissime regioni del cielo: di che meritamente ciascun di loro cognosco aver conseguita dignissima laude appresso degli altri, e di se medesimi pienissima sodisfazione. Donde io, avendo grandissimo desiderio di simili effetti, lasciando stare i cieli, come peso convenevole alle spalle di Atlante e di Ercole, mi disposi a voler investigare qualche particella di questo nostro terreno globo; né avendo animo (cognoscendomi di tenuissimo ingegno) per studio over conghietture pervenir a tal desiderato fine, deliberai con la propia persona e con gli occhi medesimi cercar di cognoscer li siti delli luochi, le qualità delle persone, le diversità degli animali, la varietà degli arbori fruttiferi e odoriferi dell’Egitto, della Soria e dell’Arabia Deserta e Felice, della Persia, dell’India, dell’Etiopia, massime ricordandomi esser più da stimare un testimonio di vista che dieci d’udita.
Avendo adunque col divino aiuto in parte sodisfatto all’animo mio, e ricercate varie provincie e strane nazioni, mi pareva niente aver fatto se delle cose da me viste e provate, meco tenendole ascose, non ne facessi partecipi gli altri uomini studiosi. Onde mi sono ingegnato, secondo le piccole forze, di scriver questo mio viaggio più diligentemente che ho potuto, giudicando far cosa grata alli lettori, che, dove io con grandissimi pericoli e intolerabili fatiche mi sono dilettato vedendo nuovi abiti e costumi, loro senza disconcio o pericolo leggendo ne piglino quel medesimo frutto e piacere.
Ripensando poi a chi meglio potessi indrizzare queste mie fatiche, mi occorse Vostra illustriss. ed eccellentiss. Signoria, quasi unica osservatrice delle cose notabili e amatrice di ogni virtù. Né mi par vano il mio giudicio, per l’infusa sapienzia dal splendor e lume dello illustrissimo ed eccellentissimo Signor duca d’Urbino suo genitore, quasi a noi un sole d’arme e di scienzia. Non parlo dello eccellentiss. S. suo fratello, che in studii greci e latini (giovene anche) fa di sé tal esperienzia, che oggidì è quasi un Demostene e Cicerone nominato. Onde, essendo in V. illustrissima S. derivata ogni virtù da così ampii e chiari fiumi, non può altro che dilettarsi delle opere grandi e maravigliose e averne gran sete. Quantunque, a quel che in essa si conosce, più volentieri dove con l’ale della mente vola con li corporei piedi anderia, ricordandosi esser questa una delle laudi data al sapientissimo e facondo Ulisse, di aver veduti li costumi di molti uomini e di molti paesi. Ma perché V. illustriss. S. nelle cose del suo illustriss. Signor e consorte, è occupata, qual come nuova Artemisia ama e osserva, allevandogli due gentil piante che sono come un Apolline e Diana, e circa l’inclita famiglia, qual con mirabil regola addorna di costumi, dirò esser assai se l’animo suo si pascerà, tra altre opere ottime, di questa, benché inculta, ma forse fruttuosa lezione. Né farà come molte altre, che porgono l’orecchie a canzonette e vane parole, le ore sprezzando, contrarie all’angelica mente di V. illustrissima Signoria, che non lassa passare punto di tempo senza qualche buon frutto. La benignità della quale facilmente potrà supplire dove mancherà la inordinata continuazione di essa, pigliando solamente la verità delle cose. E se queste mie fatiche le saranno grate e le approbarà, assai gran laude e sodisfazione mi parrà aver ricevuta del mio lungo peregrinare, anzi più presto paventoso esilio, dove infinite volte ho tolerata fame e sete, freddo e caldo, guerra, prigione e infiniti altri pericolosi incommodi, animandomi più forte a questo altro viaggio, quale in breve spero di fare: che, avendo cercate parti delle terre e isole orientali, meridionali e occidentali, son disposto, piacendo al Signor Dio, cercar ancora le settentrionali. E così, poi che ad altro studio non mi vedo esser idoneo, spenderò nel resto di questo laudabile esercizio il rimanente de’ miei fuggitivi giorni.
[Arabia Felice]
I
1
Di Alexandria.
Il desiderio il quale molti altri ha spronato a vedere la diversità delle monarchie mondane, similmente alla medesima impresa mi incitò. E perché tutti gli altri paesi dalli nostri antichi assai sono stati dilucidati, per questo nel mio animo desiderai vedere paesi dalli nostri meno frequentati. Onde, partendomi da Venezia con l’aiuto del nostro Signor Iddio, navigai tanto per le nostre giornate ch’arrivai in Alessandria, città d’Egitto, le qualità della qual essendo notissime si pretermetteno; ma desideroso di cose nuove, entrato nel fiume Nilo me ne gionsi al Cairo.
2
Del Cairo.
Pervenuto nel Cairo, stupefatto prima della fama della sua grandezza, fui resoluto non esser tanto quanto si predica, ma la grandezza sua è come il circuito di Roma; vero è ch’è più abitato assai che non è Roma, e fa molte più genti. L’errore di molti è questo, che di fuori del Cairo sono certe ville, le quali credono alcuni che siano del circuito di esso Cairo: la qual cosa non può essere, perché sono lontane dua o tre miglia e sono proprii villaggi. Non sarò prolisso a narrare della lor fede e costumi, perché si sa publicamente esser da Mori e Mammalucchi abitato, de’ quali è signore il gran soldano, il quale è servito da’ Mammalucchi, signori de’ Mori.
3
Di Barutti, Tripoli e Alepo.
Circa le ricchezze e la bellezza del detto Cairo, e della superbia de’ Mammalucchi, perché sono cose a tutti e’ nostri manifeste, metterò fine; ma de qui partendomi, a seconda del Nilo me ne ritornai in Alessandria, donde faccendo vela per mare arrivai in Barutti, città e porto della Soria: e possono esser da 500 miglia. Nel qual Barutti stetti molti giorni, ed è terra molto abitata da’ Mori, e d’ogni cosa molto abbondante. Il mare batte nelle mura: non è circondata tutta intorno di mura, ma solamente dalla banda verso ponente, cioè verso il mare. Ivi non viddi cosa alcuna degna di memoria, salvo una anticaglia, dove dicono che era posta la figliuola del re quando il dragone la dovea divorare, e dove san Giorgio, ammazzato detto dragone, la restituì al padre: la quale è tutta in ruina.
E partitomi de lì, andai alla volta di Tripoli di Soria, che sono due giornate verso levante; il qual Tripoli è sottoposto al gran soldano, e tutti sono maumettani, e la detta città è abbondante d’ogni cosa. E de lì poi pervenni in Alepo, che sono otto giornate dentro in terra ferma, il qual Alepo è una bellissima città ed è sottoposta al gran soldano del Cairo, ed è scala della Turchia e della Soria, e sono tutti maumettani. È terra di grandissimo traffico di mercanzia, e massime di Persiani e Azzamini che arrivano fin lì; e ivi si piglia il cammino per andare in Turchia e in Soria, cioè di quelli che vengono di Azzamia.
4
Di Aman e di Menin.
Dapoi me ne andai alla volta di Damasco, che sono giornate dieci piccole. Alla metà del cammino v’è una città chiamata Aman, nella quale nasce grandissima quantità di bombagio e frutti assai buoni. E appresso a Damasco sedeci miglia trovai un’altra terra chiamata Menin, la qual è posta in cima d’un monte ed è abitata da cristiani alla greca, e sono sottoposti al signor di Damasco: nella qual terra sono due bellissime chiese, le quali dicono aver fatte far santa Elena madre di Constantino. Ivi nascono bonissimi frutti, e massime buone uve lunge e senza ciolo, e sonovi bellissimi giardini e fontane.
Partitomi de lì, arrivai alla nobilissima città di Damasco.
5
Di Damasco.
Veramente non potria dire la bellezza e bontà di questa nobilissima città, nella qual dimorai alcuni mesi per imparar la lingua moresca. È abitata tutta da Mori e Mammalucchi, e anco da molti cristiani grechi. E qui mi occorre recitar il governo del signore, il qual è sottoposto al gran soldano del Cairo. Nella detta città è uno bellissimo e forte castello, il qual dicono aver fondato un Mammalucco fiorentino a spesa sua, essendo signor di quella: e fin oggidì in ogni cantone di detto castello è scolpita l’arma di Fiorenza in marmo. E ha le fosse intorno grandissime, con quattro fortissimi torrioni e con ponti levatori e buona artegliaria, e di continuo vi stanno 50 Mammalucchi provisionati col castellano, li quali stanno ad instanzia del gran soldano. E quel Fiorentino era mammalucco del gran soldan, e nel tempo suo fu (com’è fama) attossicato il soldano e, non trovandosi chi lo liberasse di detto tossico, Dio volse che ‘l detto Fiorentino lo liberò: e per questo li dette la detta città di Damasco, e così fec’il castello. Poi morse in Damasco, e il popolo l’ha in tanta venerazione quanto si fusse stat’un santo, con grandi luminarie. E d’allora in qua sempr’il castello sta a posta del soldano, e quando si fa un soldan nuovo, uno delli suoi signori, li quali si chiaman ammiragli, dice: “Signore, io son stato gran tempo tuo schiavo; donami Damasco e io ti darò 100 o 200 mila seraffi d’oro”. Il soldan li fa la grazia. Ma è da sapere che, s’in termine poi di duoi anni il detto signor non li manda detti migliaria di seraffi, egli cerca di farlo morire, per forza d’arme o in qualche altro modo, e faccendoli il detto presente rimane in signoria.
Il detto signore ha sempre dieci over dodeci signori e baroni della città con lui, e quando il gran soldano vuol dugento o trecentomila seraffi da lui, over dalli signori overo mercanti di detta città (perché loro non usano iustizia, ma solo robbamenti e assassinamenti come chi più può, perché i Mori stanno sotto alli Mammalucchi come l’agnello sotto il lupo), manda due lettere al castellano del detto castello, delle quali l’una in semplice tenore contiene ch’ei debbia congregare nel castello quelli signori over mercanti che a lui piace, e poi congregati si legge la seconda lettera, il tenor della quale subito si esequisse, o in bene o in male: e in questo modo il detto gran soldano cerca di trovar danari. E qualche fiata il signor di Damasco si fa tanto forte che ei non vorrà andare in castello, e ancora molti baroni e mercadanti, sentendosi invidiati, montano a cavallo e tirano alla volta della Turchia, per fuggir questa tirannia.
E di questo non vi diremo altro, se non che la guardia del detto castello è questa, che in ciascuno delli quattro torrioni gli uomini che stanno a guardare la notte non gridano niente, ma ciascuno ha un tamburo fatto a modo di una mezza botta, e li dà una gran botta con un bastone, e uno con l’altro si rispondono con detti tamburi: e tardando a rispondere il termine d’un paternostro, sono posti in prigione per uno anno.
6
Del detto Damasco.
Poi che detto abbiamo delli costumi del signor di Damasco, al presente mi occorre referire alcune cose della città, la quale è molto populata e molto ricca. Non si potria stimar la ricchezza e la gentilezza de’ lavori che ivi si fanno; qui avete grandissima abbondanza di grano e di carne, ed è la più abbondante terra de frutti che mai si vedesse, e massime d’uva d’ogni tempo fresca. Dirò delli frutti buoni che vi sono e de’ tristi: melegranate e melecotogne buone, mandorle e olive grosse buonissime, rose bianche e rosse le più belle che mai si vedessero, belli pomi e peri e persichi, ma tristissimi al gusto: e la cagione di questo è che Damasco è molto abbondante di acque. Va una fiumara per mezzo della città, e una gran parte delle case ha fontane bellissime di mosaico; e le stanzie di fuori sono brutte, ma dentro sono bellissime, con molti lavori di marmo e di porfido. E vi sono molte moschee: fra l’altre ve n’è una principale, ch’è della grandezza di San Pietro di Roma, ma è scoperta in mezzo e intorno è coperta in volto, e lì tengon il corpo di san Zacaria profeta, com’è fama, e fannoli grandissimo onore; e nella detta moschea sono quattro porte principali di metallo, e dentro vi sono molte fontane. Vedesi ancora dov’era la canonica che fu già de’ cristiani, nella quale sono molti lavori antichi di mosaico. Ancora si vede dove dicono Cristo aver detto a san Paolo: “Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?”, qual luoco è fuori d’una porta di detta città circa un miglio, e ivi si sepelliscono tutti li cristiani che morono in detta città. È ancora nelle mura di detta città quella finestra, dove (come dicono) san Paolo stav’in prigione: li Mori più volte l’hanno murata, e la mattina si trova rotta e smurata, come l’angelo la ruppe quando tirò san Paolo fuor di detta finestra. Ancor viddi quella casa dove Cain (come si dice) ammazzò Abel suo fratello, la qual è fuori dell’altra banda della città un miglio, in una costa pendente sopr’un vallone.
Or torniamo alla libertà che i detti Mammalucchi hanno in detta città di Damasco.
7
De’ Mammalucchi in Damasco e della sua libertà.
Li Mammalucchi sono cristiani renegati e comprati dal detto signore, li quali mai non perdono tempo, ma sempre o in arme o in lettere si esercitano, finché siano ammaestrati. E ogni Mammalucco, grande o piccolo che sia, ha di soldo sei seraffi al mese, e le spese per lui e per il cavallo e un famiglio, e tanto più hanno quanto più fanno alcune esperienze nella guerra. Li detti Mammalucchi, quando vanno per la città, sono sempre accompagnati da duoi o tre al manco, perché gli saria gran vergogna s’andassero soli. Scontrandosi per caso in due o tre donne, hanno questa libertà, e se non l’hanno se la pigliano: vanno ad aspettar queste donne in certi luochi, come seriano ostarie grandi, e come esse donne passano davanti alla porta, ciascuno Mammalucco piglia la sua per la mano e tirala dentro e fa quello che li piace. E se la donna fa resistenza di darsi a conoscere (perché tutte portano il viso coperto, in modo che loro conoscono noi e noi non conosciamo loro), il Mammalucco le dice che la vorria conoscere. Ed essa gli risponde: “Fratello, non ti basta che di me fai quello che vuoi, senza volermi conoscere?” e tanto lo prega che la lascia. E alcuna volta credono pigliare la figliuola del signore e pigliano le loro proprie mogli: e questo è intravenuto al tempo mio.
Queste donne vanno molto ben vestite di seta, e di sopra portano certi panni bianchi di bombagio, sottili e lustri come seta, e portano tutte li borzacchini bianchi e scarpe rosse overo pavonazze, e molte gioie intorno alla testa e all’orecchie e alle mani. Le qual donne si maritano a beneplacito loro, cioè, quando non vogliono più stare col marito, se ne vanno al cadì della fede loro e lì si fanno separar dal marito, e lui piglia altra moglie. E benché alcuni dicano che li Mori tengono cinque o sei mogli, io per me non ho mai veduto se non che ne tengono due over tre al più.
Questi Mori la maggior parte mangiano nelle strade, cioè dove si vendono le robe, e fansi cocere il mangiare, e vi mangiano molta carne di cavallo, camelli e buffali e castrati e capretti assai. E quivi è abbondanzia di buoni caci freschi, e quando volete comprar il latte, vanno ogni dì per la terra quaranta e cinquanta capre, le quali hanno l’orecchie lunghe più d’un palmo: il padrone di esse ve le mena suso nella camera vostra, se ben la casa avesse tre solari, e lì in presenzia vostra ve ne mugne quanto volete in un bel vaso stagnato, e avete molti capi di latte. Qui ancora si vende gran quantità di tartuffale, e alcuna volta ne viene venticinque o trenta camelli carghi, e de lì in tre o quattro giorni sono vendute: e vengono dalle montagne dell’Armenia e di Turchia. Li detti Mori vanno vestiti con certe veste lunghe e larghe di seta over di panno, senza cingerle; la più parte portano calzoni di bombagio e scarpe bianche. Li quali, quando scontrano un Mammalucco, benché fusse Moro e principal mercante, bisogna che ‘l faccia onore e largo al Mammalucco, e non lo faccendo lo bastonano. Vi sono molti fontichi de cristiani, che tengono panni e seta e rasi, velluti e rami e di tutte mercanzie che bisogna; ma sono mal trattati.
8
Come da Damasco si va alla Mecca, dove si descrivono li costumi di Arabi che stanno alla campagna.
Avendo dechiarate forse più diffusamente le cose di Damasco che non si dovea, l’opportunità mi sollecita di raccontar il mio viaggio. Nel 1503, adì 8 d’aprile, mettendosi in ordine la carovana per andar alla Mecca, ed essendo io volontaroso di veder varie cose e non sapendo in che modo, pigliai grande amicizia col capitano de’ detti Mammalucchi della carovana, il qual era cristiano renegato, per modo ch’egli mi vestì da Mammalucco e dettemi un buon cavallo, e messemi in compagnia d’altri Mammalucchi: e questo fu per forza di danari e de altre cose ch’io gli donai. E così ci mettemmo in cammino, e andammo tre giornate ad un luoco che si chiama il Mezeribe; e ivi ci fermammo tre giorni, per fornir li mercanti e comprar camelli e quanto a loro era necessario.
In questo Mezeribe è signore uno che si chiama Zambei, ed è signor della campagna, cioè degli Arabi: il qual Zambei ha tre fratelli e quattro figliuoli maschi, e ha quarantamila cavalli, e per la corte sua ha diecimila cavalle femine, e qui tiene quarantamila camelli, che dura due giornat’il pascolar suo. E detto signor Zambei, quando vuole, tiene in guerra il soldano del Cairo e il signor di Damasco e di Ierusalem. E quando è il tempo delle raccolte, alcuna volta credono ch’ei sia lontano cento miglia, ed egli si trova la mattina a far una correria alle are della detta città, e trova il grano e l’orzo bello insaccato e portaselo via. Alcuna volta corre un dì e una notte con le dette cavalle che mai si fermano, e quando son giunti gli danno a bere latte di camella, perché gli è molto refrescativo. Veramente mi pare non che corrano, ma che volino come falconi, perché io mi sono trovato con loro. Ed è da sapere che vanno la maggior parte a cavallo senza sella, e tutt’in camicia, salvo alcuni uomini principali; e l’armatura sua è una lancia di canna d’India lunga 10 over 12 braccia, con un poco di ferro in cima e con una banderola di seda; e quando vanno a far qualche correria, vanno stretti come stornelli. E li detti Arabi sono uomini molto piccoli e di color leonato scuro, e hanno la voce feminile e li capelli lunghi, stesi e neri. Sono veramente questi Arabi una grandissima quantità, e combattono continuamente fra loro. Questi abitano alla montagna e vengono, quando è il tempo che la carovana passa per andar alla Mecca, ad aspettarla alli passi per robarla; e menano con seco le mogli, i figliuoli e tutte le lor massarizie, e le case ancora sopra li cammelli, le qual case sono come una trabacca da uomo d’arme, e sono di lana nera e trista.
Alli XI d’aprile si partì ditta carovana da Mezaribe, che furon trentacinquemila camelli, e vi poteva esser circa 40 mila persone; e noi eravamo sessanta Mammalucchi in guardia di detta carovana, il terzo de’ quali andava innanzi con la bandiera, l’altro terzo in mezzo e l’altro da drieto. Il viaggio nostro facemmo in questo modo. Da Damasco alla Mecca sono 40 giorni e 40 notte di cammino. Noi partimmo la mattina da Mezaribe, e camminammo per fino a ventidue ore: in quel punto si fanno certi segnali dal capitano di mano in mano, che, dove si trovano, là si fermano tutti di compagnia, e nel scaricare e mangiar loro e li cammelli stanno per fino a ventiquattro ore; e poi fanno segnali, e subito cargano detti cammelli. Ed è da sapere che alli cammelli non gli danno da mangiare se non cinque pani di farina d’orzo crudi, e grossi quanto un pomo granato l’uno. E poi montano a cavallo, e camminano tutta la notte e tutto il dì seguente fino alle ventidue ore, e poi alle ventiquattro ore fanno il simile come prima. E ogni 8 giorni trovano acqua, cioè cavando la terra over sabbione, e ancora si trovano certi pozzi e cisterne; e in capo delli otto giorni si fermano un giorno over duoi per far reposar li detti cammelli, quali portano peso ciascuno quanto duoi muli: e alli poveri animali non danno da bere se non ogni tre giorni una volta.
9
Del valor e forza che hanno i Mammalucchi.
Essendo noi fermati alle dette acque, sempre avemmo da combattere con grandissima quantità d’Arabi, né mai ammazzarono alcun di noi salvo che un uomo e una donna, perché tanta è la viltà degli animi loro che noi sessanta Mammalucchi eravamo sofficienti a defenderci da 40 o 50 mila Arabi: perché della gente pagana non è la migliore con l’arme in mano che i Mammalucchi. Certa cosa è ch’io viddi di belle esperienzie de’ Mammalucchi in questo viaggio: infra gli altri viddi un Mammalucco pigliar il suo schiavo e mettergli una melangola sopra la testa, e farlo stare 12 o 15 passi lontano da lui, e alla seconda volta levargli la detta melangola a tirar con l’arco. Ancora viddi un altro Mammalucco levarsi la sella e mettersela sopra la testa, e poi tornarla nel suo luoco primo senza cascare e sempre correndo. Li fornimenti delle loro selle sono a usanza nostra.
10
Della città di Sodoma e Gomorra.
Camminato ch’avemmo dodici giornate, trovammo la valle di Sodoma e Gomorra: veramente la Scrittura Santa non mente, perché si vede come furono rovinate per miracolo di Dio. E io dico come sono tre città ch’erano in cima tre monti, dove si vede ancora che in quel terreno par che sia sangue a modo di cera rossa, mescolata con la terra per tre o quattro braccia di profondità. Certamente io credo, per quello che ho veduto, ch’erano genti viziose, perché intorno è tutto paese deserto e la terra non produce cosa alcuna, né anche acqua; e queste genti vivevano di manna, e non riconoscendo il beneficio loro furono puniti da Dio: e per miracolo si veggono ancora al presente li segnali di tutte le dette città rovinate.
Passammo poi quella valle ch’era ben venti miglia, dove ci morirono trentatre persone per la sete, e molti furono sepolti nel sabbione, quali non erano ancora ben finiti di morire. Dipoi trovammo un monticello, appresso il quale era una fossa di acqua, di che fummo assai contenti. Noi ci fermammo sopra il detto monte; l’altro giorno dipoi, la mattina a buon’ora, vennero ventiquattromila Arabi, i quali dissero che pagassimo la sua acqua. Rispondemmo che non la volevamo pagare, perché quella acqua era data da Dio; ed essi cominciorono a combattere con noi, dicendo che avevamo tolto la sua acqua. Ci facemmo forti nel detto monte, e facemmo le mura de’ nostri camelli: e li mercadanti stavano in mezzo de’ detti camelli e noi continuamente stavamo a scaramuzzare, di modo che ci tennero assediati duoi giorni e due notti, e venimmo a tanto che noi e loro non avevamo più acqua da bere. Loro ci avevano circondato il monte intorno intorno di gente, con dire che ci volevano rompere la carovana; e per non aver più a combattere, fece consiglio il nostro capitano con li mercanti mori, e li donammo mille e ducento ducati d’oro. Essi pigliarono i danari, e dissero poi che diecimila ducati non pagariano la sua acqua: e noi conoscevamo che volevano altro che danari. Il nostro capitano, che era prudente, fece far un bando per la carovana, che tutti quegli uomini ch’erano buoni a pigliar arme non andassero a cavallo sopra li cammelli, ma che tutti pigliassero l’arme loro. La mattina seguente mettemmo tutta la carovana innanzi, e noi Mammalucchi rimanemmo drieto: e in tutti eravamo trecento persone. E cominciammo a buon’ora a combattere: furono ammazzati de’ nostri un uomo e una donna con gli archi, e non ci fecero altro male, e noi ammazzammo di loro milleseicento persone. Né è da maravigliare che noi ne ammazzammo tanti: la causa fu che loro erano tutti nudi e a cavallo senza sella, di modo ch’ebbero carestia di ritornare alla via loro.
11
Di una montagna abitata da giudei, e della città di Medina Thalnabi.
In termine d’otto giorni con gran piacere trovammo una montagna, la qual mostra di circuito 10 over 12 miglia. In questa abitano quattro o cinquemila giudei, li quali vanno nudi e sono piccoli di grandezza di cinque palmi l’uno over sei, e hanno la voce feminile, e sono più negri che d’altro colore, e non vivono d’altro che di carne di castrati. Sono circuncisi e confessano esser giudei, e se possono aver un Moro nelle mani, lo scorticano vivo. A’ piedi di detta montagna trovammo un ridutto di acqua, la quale è acqua che piove alli tempi: noi cargammo di detta acqua sedicimila cammelli, di che li giudei furono malcontenti; e andavano per quel monte come caprioli, e per niente volevano descendere al piano, perché sono nimici mortali de’ Mori. A’ piedi di detta acqua stanno sei over otto piè di albori di spine bianche molto belli, ne’ quali trovammo due tortore, il che ci parve come un miracolo, perché avevamo camminato quindici giorni e notti che mai non trovammo animal né uccello alcuno.
Il dì dapoi camminammo, e in due giornate arrivammo ad una città chiamata Medina Thalnabi, cioè città del profeta, appresso alla qual 4 miglia trovammo un pozzo, dove si fermò la carovana per un giorno: e a questo pozzo ogniuno si lavò e mutossi di panni netti per entrare nella città, la quale fa cerca trecento fuochi, e ha le mura intorno fatte di terra; le case dentro sono di muro e di pietre. Il paese intorno alla città ha avuto la maladizione da Dio perché la terra è sterile, salvo che fuora della terra duoi tratti di pietra vi sono forse cinquanta o sessanta piedi di datteri in un giardino, appresso del quale è un certo condutto d’acqua, che discende di un monte piccolo al basso ben ventiquattro piedi, della qual acqua se ne governa la carovana quando arriva lì.
Ora mi saria da riprendere alcuni che dicono che ‘l corpo di Maumetto sta in aere nella Mecca: dico che non è la verità, che ho visto la sua sepoltura in questa città di Medina Thalnabi, nella quale noi stemmo tre giorni. Nel primo che entrammo nella città, la volemmo veder tutta; poi, volendo entrar nella porta della moschea, ci dissero che bisognava che ciascun di noi fusse accompagnato da una persona, o piccola o grande, de loro medemi Mori, la qual ci pigliava per la mano e ci menava dove fu sepolto Maumetto.
12
Della moschea dove fu sepulto Maumetto e suoi compagni.
La moschea dove è sepulto Maumetto è fatta in questo modo: la è quadra, e lunga 100 passa e larga 80; ha due porte per intrarvi, una dalla parte davanti, l’altra da drieto; ha una nave dentro via che corre da tre bande, tutta coperta in volto, posta sopra 40 colonne di pietra cotta imbiancate, dove sono attaccate forse tremila lampade. A l’intrar della moschea da una banda vi è una torre di 5 passa per quadro, tutta in volto, ed è coperta intorno d’un panno de seda ricco, il piede della qual è fatto di metallo; e intorno vi è una ferrata di bronzo, dove stanno le persone a veder detta torre. Intrando poi in la moschea, a man manca vi è una porticella la qual vi mena alla detta torre, dove gionto vi è un’altra porta piccola: e da un lato di quella vi stanno cerca 20 libri e da l’altro circa altri 25, tutti ligati riccamente, li quali sono di Macometto e de’ suoi compagni, e in quelli si contiene la vita di esso Maumetto e i comandamenti della sua setta. Dentro la detta porta è una sepoltura, cioè fossa sotto terra, dove fu messo Maumetto; vi sono anche duoi suoi generi, cioè Haly e Othman, qual Haly fu figliuolo de un suo fratello e tolse per moglie Fatma, figliuola di Maumetto. Vi sono appresso duoi suoi soceri, cioè Bubecher e Homer: questo Bubecher fu quello che noi diciamo che venne a Roma per farsi cardinale, ma non li successe. E questi quattro furono capitani di Maumetto, e ciascun di questi ha li suoi libri ivi posti delle cose che fecero, e delli comandamenti e regole che dettero alli Mori del vivere. E per questo rispetto quella canaglia si tagliano a pezzi tra loro, perché chi vuol far a comandamento di uno e chi d’un altro: e così non si sanno risolvere e si ammazzan come bestie sopra queste eresie, le quali tutte son false.
13
Del ragionamento che ebbe il capitano della carovana con il sacerdote di detta moschea.
Per dechiarazione della setta di Maumetto, è da sapere che sopra la detta torre sta una cupola, nella quale si può andare intorno disopra, cioè di fuora: intendete che malizia usorono a tutta la carovana. La prima sera che venimmo al sepolcro di Maumetto, il nostro capitano fece chiamare il superiore sacerdote di detta moschea, e dissegli che li mostrasse il corpo del Nabi (questo Nabi vuol dire il profeta Maumetto), che gli daria tremila seraffi d’oro; e ch’egli non avea né padre né madre né fratelli né sorelle né mogli né figliuoli, né manco era venuto per comprar speziarie né gioie, ma ch’era venuto per salvar l’anima sua e per veder il corpo del profeta. E il sacerdote li rispose con grandissimo impeto e furia e superbia, dicendo: “Come quest’occhi tuoi, i quali hanno commesso tanto male al mondo, voglion veder colui per il quale Dio ha creato il cielo e la terra?” Allora il nostro capitano disse: “Signore, tu dici il vero, ma fammi una grazia, lasciami veder il corpo del profeta, e subito che l’arò visto, per amor suo mi voglio cavar gli occhi”. E il sacerdote li rispose: “O signore, io ti voglio dire la verità. È vero che ‘l nostro profeta volse morir qui per dar buono esempio a noi, perché ben poteva morir alla Mecca se ‘l voleva, ma volse usare la povertà per ammaestramento nostro; e subito ch’ei fu morto, fu portato in cielo dagli angeli, e dice ch’el sta al paro di Dio”. Il nostro capitano gli disse: “E Iesù Cristo figliuolo di Maria dove sta?” Rispose il sacerdote: “Alli piedi di Maumetto”. Il capitano gli disse: “Basta, basta, non voglio saper più”. Poi se ne venne fuori e disse a noi altri: “Guardate dove io voleva gittare tremila seraffi”.
La sera dapoi, circa a 3 ore di notte, vennero infra la carovana dieci o dodici di quei vecchi della setta, perché la carovana era alloggiata appresso alla porta a due tratti di pietra, e questi cominciorono a cridare uno di qua e l’altro di là: “Dio fu, Dio sarà, e Maumetto messaggier di Dio resusciterà. O profeta, o Dio perdonami”. Il nostro capitano, sentendo questo rumore, e noi, subitamente corremmo con l’arme in mano, credendo che fussero gli Arabi che volessero robar la carovana. E dicendo a quelli: “Che cosa è questa? Che cridate?”, perché facevano sto rumore, come saria intra di noi cristiani quando un santo fa alcun miracolo, que’ vecchi risposero: “Non vedete voi lo splendore che esce fuora della sepoltura del profeta?” Disse il capitano: “Non veggo niente”, e dimandò a tutti gli altri se avevano veduto cosa alcuna: fugli risposto di no. Rispose un di que’ vecchi: “Sete voi schiavi, cioè Mammalucchi?” Disse il capitano: “Sì che siam schiavi”. Rispose il vecchio: “O signori, voi non potete vedere queste cose celesti, e perché voi non siate ancora ben confirmati nella fede nostra”. Rispose il capitano: “O stolti, io voleva dare tremila ducati. Per Dio, mai più non ve li do, cani figliuoli de cani”. Sappiate che questi splendori erano certi fuochi artificiati, che loro aveano fatto maliziosamente in cima di detta torre, per dar ad intendere a noi altri che fussero splendori e che uscissero della sepoltura di Maumetto: per la qual cosa il nostro capitano comandò che per niun modo alcun di noi non entrasse nella detta moschea, e vi affermo e dico per certo che non v’è né arca di ferro né di azzale, né calamita, né montagna nissuna appresso a quattro miglia.
Noi stemmo lì tre giorni per riposar li cammelli. Il popolo della detta città si governa della vettovaglia che viene dall’Arabia Felice e dal Cairo e dalla Etiopia per mare, perché de lì al mar Rosso sono quattro giornate di cammino.
14
Del viaggio per andar da Medina alla Mecca, e del mar della rena.
Già noi delle cose e vanità di Maumetto sazii, ci disponemmo di passar più oltra, e col nostro pilotto, il qual reggeva il nostro cammino con il bossolo e carta da navigar, secondo che sogliono far gli esperti pratichi con li suoi bussoli e carte nel corso del mar. E cominciammo a camminare per ostro, cioè mezzogiorno, e trovammo un pozzo bellissimo nel quale era gran quantità di acqua, il qual pozzo dicono li Mori che lo fece santo Marco evangelista per miracol di Dio, per necessità di acqua ch’è in que’ paesi: il qual pozzo rimase secco alla partita nostra.
Non vorrei mandar in oblivione il trovar del mar dell’arena, qual lassammo davanti che trovammo la montagna de’ giudei, pel qual camminammo cinque giorni e cinque notti. Or intenderete in che modo sta questo. Questa è una campagna grandissima piana, la quale è piena d’arena bianca minuta come farina, dove, se per mala ventura venisse il vento da mezzogiorno, come viene da tramontana, tutti sariamo morti; e con tutto che noi avevamo il vento a nostro modo, l’uno con l’altro non se vedevamo di lungi 10 passi. E gli uomini che vanno a cavallo sopra li cammelli sono serrati in certe casse di legno, e per certi busetti piccoli ricevon l’aere, e ivi dormono e mangiano; e li pilotti vanno innanzi con bussolo, sì come andassero per terribil mare. E qui morirono gran gente per la sete, e gran parte ne morì perché, quando cavammo l’acqua, beverono tanto che creporono. E qui si fa la mumia. E quando tira il vento di tramontana, questa arena si coaduna ad un lato d’un gran monte, il qual è un brazzo del monte Sinai: al qual come arrivammo, trovammo una colonna fatta con gentil arte e a forza di mano, la qual chiamano porta; a man manca sopra il detto monte è una grotta molto lunga, nella quale è una porta di ferro. Dicono alcuni che Maumetto se retirava ivi a far orazione, e a questa porta si sente un grandissimo rumore come di acqua che caschi. Indi passammo la detta montagna con grandissimo pericolo, a tale che non pensavamo mai di arrivare in questo luoco.
Poi che ci partimmo dal pozzo detto di sopra, camminammo per dieci giornate, e due volte combattemmo con cinquantamila Arabi, tanto che giungemmo alla Mecca. E lì era grandissima guerra fra l’un fratello e l’altro, perché sono quattro che combattevano di continuo per esser signori della Mecca.
15
Della Mecca, e perché li Mori vanno alla Mecca.
Oramai diremo della nobilissima città detta Mecca, che cosa è e come sta e chi la governa. La città è bellissima e molto bene abitata, e fa cerca seimila fuochi; le case sono bonissime come le nostre, e vi sono case che vagliono 3 e 4 mila ducati l’una: la qual città non ha mura intorno. Appresso a un quarto di miglio alla città trovammo una montagna, nella quale era una strada tagliata per forza di mano, che dura fino al smontar nel piano: le mura di detta città sono le montagne che l’ha d’intorno da ogni canto, e vi son se non 4 entrate. Il governatore di questa città è soldano, cioè uno delli 4 fratelli, ed è della stirpe di Maumetto e sottoposto al gran soldano del Cairo, e li suoi tre fratelli combattono di continuo con lui.
Alli 18 di maggio entrammo nella detta città della Mecca dalla parte verso tramontana, e poi descendemmo giuso nel piano. Dalla parte verso mezzogiorno sono due montagne che quasi si toccano, dov’è il passo ben stretto per andare al porto della Mecca; dall’altra banda dove leva il sole è un’altra bocca di montagna a modo di una vallata, per la qual si va al monte dove fanno il sacrificio alli due patriarchi Abraham e Isaac. Il qual monte è lontano da detta città cerca 8 o 10 miglia, ed è alto duoi e tre tiri di pietra di mano, ed è d’un certo sasso non di marmo, ma d’un altro colore; e in cima è una moschea a usanza loro, la qual ha tre porte. A’ piedi del detto monte sono due bellissime conserve d’acqua: una è della carovana del Cairo e l’altra della carovana di Damasco; la qual acqua si raccoglie parte per la pioggia, e parte viene di molto lontano.
Or torniamo alla città; quando sarà tempo diremo del sacrificio che fanno a’ piedi del detto monte. Allora che noi entrammo in detta città, trovammo la carovana del Cairo, la qual era venuta 8 giorni prima di noi, perché non vengono per la via che venimmo noi: e in detta carovana erano sessantaquattromila cammelli e cento Mammalucchi. E la prima cosa che avete da saper di questa città è quello che ognun dice, che l’ha avuta la maladizione da Dio, perch’el paese non produce né erbe né arbori né frutti né cosa alcuna, e hanno grandissima carestia d’acqua, in modo che, se uno volesse bere a sua volontà, non li basteria quattro quattrini d’acqua al giorno. Io dirò in che modo vivono: una gran parte del viver suo gli viene dal Cairo, cioè dal mar Rosso, e vi è un porto chiamato il Ziden, che è lontano dalla detta città 40 miglia; gli viene ancora una grandissima quantità di vettovaglia dell’Arabia Felice, e anco gran parte ne gli viene dall’Etiopia. Noi trovammo grandissima quantità di pellegrini, de’ quali alcuni venivan dall’Etiopia, chi dall’India maggiore, chi dalla minore e chi dalla Persia e dalla Soria: veramente non viddi mai in una terra tanto popolo, per 20 giorni ch’io stetti lì. Delle qual genti parte ne erano venute per mercanzie, parte per guadagnar l’indulgenzie e compir i suoi voti, nel che voi intenderete quel che fanno.
16
Delle mercanzie che vengono alla città della Mecca
Primo diremo della mercanzia, che vien da più parti: dall’India maggiore, la qual è posta di qua e di là dal fiume Ganges, vengono assai gioie e perle e d’ogni sorte di speziarie; e ancora vengono dall’India minore, da una città chiamata Banghalla, grandissima quantità di panni di bambagio e di seta; e anche dall’Etiopia certa sorte di speziarie; per modo che in questa città si fanno grandissimi traffichi di mercanzia, cioè di gioie, spezie d’ogni sorte in quantità, bombagio in gran copia, sete e cose odorifere in grandissima abbondanzia.
17
Della perdonanza della Mecca.
Or torniamo alla perdonanza de’ detti pellegrini. In mezzo della città è un bellissimo tempio a comparazion del Coliseo di Roma, non di quelle pietre grandi, ma di pietre cotte: ed è tondo a quel modo, e ha novanta over cento porte intorno, ed è in volto. All’entrar del detto tempio si descende per dieci over dodici scalini per tutte le parti, e di qua e di là di detta entrata stanno uomini che vendono gioie e non altra cosa; e quando l’uomo è disceso detti scalini, trova il detto tempio intorno coperto e ogni cosa messo a oro, cioè le mura. E sotto alle dette volte stanno quattro o cinquemila persone, le quali vendono tutte cose odorifere, e la maggior parte sono polvere per conservar li corpi umani quando si sotterrano, perché de lì vanno per tutte le terre de’ pagani: veramente non si potria dir la suavità e gli odori che si sentono in quel tempio, che par essere in una speziaria piena di muschio e benzuì e d’altri odori suavissimi.
Alli 23 di maggio cominciò il perdono in detto tempio, il qual è in questo modo: che nel mezzo del detto tempio vi è un discoperto, in mezzo di quello una torre la cui grandezza è di 5 over 6 passi per ogni verso, la qual torre tiene un panno di seta intorno di altezza di 4 brazza, ed evvi una porta tutta d’argento di altezza d’un uomo, per la qual s’entra in detta torre. E da ciascuna parte dentro della porta stanno alcuni vasi, quali dicono esser pieni di balsamo, che si mostrano solamente il giorno della Pentecoste: e dicono gli abitanti quel balsamo esser parte del tesoro del soldano della Mecca. Ad ogni quadro di detta torre sono certe reti di ferro rotonde, con li busi molto minuti per entrarvi dentro il lume. Alli 23 di maggio tutto il popolo comincia, la mattina innanzi giorno, andar sette volte intorno alla detta torre, sempre toccando e baciando ogni cantone . Lontano dalla detta torre cerca 10 o 12 passi è un’altra torre, a modo di una cappella delle nostre, con 3 o 4 porte. In mezzo di questa torre è un bellissimo pozzo, il quale è cupo 70 braccia e tiene acqua salmastra: al detto pozzo stanno 6 overo 8 uomini deputati a trar acqua per il popolo, el qual, quando è andato sette volte intorno alla prima torre, vanno a questo pozzo e s’accostano all’orlo di quello con la schena, dicendo queste parole: “E tutto questo sia per onor di Dio, el piatoso Dio mi perdoni i miei peccati”. Le qual compite, quelli che tirano l’acqua gettano a ciascuna persona 3 secchi d’acqua dalla cima del capo per fino alli piedi, e tutti si bagnano, se ben la vesta fusse di seta: e pensono quelli matti in questo modo di restar limpidi e netti, e che li loro peccati rimanghino tutti in quel pozzo con quel lavare; e dicono che la prima torre dove vanno intorno sette volte è la prima casa che edificasse Abraham, e così bagnati tutti se ne vanno per la valle al detto monte, e lì stanno duoi giorni e una notte. E quando sono tutti a’ piedi del detto monte, ivi fanno questo sacrificio.
18
Del modo de’ sacrificii della Mecca.
Perché la novità delle cose suole il più delle volte dilettare ogni animo generoso e alle cose grandi incitarlo, però, per sodisfare a molti del medesimo animo, soggiugnerò brievemente il modo che si osserva ne’ loro sacrificii, il quale è questo, che ogni uomo ammazza al manco duoi o 3, e chi 4 e chi 6 castrati, per modo ch’io credo ben che ‘l primo giorno si ammazzarono più di 30 mila castrati, scannandoli verso dove leva il sole. E ciascun li dava per amor di Dio a’ poveri, perché v’erano forse 30 e 40 mila poveri, li quali facevano una fossa in terra, poi li mettevano dentro sterco di cammello e così facevano un poco di fuoco, e rostivan alquanto quella carne e poi la mangiavano. E veramente credo che quelli tanti poveri uomini venivano più tosto per la fame che per il perdono o indulgenzia; e che sia il vero, noi avevamo gran quantità di cocomeri, che venivano dall’Arabia Felice, e li mangiavamo levandoli via prima la scorza, la qual gittavamo fuori del nostro padiglione, come si suol fare: e li detti poveri stavano a 40 e 50 dinanzi al detto padiglione, e facevano gran questione tra loro per raccogliere le dette scorze da terra, ancor che fussino piene di sabbione. Per questo pareva a noi che venissero più tosto per mangiare che per lavarsi de’ loro peccati.
Il secondo giorno un cadì della fede, qual è al modo d’un predicador nostro, montò in cima del detto monte e fece un sermone a tutto il popolo, il qual sermone durò cerca un’ora. E la somma del suo parlare era questo, che pregava il popolo che buttando molte lacrime piangesse e’ suoi peccati, e ferendosi nel petto facesse penitenzia. E alzando molto la voce diceva: “O Abraham, benvoluto da Dio e amato da Dio”; poi diceva: “O Isaac, eletto da Dio, amico di Dio, prega Dio per il popolo del Nabi”. E così si sentivano di grandissimi pianti. E finito ch’ebbe il sermone, venne nova che venivan gli Arabi, per il che tutti quelli delle carovane, come fuori di sé, corsero in la Mecca con grandissima furia, perché appresso a 6 miglia già erano giunti più di ventimila Arabi, i quali volevano robare le carovane: e noi arrivammo a salvamento alla Mecca. Ma quando fummo alla metà del cammino, cioè fra la Mecca e il monte dove si fa il sacrificio, trovammo un certo muro o parete vecchio, piccolo, alto quattro braccia, a’ piedi del quale v’era grandissima quantità di pietre piccoline, le qual sono tirate da tutto il popolo per questo rispetto che intenderete.
Dicono che, quando Dio comandò ad Abraham che andasse a far il sacrificio del suo figliuolo, andò prima egli e disse al figliuolo che, obediendo alli comandamenti de Dio, lo dovesse seguire. Il figliuolo gli rispose: “Io son molto contento di far il comandamento di Dio”. E quando il fanciullo Isaac arrivò al sopradetto muro piccolo, dicono che ‘l diavolo gli apparve in forma d’un suo amico e gli disse: “Dove vai tu, amico mio Isaac?” Ed egli rispose: “Vo al padre mio, che m’aspetta al tal luoco”. E gli disse il diavolo: “Non andar, figliuolo mio, che tuo padre ti vuol sacrificare a Dio e ti vuol far morire”. E Isaac gli rispose: “Lascial fare: se così è la volontà di Dio, così si faccia”. Il diavolo allora disparve, e poco più avanti gli apparve in forma d’un altro suo caro amico, e gli disse le sopra dette parole. Dicono che Isaac gli rispose con furia, e pigliò una pietra e tirolla nel viso del diavolo: e per questo rispetto, quando arriva il popolo al detto luoco, ognuno tira una pietra al detto muro e poi se ne vanno alla città.
Noi trovammo per le strade di detta città ben quindeci o ventimila colombi, i quali dicono che sono della schiatta di quella colomba che parlava a Maumet in forma di Spirito Santo, i quali colombi volano per tutta la terra a suo piacere, cioè nelle botteghe dove si vende il grano, miglio, riso e altri legumi: e li padroni di detta roba non hanno libertà d’ammazzarli né di pigliarli, e se alcuno battesse di quelli colombi, si temeria che la terra rovinasse; e sappiate che li danno grandissima spesa in mezzo del tempio.
19
Delli unicorni che si trovano appresso il tempio della Mecca, animali rarissimi.
Dall’altra banda del detto tempio è una corte murata, nella qual vedemmo duoi unicorni: e li si mostrano per cosa maravigliosa, come nel vero è cosa da prenderne admirazione. E sono fatti in questo modo: il maggiore è fatto come un poledro di trenta mesi, e ha un corno nella fronte di lunghezza cerca tre braccia; l’altro unicorno era minore, come saria un poledro d’un anno, e ha un corno lungo circa quattro palmi. Il color del detto animale è come un cavallo sasinato scuro, e ha la testa come un cervo e il collo non molto lungo, con alcune crine rare e corte che pendono da una banda, e ha le gambe sottili e lunghe come il capriolo, e il suo piede è un poco fesso davanti e l’unghia è caprina, e ha molti peli di drieto delle gambe, li qual son tanti che fa parer questo animal molto feroce: ma la sua ferocità è coperta da una mansuetudine che in sé dimostra. Questi duoi animali furono presentati al soldano della Mecca come cosa de molto prezio e rara e che si trova in pochi luochi, e furono mandati da uno re di Etiopia, il qual li fece questo presente per far amicizia con lui.
20
Come l’auttore fu cognosciuto in la Mecca, e come venne con la carovana dell’India.
Mi occorre qui mostrare quel che possa l’umano ingegno ne’ casi occorrenti, quanto la necessità lo constringe: e ben fu a me necessario di mostrarlo per fuggir dalla carovana della Mecca. Essendo io a comprare alcune cose per il mio capitano, fui conosciuto da un Moro, il qual mi guardò nel viso e dissemi: “Donde sei tu?” Io li risposi: “Son moro”. Egli disse ch’io non diceva il vero. Io gli dissi: “Per la testa di Maumet, io vi giuro che son moro”. E risposemi: “Vieni a casa mia”, e io andai con lui. Quando fui in casa sua, egli mi parlò in lingua italiana e dissemi donde era, e ch’ei mi conosceva ch’io non era moro, ancor che glielo dicesse, e mi disse ch’egli era stato in Genova e in Venezia, e cognosceva molto la maniera di quelle genti, e davami li segni molto veri delle dette terre. Quando io intesi questo, io gli dissi ch’era romano e che mi era fatto mammalucco al Cairo: il che intendendo, egli fu molto contento e fecemi grandissimo onore. E perché la intenzione mia era di passar più avanti, gli cominciai a dire se questa era la città della Mecca, qual era tanto nominata per il mondo, e gli domandai dov’erano le gioie e le spezie, e dove erano tante sorti di mercanzie quante si dice che qui arrivano, sol perché lui mi avesse a dire per che causa non venivano come erano usate, e per non domandargli che ne fusse cagione il re di Portogallo, perché egli è signore del mar Oceano e del sino Persico e dell’Arabico. Ei mi cominciò a dire di passo in passo la cagione perché non venivano le dette robbe come erano usate di venire, non si accorgendo della mia malizia, e quando mi disse che n’era cagione il re di Portogallo, io mostrai di averne grandissimo dolore e diceva molto male del detto re, solo perché egli non pensasse ch’io fussi contento che li cristiani facessero tal viaggio. Quando costui vidde ch’io mi dimostrava nimico de’ cristiani, fece maggior onore assai che non faceva per avanti, e dissemi ogni cosa di punto in punto. E quando fui molto ben informato, gli dissi: “O amico mio, ti priego che tu mi dia il modo o via ch’io possa fuggire da questa carovana, perché la intenzion mia seria di andare a trovar quelli re che sono nimici de’ cristiani, perché ti aviso che, quando loro sapessero l’ingegno ch’io ho, mi mandariano a trovare fino alla Mecca”. E lui, stupefatto di queste parole, mi disse: “Per la fede del nostro profeta, che sapete voi fare?” Io li risposi ch’io era il miglior maestro di far bombarde grosse che fusse al mondo. Udendo egli questo, disse: “Maumetto sempre sia laudato, che ha mandato tal uomo al servigio de’ Mori di Dio”. Per modo ch’ei mi ascose nella casa sua con la sua donna, e mi pregò ch’io ottenesse dal nostro capitano della carovana che lo lasciasse trar fuora della Mecca quindeci cammelli carichi di spezie: e questo fece egli per non pagar trenta seraffi al soldano per la gabella. Io li risposi che s’ei mi salvava in casa sua, ch’io li faria levare cento cammelli, se tanti ne avesse, perché li Mammalucchi hanno la libertà: e quando ei sentì questo, fu molto contento. Dapoi mi ammaestrò del modo ch’io aveva a tenere, e de indrizzarmi ad uno re che sta nella parte dell’India maggiore, che si chiama re di Decan, del qual diremo quando sarà il tempo. Un giorno avanti che la carovana si partisse, mi fece ascondere in casa sua in loco secreto.
La mattina sequente andavano per la città grandissima quantità d’instrumenti sonando all’usanza loro, e i trombetti andavano faccendo il bando per tutta la città che tutti li Mammalucchi, sotto pena della vita, dovessero montar a cavallo e pigliar il suo viaggio verso la Soria. Donde gran perturbazione astringeva il cor mio, quando sentia mandar tal bando, e di continuo mi raccomandava alla moglie del detto mercante, piangendo e raccomandandomi a Dio, che mi campasse da tanta furia. Un martedì mattina si partì la detta carovana, e il mercante mi lasciò nella sua casa con la sua donna, ed egli se n’andò con la carovana; e disse alla donna ch’el venerdì sequente mi dovesse far accompagnare con la carovana dell’India che andava al Ziden, cioè al porto della Mecca, che vi sono miglia quaranta. La compagnia che mi fece la detta donna non si potria dire, e massime una sua nipote molto bella di quindeci anni, le quali mi promettevano, volendo io restare, di farmi ricco: e io, per il pericolo presente, posposi ogni sua promessa. Il venerdì sequente mi parti’ con la carovana al mezzogiorno, con non piccolo dispiacere e lamentazioni delle prefate donne, e a mezzanotte arrivammo ad una certa villetta di Arabi, e lì stemmo sino a mezzogiorno del dì sequente. Il sabbato si partimmo, e camminammo fino alla mezzanotte, e intrammo nella città del Ziden.
21
Del Ziden, porto della Mecca, e del mar Rosso.
Questa città non ha mura intorno né fossa, ma ha bellissime case all’usanza della Italia. Diremo di lei brevemente. Detta città è di grandissimo traffico, perché qui arriva una gran parte di tutte le nazioni del mondo, eccetto cristiani e giudei, che non vi ponno venir sotto pena della vita. Quand’io fui giunto nella detta città, subito me ne andai nella moschea, cioè al tempio, dove erano ben 25 mila poveri, che stavano aspettando qualche patron di nave che li levasse al suo paese. E io fra quelli mi mescolai, ascondendomi in uno cantone del detto tempio, e lì mi fermai per 14 giorni: tutto il dì stava gittato in terra coperto con li miei vestimenti, e di continuo mi lamentava, come s’io avessi avuto grandissima passion di stomaco o di corpo. Li mercadanti udendomi dicevan: “Chi è quello che si lamenta?” Dicevano li poveri che mi stavano a canto: “Egli è un povero Moro che si muore”. La sera al scuro usciva fuori della moschea e andava a comprar da mangiare: se io aveva appetito, lassolo giudicare a voi, perché non mangiava se non una volta al giorno, e ben male.
Questa città si governa per il signore del Cairo, e vi è signore uno fratello del soldano della Mecca, li quali sono sottoposti al gran soldano del Cairo. Qui non accade a dir molto, perché sono Mori. La terra non produce cosa alcuna, e ha grandissima carestia d’acqua dolce; il mare batte nelle mura delle case. Quivi si trovano tutte le cose necessarie per il viver umano, ma vengono condotte dal Cairo, dall’Arabia Felice e d’altri luoghi. Quivi è continuamente grandissima quantità di gente ammalata, per causa del mal aere che è in detta città, la qual puol aver da 500 case.
In capo di quattordici giorni mi accordai con un padrone d’una nave che andava alla volta della Persia, perché nel detto porto erano circa cento navi tra grandi e piccole. De lì a tre giorni facemmo vela e cominciammo a navigare per il mar Rosso.
22
Per che causa il mar Rosso non sia navigabile.
Si può comprendere (perché egli è così in effetto) che ‘l detto mar non è rosso, anzi quell’acqua è come quella dell’altro mare. Noi navigammo il giorno fina al tramontar del sole, perché non si può navigare in questo mare di notte, e ogni giorno si posano a questo modo, fino a tanto che giungono ad una isola chiamata Chamaran, e dalla detta isola in là si va sicuramente. La ragione che non si può navigare al tempo di notte è questa, perché vi sono molte isole e molti scogli e secche, ed è bisogno che sempre vada un uomo in cima dell’albero della nave per veder il cammino, il che la notte non si può fare: e però non si naviga se non di giorno.
II
1
Della città di Gezan e della fertilità sua.
Poi che discorso abbiamo li luochi, le città e costumi de’ popoli dell’Arabia Deserta, quanto fu a noi concesso di vedere, parmi esser conveniente che con brevità e più felicemente entriamo nell’Arabia Felice. In termine di sei giorni arrivammo ad una città chiamata Gezan, la quale ha un bellissimo porto, e lì trovammo quarantacinque navilii di più paesi. Questa città è posta alli lidi del mare, ed è sottoposta ad uno signor moro, ed è terra molto fruttifera e buona ad usanza de’ cristiani. Quivi sono buonissime uve e persichi, fichi, cocomeri, cetri, limoni e aranci, zucche grande, melenzane, agli, cepolle, in modo che è un paradiso. Gli abitatori di questa città vanno la maggior parte nudi, e vivono pure alla moresca. Quivi è abbondanzia di carne, grano, orzo e miglio bianco, il qual chiamano dora, e di quello si fa molto buon pane. Qui stemmo tre giorni, per fin che pigliammo la vettovaglia.
2
Di alcune genti chiamate Baduini.
Partendoci dalla detta città di Gezan, andammo cinque giorni sempre in vista di terra, la qual restava a man manca. E vedendo alcuna terra a canto alla marina, smontammo in terra 14 persone di noi, per dimandare alcuna cosa da mangiare con li nostri danari. La risposta che ci fecero fu che cominciorono a tirar pietre con le frombole contra di noi, e questi erano certe generazioni che si chiamano Baduini, i quali erano più di cento persone, e noi eravamo solo 14. E combattemmo con loro poco manco d’un’ora, per modo che ne rimasero di loro ventiquattro morti; gli altri si misero tutti in fuga, perché erano nudi e non aveano altre arme che queste frombole, e noi pigliammo tutto quel che potemmo, cioè galline, vitelli, buoi e altre cose da mangiare. De lì a due ore cominciò a multiplicare la turba di detta terra ferma, tanto che erano più di seicento, e a noi fu forza di ritirarsi al navilio nostro.
3
Della isola chiamata Chamaran e della bocca del mar Rosso.
In quel giorno medesimo pigliammo il nostro cammino verso una isola chiamata Chamaran, la qual mostra di circuito dieci o dodici miglia, dov’è una terra che mostra circa dugento fuochi ed è abitata da Mori. Nella detta isola si trova acqua dolce e carne, e fassi il più bel sale che mai viddi; ha un porto verso la terra ferma circa otto miglia. Questa isola è sottoposta al soldano dell’Arabia Felice. E lì stemmo duoi giorni, poi pigliammo il nostro cammino verso la bocca del mar Rosso, e vi sono due giornate, dove si può navigare sicuramente notte e giorno, perché dall’isola infino al Zidem non si può navigar di notte per le gran secche e scogli. E quando noi arrivammo alla detta bocca, parea veramente che noi fussimo in una casa serrata, perché quella bocca è larga cerca due o tre miglia. A man dritta di detta bocca è terra alta cerca 20 passi, ed è disabitata e sterile, per quanto si può veder di lontano; e a man manca di detta bocca è una montagna altissima, ed è sasso. Al mezzo di detta bocca v’è una certa isoletta disabitata che si chiama Bebel Mendel, e chi vuol andare a Zeila piglia il cammino a man diritta, e chi vuole andar in Aden lo piglia a man manca: e così facemmo noi per andar in Aden, e sempre andammo in vista di terra, e dal detto Bebel Mendel arrivammo alla città di Aden in poco manco di due giorni e mezzo.
4
Del sito della città di Aden e d’alcuni costumi verso li mercanti; e come l’auttor fu messo in prigione e menato al soldano di Rhada, città dell’Arabia Felice; e dell’esercito che ‘l prefato soldan fece, e armature loro, per andar contro un altro soldano.
Aden è una città la più forte che mai abbia visto in terra piana, e ha le mura da due bande, e dall’altre bande sono le montagne grandissime, sopra le quali sono cinque castelli; e la terra è nel piano di questi monti, e fa circa cinque o seimila fuochi. A due ore di notte qui si fa il mercato, per rispetto dell’estremo caldo che fa il giorno nella città. Appresso la quale ad un tirar di pietra è una montagna, sopra la quale è uno castello; e a piè di questa montagna, che vi batte il mare, surgono li navilii. Questa città è la principal e bellissima e la meglio fabbricata de tutte le città dell’Arabia Felice. Qui fanno capo tutti li navilii che vengono dall’India maggiore e dalla minore, e dalla Etiopia e dalla Persia, per li gran traffichi che vi sono. Tutti li navilii che hanno ad andare alla Mecca vengono a pigliar porto qui, e così presto che arriva una nave in porto, vengono gli officiali del soldano della dogana di detta città, e vogliono saper donde vengono e che portano, e quanto tempo è che si partirono dalle lor terre, e quante persone vanno per ciascuna nave. E poi che hanno inteso ogni cosa, per l’ordine del regno, levano alle dette navi gli arbori e le vele, li timoni e l’ancore, e ogni cosa portano dentro della città: e questo fanno accioché dette persone non si possino partire senza pagar la gabella al soldano.
Il secondo giorno ch’io arrivai alla detta città, fui preso e messo in ferri, e questo fu per cagione d’un ghiotto mio compagno, il qual mi disse: “Can cristiano, figliuolo di cane”. Certi Mori intesero questo parlare, e per questo rispetto fussimo menati in palazzo dal vice soldano, e subito fecero consiglio se subito ne doveano far morire, perché il soldano non era nella città. Dicevano che noi eravamo spie de’ cristiani, e perché il soldano di questa terra non fece mai morire alcuno, costoro ebbero rispetto, donde ne tennero ben sessantacinque giorni con diciotto libbre di ferro alli piedi. Il terzo giorno che noi fummo presi, corsero al palazzo ben quaranta o sessanta persone de Mori, li quali erano di due o di tre navilii quali avevano presi li Portoghesi; e questi tali erano scampati per nodare, e dicevano che noi eravamo di quelli di Portogallo e venuti lì per spie. Per questo corsero al palazzo con grandissima furia, con l’arme in mano per ammazzarne: e Dio ne fece grazia che quello che ne aveva in guardia serrò la porta dalla banda di dentro. A questo rumore sì levò la terra in arme, e chi voleva che morissemo e chi no: alla fine il vice soldano ottenne che noi campassimo.
In termine di 65 giorni il soldano mandò per noi, e fummo portati tutti duoi sopra un camello, pure co’ detti ferri ai piedi, e stemmo giorni otto pel cammino. Poi fummo presentati al soldano in una città la qual si chiama Rhada, e quando noi giugnemmo alla detta città, il soldano faceva la mostra con trentamila uomini, perché voleva andar a combattere con un altro soldano d’una città chiamata Sana, lontana da Rhada tre giornate; ed è questa città parte in costa de un monte e parte descende in piano, ed è bellissima e antica, populata e ricca. Appresentati che fummo innanzi al soldano, egli mi dimandò di che parte io era e quel che andava faccendo. Li risposi ch’io era romano e che era fatto mammalucco al Cairo, e ch’io era stato a Medina, dove el Nabi, cioè il gran profeta, è sepulto, e poi alla Mecca; e poi era venuto a veder sua signoria, perché per tutta la Soria e in la Mecca si diceva ch’egli era un santo, e se gli era santo (com’io credeva), che ben dovea sapere ch’io non era spia de’ cristiani, e ch’io era buon Moro e suo schiavo. Disse allora il soldano: “Di’: “La ilache ill’allach Muchemmedun resul’allach””, cioè: “non è Dio se non Iddio; Macometto è messaggiere de Dio”, che sono le parole che chi le dice se intende esser fatto moro. E io non le potei mai dire, o che fusse la volontà di Dio, o veramente per la gran paura ch’io aveva. Veduto il soldano ch’io non poteva dire dette parole, subito comandò ch’io fussi posto in prigione nel palazzo suo, con grandissima custodia di uomini di 18 castelli, quali venivan quattro per castello, e stavano quattro giorni, poi si mutavano quattro altri di detti castelli; e così seguitando mi guardorono tre mesi, che non viddi aere, con un pane di miglio la mattina e uno la sera: e sei di que’ pani non mi ariano bastati un giorno, e alcuna volta, se io avessi avuto acqua a bastanza, saria stato assai contento.
Il soldano se n’andò in campo de lì a duoi giorni alla detta città di Sana con lo esercito sopradetto, nel quale v’erano quattromila cavalieri figliuoli de cristiani, negri come Mori, ed erano di quelli del Prete Ianni, li quali sono comprati da piccolini di otto o nove anni, e fannoli esercitare nell’arme: e questi erano la guardia sua, e valevano più questi che non faceva tutto il resto delli ottantamila. Gli altri erano tutti nudi, con un mezzo lenzuolo in cambio d’un mantello adosso. E quando entrano nella battaglia, usano certe rotelle, le quali sono due pelli di vacca overo di bue incollate insieme, e in mezzo di dette rotelle sono quattro bacchette che le tengono diritte: le dette rotelle sono dipinte, in modo che chi le vede giudica esser le più belle e le migliori che far si possino; la grandezza loro è come un fondo di botta, e lo manico è una tavoletta con due chiodi. Ancora portano un dardo in mano e una spada curta e larga, con una vesta indosso di tela rossa overo d’altro colore, piena di bambagio, che li defende dal caldo e da’ nimici: questo usano quando vanno a combattere. Portano tutti generalmente una frombola per tirar pietre involta intorno alla testa, e sotto la detta frombola portano un legnetto lungo un palmo, col qual si nettano i denti; e generalmente, da quaranta o cinquanta anni in giù, portano due corna fatte dei loro proprii capelli, che paiono capretti. Il detto soldano ancora mena nel suo esercito cinquemila camelli, carichi di padiglioni tutti di bambagio, che avevan similmente le corde di bambagio.
5
Della regina moglie del soldano, che fieramente s’innamorò dell’auttore; e come il prefato finse di esser pazzo, e de molte cose che gl’intervenne.
Nel detto palazzo vi era una delle tre mogli del soldano, la qual chiamavan regina, e stava con dodici over tredeci damigelle bellissime, il color delle quali era più tosto negro che altramente. Detta regina ne fece un buon servigio, che ne allargò la prigione e dette licenzia che potessemo andar fuori con le guardie e ferri alli piedi. Essendo io e il mio compagno e un Moro tutti tre prigioni così in libertà, facemmo deliberazione che uno di noi si facesse matto, per poter sovenir meglio l’uno all’altro: all’ultimo toccò a me di esser pazzo. Avendo adunque pigliato tal impresa, era necessario ch’io facessi quelle cose che si richieggono a’ pazzi. Veramente, li primi tre giorni ch’io finsi il pazzo, mai non mi trovai tanto stracco né tanto affaticato come allora, perché di continuo avea cinquanta o sessanta mammoli drieto, che mi traevano de’ sassi e mi lapidavano, e io lapidava loro, li qual mi gridavan drieto: “Pazzo, pazzo”, e io di continuo aveva la camicia piena di sassi, e faceva come fanno i pazzi.
La regina di continuo stava alla finestra con le sue damigelle, e dalla mattina alla sera stava per vedermi e parlar meco; ed essendo da più uomini sbeffeggiato, acciò che più vera paresse la mia pazzia, cavatami la camicia andava così nudo avanti alla regina, la quale avea grandissimo piacere quando mi vedeva e non voleva ch’io mi partissi da lei, e davami di buoni e perfetti cibi da mangiare, in modo ch’io trionfava. Ancora mi diceva, come vedeva che li fanciulli mi correvan drieto: “Dagli a quelle bestie, che se tu gli ammazzi sarà suo danno”. Andava per la corte del soldano uno castrato, che la coda sua pesava quaranta libbre; io il prese e dimandavagli s’egli era moro o cristiano over giudeo, e replicandoli queste parole e altre, gli diceva poi: “Fatte moro e di’: “la illache ill’allach Muchemmedun resul’allach””. Ed egli stando come animale paziente, che non sapeva parlare, pigliai un bastone e gli ruppi tutte quattro le gambe, e la regina stava a ridere; e dapoi mi dettono tre giorni a mangiare di quella carne, della quale non so se mai mangiassi la migliore. De lì a tre giorni gli ammazzai un asino il quale portava l’acqua al palazzo, in quel medesimo modo ch’io feci del castrato, perché non se voleva far moro; il simile ancora faccendo con un giudeo, lo assettai in modo che per morto il lasciai.
Ma un giorno, volendo fare come soleva, trovai uno di quelli che mi guardavano ch’era molto più pazzo di me, e dicevami: “Can cristiano, figliuolo di can”. Io li tirai di molti sassi, ed ei si cominciò a voltare verso di me con tutti li mammoli, e dettemi d’un sasso nel petto, che mi fece un mal servigio. E per non poterlo seguitare per li ferri ch’aveva alli piedi, pigliai la via della prigione; ma prima ch’io vi giugnessi, ei mi dette un’altra sassata ne fianchi, la qual molto più mi dolse che la prima. E s’io avessi voluto, ben poteva schifarle tutte dua, ma per voler dar colore alla mia pazzia le volsi ricevere. E così entrai nella prigione subito, e con grandissime pietre mi murai dentro, dove gli stetti duoi giorni e due notte senza mangiare e senza bere, in modo che la regina e gli altri dubitavano ch’io non morissi, e fecero romper la porta. E quelli cani mi portavano certi pezzi di marmo, dicendo: “Mangia, che questo è zuccaro”; e alcuni altri mi davano certi granelli d’uva pieni di terra, e dicevano ch’era sale: e io mangiava il marmo e l’uva e ogni cosa insieme.
Quel giorno medesimo alcuni mercanti fecero venir duoi uomini, i quali erano tenuti fra loro come sariano fra noi duoi eremiti e stavano in certe montagne, alli quali fui mostrato, e li mercanti dimandavano se loro pareva ch’io fussi santo o matto. Uno di loro diceva: “A me pare che ‘l sia santo”, e l’altro diceva che gli pareva ch’io fussi pazzo. E stando così in questa disputa più d’un’ora, io per levarmegli davanti alzai la camicia e pisciai adosso a tutti duoi. Allora cominciorono a fuggire cridando: “Egli è matto, egli è matto e non è santo”. La regina stava alla sua finestra con le sue damigelle, e vedendo questo tutte cominciorono a ridere, dicendo: “Per il gran Dio, per la testa di Maumet, costui è il miglior uomo del mondo”. La mattina sequente me ne venni nella corte e trovai colui che mi dette le due sassate a dormire, e piglialo per le corna che gli avea fatto di suoi capelli, e gli messi li ginocchi sopra la bocca dello stomaco, e dettigli tanti pugni sul mostaccio che tutto pioveva sangue, in modo che lo lasciai per morto. La regina pur stava alla finestra, dicendo: “Ammazza, ammazza quella bestia”, qual subito si partitte, né mai più lo viddi.
Trovando il governatore di questa città per molti indicii che li miei compagni con perfidia volevano fuggire, e che aveano fatto un buso nella prigione e s’aveano cavati li ferri, e io non, e perché sapeva la regina pigliarsi gran piacere di me, non mi volse far dispiacere se prima non parlava con lei: la quale, inteso ch’ebbe ogni cosa, mi giudicò infra sé esser savio e mandò per me, e fecemi mettere in una stanzia a basso pur nel palazzo, la qual stanzia non avea porta da uscir fuori da basso, e tuttavia con li ferri ai piedi.
6
Delli ragionamenti che egli ebbe con la regina, e con quanto ingegno e astuzia si fece far libero e poi lassar andar in la città di Aden.
La notte sequente la regina mi venne a trovare con cinque o sei damigelle e cominciò a disaminarmi, e io pian piano li cominciai a dar ad intendere ch’io non era pazzo. Ed ella, prudente, conoscette chiaramente che io era savio, e così cominciò a carezzarmi con mandarmi un buon letto alla loro usanza e molto ben da mangiare. Il dì seguente mi fece far un bagno pur all’usanza loro con molti profumi, continuando queste carezze per dodici giorni; cominciò poi a descendere a visitarmi ogni sera a tre o quattro ore di notte, e sempre mi portava di buone cose da mangiare, ed entrando dove io era mi chiamava: “Lodovico, vien qua, hai tu fame?” E io le rispondeva: “Sì, per la fame ch’ha da venire”, e mi levava in piedi e andava a lei in camicia. E lei diceva: “Non così, levati la camicia”. Io le respondeva: “O signora, io non son pazzo adesso”, ed essa replicava: “Per Dio, so ben che tu non fusti mai pazzo, anzi sei il più avisato uomo che mai vedessi”. E io per contentarla mi levava la camicia e ponevomela davanti per onestà, e così mi teniva due ore davanti a lei standomi a contemplare, come s’io fussi stato una ninfa, e faceva una lamentazione inverso Dio in questo modo: “O Dio, tu hai creato costui bianco come il sole, il mio marito tu l’hai creato negro, il mio figliuolo ancora negro e io negra. Dio volesse che questo uomo fusse mio marito, Dio volesse ch’io facesse un figliuolo com’è questo”. E dicendo tal parole piangeva continuamente e sospirava, maneggiando di continuo tutta la mia persona, e promettendomi che, subito che fusse venuto il soldano, mi faria cavar li ferri.
L’altra notte seguente la detta regina venne con due damigelle, e portommi molto ben da mangiare, e disse: “Vien qua, Lodovico, vuoi tu ch’io venga a star con te un pezzo?” Io le rispose che non, che ben bastava ch’io era in ferri, senza che mi facesse tagliare la testa. Ella disse allora: “Non aver paura, io ti fo la sigurtà sopra la mia testa. Se tu non vuoi che venga io, verrà Gazella over Tegia over Carcerana”. Questo diceva ella solo perché in scambio d’una di queste voleva venir essa e star con meco; e io non volsi mai consentire, perché io considerava molto bene quel che di questo ne poteva seguire. E vedendola tanto fuora di sentimento, e che la dimostrava publicamente la passion che l’avea di me, pensava che, poi ch’ella avesse avuto il suo contento, m’arebbe dato oro, argento, cavalli e schiavi e ciò che avessi voluto, e poi m’averia dato dieci schiavi negri, li quali sariano stati in mia guardia, che mai non arei potuto fuggir del paese, perché tutta l’Arabia Felice era avisata di me, cioè alli passi; e s’io fussi fuggito una volta, non mi mancava la morte o veramente li ferri in vita mia. E per questo rispetto mai non volsi consentire a lei, e ancora perché non voleva perder l’anima e il corpo; tutta la notte io piangeva, raccomandandomi a Dio.
De lì a tre giorni venne il soldano, e la regina subito mi mandò a dire che, s’io voleva star con lei, essa mi faria ricco. Io le risposi che una volta mi facesse levar li ferri, e satisfacesse alla promessa ch’ella avea fatta a Dio e a Maumetto; dipoi faria ciò che piacesse a sua signoria. Subito ella mi fece andar avanti il soldano, qual mi dimandò dove io voleva andare, poi ch’avesse cavato li ferri. Io li risposi: “O signore, io non ho né padre né madre né moglie né figliuoli né fratelli né sorelle: non ho se non Dio e il profeta e tu, signore. Piaccia a te di darmi da mangiare, che io voglio esser tuo schiavo in vita mia”; e di continuo lagrimava. E la regina sempre era presente, e disse al soldano: “Tu darai ancora conto a Dio di questo pover’uomo, il qual senza cagione tanto tempo hai tenuto in ferri. Guardati dalla ira di Dio”. Disse il soldano: “Orsù, va’ dove tu vuoi, io ti dono la libertà”, e subito mi fece cavar li ferri. E io mi inginocchiai e gli baciai li piedi, e alla regina baciai la mano, la qual mi prese pur ancora per la mano, dicendo: “Vien meco, poveretto, perché so che mori di fame”. E come fui nella sua camera, mi baciò strettamente più di cento volte, e poi mi dette molto ben da mangiare; e io non aveva alcuna volontà di mangiare: la cagion era ch’io viddi la regina parlar al soldano in secreto, e pensava ch’ella m’avesse dimandato al soldano per suo schiavo. Per questo io gli dissi: “Mai non mangierò, se non mi promettete di darmi la libertà”. Ed ella rispose: “Taci, matto, tu non sai quello che ti ha ordinato Dio, cioè, se tu sarai uomo da bene, sarai signore”. Già io sapeva la signoria ch’ella mi voleva dare, ma io gli risposi che mi lassasse un poco ingrassare e ritornar il sangue, che, per le paure grandi ch’io aveva avuto, altro pensieri che di amore aveva nel petto. Ella rispose: “Per Dio, tu hai ragione, ma io ti farò dare ogni giorno ova fresche, galline, piccioni, pepe, cannella, garofani e noci moscate”. Allora mi rallegrai alquanto delle buone parole e promesse ch’ella mi ordinò, e per ristorarmi meglio stetti ben quindeci o venti giorni nel palazzo suo.
Un giorno ella mi chiamò e dissemi s’io voleva andar a caccia con lei; io le risposi de sì e andai seco. Alla tornata poi finsi di cascar ammalato per stracchezza, e stetti in questa fizione otto giorni, ed ella di continuo mi mandava a visitare per suoi secreti messi. E io un giorno le feci dire che avevo fatto voto a Dio e a Maumeto di andar a visitare un santo uomo che era in la città di Aden, il qual dicevan che facea miracoli per la santa vita che ‘l teneva, e io lo confirmava esser vero per far il fatto mio; ed ella mi mandò a dire ch’era molto contenta, e fecemi dar un camello e 25 serafi d’oro, del che io ne fui molto allegro. E il giorno sequente montai sopra il camello e me ne andai in Aden in spazio di otto giorni, dove subito trovai quel santo uomo, il quale era adorato per rispetto che di continuo viveva in povertà e castità, e faceva vita di eremita. E veramente assai ve ne sono in quel paese, che fanno pur questa santa vita, ma sono ingannati per non aver la fede e il battesimo. Fatto ch’io ebbi la mia orazione, il secondo giorno finsi d’esser liberato per la virtù di quel santo, e feci scriver alla regina come io era, per virtù di Dio e di quel santo uomo, risanato; e poi che Dio mi avea fatto tanta grazia, io voleva andar a veder tutto il suo reame: e questo io facea perché in questo luogo era l’armata, la qual non si potea partire fino ad un mese. E io secretamente parlai ad un capitano d’una nave, e dissigli ch’io voleva andare in India, e se lui mi voleva levare li faria un bel presente. Ei mi rispose che, prima che gli andasse in India, voleva toccare in la Persia, e io di questo mi contentai e così restammo.
7
Di Lagi, città dell’Arabia Felice, e di Aiaz e del mercato in Aiaz, e di Dante castello.
Il giorno seguente montai a cavallo e, cavalcato cerca quindeci miglia, trovai una città chiamata Lagi, la qual era in terra piana senza alcun monte appresso e molto ben populata. Qui nasce grandissima quantità di dattali, e ancora v’è carne assai e grano a usanza nostra; qui non è uva, e hanno gran carestia di legne. Questa città non è civile, e gli abitatori d’essa sono Arabi, li quali non sono molto ricchi.
De lì mi parti’ e andai ad un’altra città distante dalla predetta una giornata, e chiamasi Aiaz, la quale è posta fra duoi colli di una montagna, in mezzo li quali vi è una bellissima valle con una bella fontana; nella qual valle si fa il mercato, dove vengono gli uomini e donne dell’uno e l’altro monte, e pochi sono quelli giorni del mercato che non vi si faccia questione. La causa è questa, che quelli che abitano il monte verso tramontana vogliono che coloro che abitano il monte verso mezzogiorno credano insieme con loro in Maumeto con tutti li suoi compagni, e loro non vogliono credere se non in Maumeto e Aly, e dicono che gli altri suoi compagni sono falsi, e per questo s’ammazzano come cani. Torniamo al mercato, al qual vengono molte sorti di spezie minute e molti odori, e gran quantità di panni di bombagio e di seta, e frutti eccellentissimi, come sono persichi, pomi granati e pomi cotogni, fichi, noci e uva buona. È da sapere che in ciascuno di questi monti è una fortissima rocca.
Viste queste cose, di qui mi parti’ e andai ad un’altra città distante da questa due giornate, chiamata Dante, la qual è fortissima e situata in cima d’una grandissima montagna, ed è abitata pur da Arabi, i quali sono poveri per esser il paese molto sterile.
8
Di Almacharana, città dell’Arabia Felice, e della sua abbondanzia.
Per seguir i nostri già nell’animo conceputi desiderii cerca la novità delle cose, di là ci partimmo pigliando il viaggio ad un’altra città, due giornate lontana, la qual si chiama Almachara ed è in cima d’una montagna che dura di salita sette miglia, alla qual non possono andare se non due persone per volta, per esser la strada molto stretta. E la città è piana, in cima del monte, ed è bellissima e buona, e qui si raccoglie da mangiare a sofficienzia per gli abitatori della città: e per questo mi pare la più forte città del mondo. Ivi non è bisogno di acqua né di cosa altra alcuna da vivere, e sopra tutto v’è una cisterna che daria acqua a centomila persone. Il soldano tien tutto il suo tesoro in questa città, qual è tanto che non lo portarian cento camelli, perché qui è la sua origine e di qui discese; e vi tiene continuamente una delle sue mogli. E veramente questo è un frutifero luoco, e vi vengono tutte le cose che si possino desiderare, e tiene il più bello aere che terra del mondo. Quivi le genti sono più bianche che d’altro colore.
9
Di Reame, città dell’Arabia Felice, e dell’aere e costumi del suo popolo.
Poi ch’ebbi discorso la prefata città, da essa partendomi andai ad un’altra terra, lontana da quella una giornata, la qual si chiama Reame ed è abitata la maggior parte da gente negra, e sono grandissimi mercatanti, ed è paese fertilissimo fuor che di legne. Questa città fa cerca duoimila fuochi. Da un lato di questa città è un monte, sopra il quale è un fortissimo castello. E quivi è una sorte de castrati, de’ quali ho veduto che la coda sola pesa quarantaquattro libbre, e non hanno corna, e per la loro grassezza non possono camminare. Vi è ancora certa uva bianca che dentro non ha granelli, della quale mai non gustai la migliore, e trovai tutte le sorti de frutti, come dissi disopra. Evvi così perfettissimo e singularissimo aere in questo paese, che parlai con molte persone le quali passavano cento e venticinque anni, e ancora erano molto prosperose. L’abito di costoro è che gli uomini da conto portano una camicia, gli altri di bassa condizione portano mezzo un lenzuolo ad armacollo all’apostolica; pur la maggior parte vanno nudi. Per tutta questa Arabia Felice gli uomini portano le corna fatte delli loro capelli medesimi, e le donne portano le calze a braga ad usanza de’ marinari.
10
Di Sana, città dell’Arabia Felice, e della fortezza e crudeltà del figliuolo del re.
Dapoi mi parti’ e andai ad una città chiamata Sana, la quale è lontana tre giornate dalla detta città di Reame, ed è posta in cima d’una grandissima montagna, ed è fortissima: alla quale stette il soldano con ottantamila uomini otto mesi per prenderla, né mai la poté pigliare se non a patti. Le mura di questa città sono di altezza dieci braccia e di larghezza braccia 20, di modo che otto cavalli vi vanno al paro sopra. In detto paese nascono molti frutti come nel paese nostro, e vi sono molte fontane. In questa Sana sta un soldano il quale ha dodeci figliuoli, de’ quali ve n’è uno che si chiama Maumet, il quale come rabbioso morde la gente e ammazzala, e poi mangia tanta della lor carne che si sazia; ed è di statura di quattro braccia e ben proporzionato, ed è di colore olivastro. In questa città si trova qualche sorte di spezie minute, le quali nascono lì d’intorno. E la detta città può fare cerca quattromila fuochi, e le case sono bellissime all’usanza nostra, ed è tanto grande che in quella vi sono molte vigne e prati e giardini a nostra usanza.
11
Di Taesa e di Zibit e Damar, città grandissime dell’Arabia Felice.
Poi ch’ebbi veduta Sana, mi posi in cammino e andai ad un’altra città chiamata Taesa, la qual è distante da Sana tre giornate ed è posta pur in montagna. Questa città è bellissima e abbondante d’ogni gentilezza, e sopra tutto di grandissima quantità d’acqua rosa, la qual qui si stilla. È fama che questa città sia antichissima, e vi è un tempio come Santa Maria Rotonda di Roma e molti altri palazzi antichissimi. Qui sono grandissimi mercanti. Vestono queste genti come le sopradette; il lor colore è olivastro.
Partendomi di lì andai ad un’altra città chiamata Zibit, distante da questa tre giornate, la qual è molto grande e bonissima, ed è appresso al mar Rosso mezza giornata e per tal rispetto è terra di grandissimo traffico, ed è dotata di grandissima quantità di zuccaro; ha frutti buonissimi. Ed è situata infra due montagne e non ha mura intorno; e quivi si fanno grandissimi mercati di spezie e odori d’ogni sorte, le quali si portano de lì ad altri paesi. L’abito e il colore degli abitanti in questa città è come li sopradetti.
Partitomi dal detto luoco, andai ad un’altra città una giornata lontana, la qual si chiama Damar, abitata pur da Mori, li quali sono grandissimi mercatanti. È la detta città molto fertile; il viver e costumi suoi sono come li sopradetti.
12
Del soldano di tutte le sopradette città, e perché si chiama per nome Sechamir.
Tutte queste città sopradette sono sottoposte al soldan delli Amanni, cioè al soldano dell’Arabia Felice, chiamato Sechamir, perché sech viene a dir “santo”, amir “signor”. La ragione perché lo chiamano santo è questa, ch’egli non fece mai morir persona alcuna, salvo se non fosse in guerra. Sappiate che nel tempo mio teneva quindeci o ventimila uomini in ferri, e a tutti dava duoi quattrini per uomo al giorno per le spese loro, e così li lassava morir in prigione quando meritavano la morte. E similmente teneva in la sua corte e a’ suoi servizii sedecimila schiavi fra uomini e femine, alli quali tutti dava il viver: e sono tutti negri.
13
Delli gatti maimoni e d’alcuni animali come lioni, agli uomini inimicissimi.
Di qui partendomi e andando verso la sopradetta città di Aden, avendo camminato poi per cinque giorni, alla metà del cammino trovai una terribile montagna, nella qual vedemmo più di diecimila fra simie e gatti maimoni, che andavan qua e là senza paura; fra li quali vi erano alcuni lioni molto terribili, i quali offendono molto gli uomini, quando possono: e per causa loro non si può passare per quella strada, se non sono almeno cento persone alla volta. Noi passammo con grandissimo pericolo e con non poca caccia di detti animali; pur ne amazzammo assai d’essi con gli archi e con le frombole e con li cani, per modo che noi passammo a salvamento. Arrivato ch’io fui in Aden, subito mi misi in la moschea fingendo d’esser ammalato, e ivi stavo tutto ‘l giorno; la notte poi andavo a trovar il padrone della nave, per modo ch’ei mi mise nella nave secretamente.
14
Come andorono per fortuna nel porto di Zeila, città della Etiopia.
Avendo noi deliberato di veder altri paesi, com’era il nostro disegno, ci ponemmo in mare; ma la instabil fortuna, ch’esercitar suole il mutabile arbitrio suo nell’acque similmente instabili, ne disviò alquanto dal proposito nostro, perché de lì a sei giorni pigliammo il cammino verso la Persia, e navigato ch’avemmo sette giorni, venne una fortuna grandissima che ci fece correr fino in Etiopia, insieme con tutte le navi di conserva, che eran cariche di rubbia per tinger panni, perché ogni anno se ne carica fin 25 navi in Aden, la qual rubbia nasce nell’Arabia Felice. Con grandissima fatica intrammo in un porto d’una città chiamata Zeila, e lì stemmo cinque giorni, per vederla e per aspettar il tempo a nostro proposito.
15
Di Zeila, città d’Etiopia, e dell’abbondanzia e animali di essa città.
La città di Zeila è di grandissimo traffico, massime d’oro e di denti d’elefanti; quivi anco si vende grandissima quantità di schiavi, i quali sono di quelli del Prete Ianni, che li Morì pigliano in guerra, e di qui si portano nella Persia, nell’Arabia Felice e alla Mecca e al Cairo e in India. In questa città si vive molto bene e fassi gran iustizia. Qui nasce molto grano e molta carne, olio in molta quantità, fatto non di olive ma di zerzilino, e di mele e cera in assai gran copia. Quivi si trova una sorte di castrati i quali hanno la coda che pesa venticinque o ventisei libbre, e hanno il collo e la testa tutta negra, il resto poi tutto bianco; vi sono ancora certi altri castrati tutti bianchi, che hanno la coda lunga un braccio e ritorta a modo di vite, e hanno la collarina come un toro, che quasi tocca terra. E in questo luoco trovai certa sorte di vacche che avevano le corna come un cervo, e sono salvatiche, le quali furono donate al soldano della detta città. Viddi poi altre vacche le quali avevano solo un corno nella fronte, di lunghezza d’un palmo e mezzo, e il detto corno guarda più verso la schiena della vacca che non guarda innanzi: il color di queste è rosso, e quelle di sopra sono negre. In questa città è un buon vivere, e qui stanno molti mercadanti. La terra ha triste mura e tristo porto, nondimeno è posta in terra piana e ferma. Il re di Zeila è moro e ha molta gente da piedi e a cavallo, e sono genti bellicose. L’abito suo è in camicia; il color loro sono olivastri. Questi tali vanno mal armati, e tutti sono maumettani.
16
Di Barbara, isola di Etiopia, e della sua gente.
Venuto che fu il tempo buono, facemmo vela e arrivammo ad una isola chiamata Barbara, il signore della quale con tutti gli abitanti suoi sono Mori. Questa isola è piccola, ma buona e molto ben abitata, e fa molte carni d’ogni sorte. Le persone sono la maggior parte negre, e le ricchezze loro sono quasi più di carne che d’altre cose. Qui stemmo un giorno, e poi facemmo vela e andammo alla volta della Persia.
Persia
1
Di Diuoban del Rumi, e di Goa e Giulfar, e di Meschet, porto della Persia.
Navigando noi cerca dodici giorni, arrivammo ad una città chiamata Diuoban del Rumi, cioè porto santo delli Turchi, la qual città è poco distante da terra ferma: quando il mar cresce è isola, e quando cala si passa a piedi. Questa città è sottoposta al soldano di Cambaia, e sta per capitano in esso Diuoban uno che si chiama Menacheaz. Qui stemmo duoi giorni. È città di grandissimo traffico, e in essa stanno di continuo quattrocento mercadanti turchi. E questa città è murata intorno, e dentro vi sono molte artegliarie; hanno certi navilii chiamati talac, che sono poco minori di fuste.
De lì si partimmo e arrivammo ad una città chiamata Goa, distante dalla predetta tre giornate, la qual Goa è terra di gran tratto e di gran mercanzie, ed è grassa e ricca; sono pur gli abitanti tutti maumettani. Partimmi e andai ad un’altra terra chiamata Giulfar, la qual è ottima e abbondante, e lì è buon porto di mare. Dal qual porto alzando le vele, con li proprii venti arrivammo ad un altro porto, chiamato Meschet.
2
De Ormus, città e isola di Persia, e come in quella si pescano perle grandissime.
Seguitando noi il nostro viaggio, partimmo da Meschet e andammo alla nobile città di Ormus, la quale è bellissima ed è isola e principale, cioè per terra di mare e per mercanzie, ed è distante da terra ferma dieci o dodici miglia. Nella detta isola non si trova né acqua né vettovaglia a sufficienza, ma tutto gli viene da terra ferma. Appresso di quest’isola tre giornate si pescano le più grosse perle che si ritrovano al mondo, e pescansi in questo modo: sono certi pescatori, con alcune barche piccole, li quali gittano un sasso grande con una corda grossa, una da poppa e un’altra da prova, acciò la detta barca stia ferma, e un’altra corda gettano al fondo pur con un sasso in mezzo della barca; e uno delli pescatori si pone un paro di bisazze al collo e ligasi una pietra grossa alli piedi, e va quindeci passa sotto acqua e sta sotto quanto può, per trovar le ostreghe dove stanno le perle, le quali ritrovate pone nelle bisazze, e poi lassa il sasso qual teneva ne’ piedi e vien suso per una delle dette corde. Si trovano alcuna volta trecento navilii di più paesi venuti per questo effetto. Il soldano di questa città è maumettano.
3
Del soldano di Ormus, e della crudeltà del figliuolo contra il soldano suo padre, sua madre e fratelli, quali ammazzò e poi fu morto egli.
In quel tempo ch’io andai in questo paese, intravenne questo che intenderete. Il soldano di Ormus aveva undeci figliuoli maschi: il minor di tutti era tenuto semplice, cioè mezzo pazzo; il maggior di questi era un diavolo scatenato. E il detto soldano avea allevati duoi schiavi figliuoli de cristiani, cioè di quelli del Prete Ianni, li quali aveva comprati da piccolini, e amavali proprio come figliuoli suoi, ed erano valentissimi a cavallo e signori di castella. Il figliuolo maggiore del soldano una notte cavò gli occhi al padre e alla madre e a tutti i fratelli, salvo al mezzo pazzo; dipoi li portò tutti in camera del padre e della madre, e pose fuoco in mezzo, e abbruciò la camera e i corpi con ciò che v’era. La mattina per tempo si seppe il caso e la terra si levò a rumore, ed egli si fortificò nel palazzo e fecesi soldano. Il minor fratello, il qual era tenuto pazzo, non si mostrò però tanto pazzo quanto era tenuto, imperoché sentendo il caso se ne fuggitte ad una moschea de Mori, dicendo: “O Dio, il mio fratello è un diavolo, ha ammazzato il mio padre, la madre e tutti i miei fratelli, e poi che gli ha ammazzati, gli ha tutti abbruciati”.
In termine di quindici giorni si pacificò la città, e questo che avea commessa tanta scelerità mandò per uno di quelli duoi schiavi sopradetti e dissegli: “Io son soldano”. Rispose il schiavo, qual si chiamava Maumet: “Sì, per Dio, che tu sei soldano”. Allora il soldano lo prese per la mano e fecelli gran festa, e dissegli: “Va’ e ammazza il tuo compagno, ch’io ti darò molti castelli”. Rispose Maumet: “O signore, io ho mangiato il pane col mio compagno trenta anni e praticato con lui: a me non basta l’animo di far tal scelerità”. Disse allora il soldano: “Orsù, lassa stare”. De lì a quattro giorni il detto soldano mandò per l’altro schiavo, il quale si chiamava Caim, e dissegli quelle medesime parole che avea detto al suo compagno, cioè che andasse ad ammazzar Maumet. Disse Caim alla prima: “Sì, al nome sia di Dio, signore”. E allora si armò secretamente e andò subito a trovar Maumet suo compagno. Come Maumet lo vidde, lo mirò fisso nel viso e dissegli: “O traditore, tu non lo puoi negar, ch’io ti conosco nel viso: aspetta, ch’io voglio prima ammazzar te che tu ammazzi me”. Caim, che si vidde esser scoperto e conosciuto, trasse fuori il pugnale e gittollo a’ piedi di Maumet, e inginocchiatosegli avanti diceva: “O signor mio, perdonami, ancor ch’io meriti la morte: se ti pare, piglia questa arma e ammazzami, perché io veniva per ammazzarti”. Rispose Maumet: “Ben si può dire che sei traditore, essendo stato meco e praticato e mangiato il pane trenta anni, e volermi poi alla fine tanto vilmente ammazzare. Poverino, non vedi che costui è un diavolo? Levati suso, ch’io ti perdono. Questo me ha stimulato (accioché tu intendi) ben tre giorni, acciò ch’io t’ammazzassi, e io non lo volsi mai consentire. Orsù, lascia fare a Dio, va’ pure e fa’ come ti dirò: vattene al soldano e digli che tu m’hai morto”. Rispose Caim: “Io son contento”, e incontinente andò al soldano. Come il soldano lo vidde, disse: “Ben ammazzasti l’amico”. Rispose Caim: “Sì, per Dio, signore”. Disse il soldano: “Vien qua”, ed egli s’accostò al soldano, il qual lo prese nel petto e ammazzollo a colpi di pugnalate.
De lì a tre giorni Maumetto si armò secretamente e andò alla camera del soldano, il quale come lo vidde si turbò e disse: “O can figliuolo di can, ancora vivi”. Rispose Maumet: “Al dispetto tuo son vivo, e voglio ammazzar te, che sei peggio che un cane o diavolo”. E a questo modo con l’arme in mano l’un l’altro combatterono insieme; all’ultimo Maumet ammazzò il soldano e poi si fortificò nel palazzo. E perché era molto benvoluto dalla città, il popolo corse tutto al palazzo, dicendo: “Viva viva Maumet soldano”; e stette soldano circa venti giorni. Passati venti giorni, mandò per tutti li signori e mercadanti della città e disse loro in questo modo, che quello ch’egli avea fatto era stato per forza, e ben sapeva egli che di ragione non era sua la signoria; e pregò tutto il popolo che volessero esser contenti che ‘l facesse re quel figliuolo ch’era tenuto pazzo: e così fu fatto re. Vero è che costui governava ogni cosa; tutta la città diceva: “Veramente costui deve esser amico di Dio”, per la qual cosa fu fatto governatore della città e del soldano, per esser il soldano della condizione sopradetta.
È da sapere che sono communemente quattrocento mercatanti forestieri, li quali fanno mercanzie di sete, perle, gioie e spezie. Il commun vivere di questa città è più in mangiar riso che pane, perché in quel luoco non nasce grano.
4
Della città di Eri nel paese del Corasam, qual si pensa che sia la Partia, e della sua ricchezza e copia di molte cose, e massimamente del reubarbaro.
Inteso il miserando caso, e visti i costumi della città e isola di Ormus, de lì partendomi passai nella Persia, e camminando per dodeci giornate trovai una città chiamata Eri, e il paese si chiama Corasam, come saria a dire la Romagna. In questa città di Eri abita il re di Corasam, dov’è gran fertilità e abbondanzia di robe e massime di seta, di modo che si troverà a comprar in un dì tre o quattromila camelli carichi di seta. La terra è abbondantissima di vettovaglia, e anco vi si trova grandissimo mercato di reubarbaro: io l’ho veduto comprare a sei libbre al ducato a usanza nostra, cioè onze dodeci per libbra. Questa città fa cerca sei o settemila fuochi; gli abitanti d’essa sono tutti maumettani. De qui mi parti’ e camminai venti giornate per terra ferma, trovando pur ville e castelli molto bene abitati.
5
Di Eufra fiumara, qual credesi esser l’Eufrate, e della città di Siras; e come si conosce il muschio; e come l’auttor si accompagnò con un Moro.
E così, seguendo el mio cammino, arrivai ad una grande fiumara, la quale da quelle genti è chiamata Eufra; ma per quanto posso considerare credo che sia Eufrate, e per la grandezza e larghezza della sua bocca. Camminando poi più oltra a man manca tre giornate, pur drieto alla fiumara, trovai una città chiamata Siras: e ha questa città il signore da per sé, il qual è persiano e maumettano. In questa città si trova gran quantità di gioie, cioè turchine e balassi infiniti: vero è che qui non nascono, ma vengono da una città chiamata Balasam. E in detta città si trova grandissima copia di azzurro oltramarino e tuzia e muschio assai. È da sapere che ‘l muschio nelle parti nostre raro si trova che non sia contrafatto; la ragion è ch’io ho veduto far la esperienza in questo modo, pigliare una mattina a digiuno una vescica di muschio e romperla, e tre o quattro uomini alla fila odorarlo, e subito fargli uscire il sangue dal naso: e questo procede perché è vero muschio e non falsificato. Dimandai quanto durava la bontà di quello: mi risposero alcuni mercadanti che, se non era falsificato, durava 10 anni. A questo considerai io che quello che viene alle nostre parti è falsificato per mano di questi Persiani, li quali sono li più astuti uomini d’ingegno e di falsificar una cosa che generazione che si trovi al mondo. E il simile dico di essi che sono li miglior compagni e li più liberali di tutti gli uomini del mondo: e questo perché l’ho provato con uno mercatante persiano, qual trovai in questa città di Siras (nondimeno egli era della città di Eri sopra detta, in Corasam), il qual mercatante li duoi anni avanti mi conobbe alla Mecca, e dissemi: “Lodovico, che vai faccendo qui? Non sei quello che era già passato alla Mecca?” Io dissi di sì, e il desiderio grande che avea di veder il mondo. Ei mi rispose: “Laudato sia Dio, che averò pur un compagno che verrà meco, che ho il medesimo volere”. Noi stemmo 15 giorni in detta città di Siras, e questo mercatante, qual si chiamava Cazazionor, disse: “Non ti partirai da me, che cercheremo una buona parte del mondo”. E così insieme ci mettemmo in cammino per andar alla volta di Sammarcante.
6
Di Sammarcante (come si dice), città grandissima come è il Cairo, nella provincia detta dagli antichi Battriana.
Sammarcante (dicono li mercatanti) è una città grossa com’è il Cairo, e il re della detta è maumettano, e fa sessantamila uomini da cavallo, e sono tutte genti bianche e bellicose. Noi non andammo più avanti, e la cagione fu perché ‘l Sofi andava per questo paese mettendo a fuoco e fiamma ogni cosa, e massime quelli che credono in Bubecher e Othman e Homar, che sono compagni di Maumet, tutti li mandava a fil di spada; ma quelli che credono in Maumeto e Haly li lassava andare e gli assecurava. Allora il compagno mi disse: “Vien qui, Lodovico, accioché tu sia certo ch’io ti voglio bene, e che tu conoschi con effetto che son per farti buona compagnia, io ti voglio dare una mia nipote per moglie, la qual si chiama Sanis, cioè Sole”: e veramente avea il nome conveniente a lei, perché era bellissima. E dissemi: “Sappi che io non vo per il mondo perché abbia bisogno di roba, anzi vo per mio piacere e per vedere e saper più cose”; e con questo ci mettemmo a cammino alla volta di Eri. Giunti che fummo alla casa di costui, subito mi mostrò la detta sua nipote, della quale finsi di esser molto contento, ancora che l’animo mio fusse ad altre cose intento. In termine di Otto giorni tornammo alla città di Ormus, e lì montammo in nave, e venimmo alla volta d’India e arrivammo ad un porto che si chiama Cheul.
India
I
1
Di Cambaia, città d’India abbondantissima d’ogni cosa.
Perché la promission nostra nel principio, se ben mi ricordo, è stata passare ogni cosa con brevità, acciò non sia tedioso il parlar mio, però continuaremo brevemente le cose che parseno a me degne di cognizione e dilettevoli, massimamente dell’India. Appresso il detto porto è una grandissima fiumara chiamata Indo, qual scorre presso ad una città nominata Cambaia. Questa città è posta verso il mezzogiorno dal detto Indo ed è 3 miglia in terra ferma, e alla città non si può andare con navilii grandi né mezzani, salvo quando l’acque sono vive e grosse: allora v’è una fiumara che va alla città, crescendo l’acque ben 3 o 4 miglia. E sappiate che le acque crescono al contrario delle nostre, perché a noi crescono l’acque quando la luna è piena, e ivi crescono quando la luna è scema. Questa città di Cambaia è murata a usanza nostra, e veramente è ottima città, abbondante di grano e di frutti buonissimi. In questo paese si trova 8 o 10 sorti di spezie minute, cioè turbitti, galanga, spico nardo, assa fetida e lacca, con altre spezie che non mi ricordo il nome. Si fa ancor quivi grandissima quantità di bombagio, per modo che se carica ogni anno 40 e 50 navi di panni di bombagio e di seta, li quali panni sono portati in diversi paesi. Trovasi ancora in questo regno di Cambaia, appresso a sei giornate, la montagna dove si cavano le corniole e la montagna delli calcedonii, e appresso Cambaia nove giornate si trova un’altra montagna, dove si trovano li diamanti
2
Della condizion del soldano di Cambaia, città nobilissima.
Ora diremo delle condizioni del soldano di questa città di Cambaia, il qual si chiama il soldano Machamut. Sono cerca quaranta anni ch’egli prese questo regno ad uno re di Guzerati, i quali sono certa generazione che non mangiano cosa che abbia sangue, né ammazzano cosa alcuna vivente. E questi tali non sono né mori né gentili: credo che se avessero il battesmo tutti sariano salvi, alle opere che fanno, perché ad altri non fanno quello che non vorriano che fusse fatto a loro. L’abito di questi è che alcuni vanno in camicia e alcuni nudi, salvo che portano un panno cerca le parti vergognose, senza alcuna cosa in piede né in gambe; in testa portano una tovaglia rossa, e sono di colore leonati. E per questa bontà loro il prefato soldano li tolse il reame.
Ora intenderete del viver di questo soldano Machamut. Egli primamente è maumettano, insieme con tutto il popol suo, e tiene di continuo ventimila uomini da cavallo; e la mattina quando si leva, vengono al palazzo suo 50 elefanti, sopra ciascun de’ quali viene un uomo a cavallo, e li detti elefanti fanno reverenzia al soldano e non hanno altro da fare. E similmente, quando è levato da letto e quando mangia, suonano 50 over 60 sorti d’instrumenti, cioè trombette, tamburi di più sorte, e ciufoli, e piffari, con molte altre sorti ch’io taccio per brevità; e ancor li detti elefanti, quando il soldano mangia, fanno reverenzia: quando sarà tempo vi dirò l’ingegno e sentimento che hanno detti animali. Il detto soldano ha li mostacchi sotto ‘l naso tanti lunghi che se gli annoda sopra la testa, come faria una donna le sue treccie, e ha la barba bianca per fino alla centura, e per quello che ne fu detto, ogni giorno mangia tossico. Non crediate però che se n’empia il corpo, ma ne mangia una certa quantità, per modo che, quando vuol far morire un gran maestro, lo fa venire innanzi a sé spogliato nudo, e poi mangia certi frutti che si chiamano chofole, li quali sono come una noce moscata, e mangia ancora certe foglie d’erbe le quali sono come foglie di melangole, che alcuni chiamano tambor, e appresso mangia certa calcina di scorze di ostreghe insieme con le presenti cose; e quando ha ben masticato e ha la bocca piena, sbuffa adosso a quella persona che vuol far morire, per modo che in spazio di mezza ora casca morta in terra. Questo soldano tiene ancor tre o quattromila donne, e ogni notte che dorme con una la mattina si trova morta. E ogni volta che lui si leva la camicia, mai più è toccata da persona alcuna, e così li vestimenti suoi, e ogni giorno vuol vestimenti nuovi. Il mio compagno dimandò per che cosa questo soldano mangiava così tossico; risposero certi mercanti più vecchi che ‘l padre l’avea fatto nutrire da piccolino di tossico.
Lasciamo il soldano e torniamo al viaggio nostro, cioè agli uomini di detta città, li quali la maggior parte vanno in camicia, e sono molto bellicosi e grandissimi mercanti. Non si potria dir la bontà del paese: qui vengono e vanno cerca 300 navi di più paesi. Questa città e un’altra che li è vicina (qual dirò quando sarà il tempo) fornisce tutta la Persia, la Tarteria, la Turchia, la Soria, la Barberia, cioè l’Africa, e l’Arabia Felice, l’Etiopia, l’India e l’altra moltitudine di isole abitate di panni di seta e di bombagio, sì che questo soldano vive con grandissima ricchezza, e combatte con un re il qual si chiama re di Ioghe, il quale confina a questa città quindeci giornate.
3
Del vivere e costumi del re di Ioghe.
Questo re di Ioghe è uomo di gran signoria e fa cerca 30 mila persone, ed è gentile, e tutto il popolo suo, e dalli re gentili col suo popolo è tenuto santo, per la lor vita, qual intenderete. Il re ha per costume di andar ogni tre o 4 anni una volta in peregrinaggio, cioè a spese d’altri, con tre o 4 mila delli suoi, e con la moglie e figliuoli; e mena quattro o cinque corsieri e gatti di zibetto e gatti maimoni, pappagalli, liompardi, falconi, e così va per tutta l’India. L’abito suo è una pelle di capra, cioè una davanti e una di drieto, col pelo di fuora, ed è di color lionato scuro, perché qui comincia esser la gente più oscura che bianca. Tutti portano grandissima quantità di gioie e perle e altre pietre preziose all’orecchie, e vanno pur vestiti all’apostolica e parte portano camicie. E il re e alcuni più nobili vanno con la faccia, le braccia e il corpo tutto infarinato di sandolo macinato con molti odori preziosissimi. Alcuni di questi si pigliano per devozione di non seder mai in cosa alta, e alcuni altri hanno per devozione di non seder in terra, alcuni di non star mai distesi in terra, altri di non parlar mai: e questi tali sempre vanno con tre o 4 compagni che li servono. Tutti generalmente portano uno cornetto al collo, e quando vanno in una città tutti di compagnia suonano li detti cornetti: questo fanno quando vogliono che gli sia data la elemosina.
E quando il re non cammina, ma si sta nell’alloggiamento, loro vanno almeno trecento o quattrocento alla volta per provedere delle cose necessarie, e stanno tre giorni in una città ad usanza di Cingani. Alcuni di costoro portano un bastone con un cerchio di ferro da piede, alcuni altri portano certi taglieri di ferro, li quali tagliano a torno a torno come rasori, e tirano questi con una frombola, quando vogliono offendere alcuna persona. E così, quando questi arrivano in alcuna città d’India, ogni uomo li fa ogni piacere, perché, se ben ammazzassero il primo gentiluomo della terra, non portano pena alcuna perché dicono che sono santi. Il paese di costoro non è troppo fertile, anzi hanno carestia di vivere, e sono più le montagne che piano. Le loro abitazioni sono molto triste e non hanno terre murate. Per mano di questi tali vengono nelle parti nostre molte gioie, perché costoro vanno per la lor libertà in fino dove nascono, e de lì le portano in altri paesi senza alcuna spesa. Sì che, per avere il paese forte e sterile, tengono in guerra quasi al continuo il soldano Machamut.
4
Della città di Cevul e de’ costumi, abito e armi del suo popolo.
Partendomi dalla detta città di Cambaia, camminai tanto ch’io giunsi ad un’altra città nominata Cevul, distante dalla sopradetta dodeci giornate: e infra l’una e l’altra di queste città, il paese si chiama Guzarati. E il re di questa Cevul è gentile, e le genti sono di color leonato oscuro; l’abito suo è che alcuni portano una camicia e alcuni vanno nudi, con un panno intorno alle parti inoneste, senza niente in piedi né in capo, salvo alcuni mercadanti mori. La gente è bellicosa: le arme sono spade, rotelle, archi e arme inastate di canne e di legno, e hanno artiglieria. Questa terra è molto ben murata ed è lontana dalla marina due miglia, e ha una bellissima fiumara, per la quale vanno e vengono grandissima quantità di navilii forestieri, perché il paese è abbondantissimo d’ogni cosa, eccetto di uva, noci e castagne. Quivi si raccoglie grandissima quantità di grano, di orzo e di legumi d’ogni sorte, e quivi si fa grandissima copia di panni di bambagio. La fede loro non vi dico, perché credono come il re di Calicut, del quale quando sarà tempo vi dechiarirò. In questa città sono assaissimi mercadanti mori. Qui comincia l’aere ad esser più tosto caldo che freddo. Qui si usa grandissima giustizia; questo re non ha molta gente da combattere. Hanno questi abitanti cavalli, buoi, vacche in assai copia.
5
Di Dabuli, città d’India.
Visto Cevul e’ suoi costumi, di là partendomi andai ad un’altra città lontana de lì due giornate, la quale è chiamata Dabuli, la qual città è posta sopra una ripa d’una grandissima fiumara. Questa città è murata a usanza nostra ed è assai buona; il paese è come della sopradetta. Quivi sono mercadanti mori in grandissima copia. Il re di questa terra Dabuli è gentile, e fa cerca trentamilia uomini combattenti, pure ad usanza di Cevul prefata; e questo re è grandissimo osservatore della giustizia. La terra, il vivere, l’abito e i costumi sono come nell’antedetta città di Cevul.
6
Di Goga, isola d’India, e del suo re.
Partitomi dalla detta città di Dabuli, andai ad un’isola distante da terra ferma cerca un miglio, e chiamasi Goga, la qual rende al re Decan ogni anno diecimila ducati d’oro, li quali loro chiamano pardai: e sono questi pardai più stretti che non sono li sarafi del Cairo, ma più grossi, e hanno per stampa duoi diavoli, cioè da una banda, e dall’altra banda hanno certe lettere. In questa isola è una fortezza murata a usanza nostra appresso al mare, nella quale sta alcune volte un capitano chiamato Sabain, il quale tiene 400 Mammalucchi ed egli ancora è Mammalucco. E quando il detto capitano può aver alcun uomo bianco, li fa grandissimo partito e gli dà almeno 15 overo 20 pardai al mese, e innanzi che lo metta nella lista de’ suoi uomini da bene, si fa portar duoi zupponi di corame molto grosso, uno per lui e l’altro per quello che vuole il soldo, e ciascuno si mette il suo indosso e fanno alle braccia: e se lo trova forte, lo fa scriver nella lista degli uomini da bene, se non, lo pone ad alcuno esercizio vile e mecanico, e non di combattere. Costui con questi 300 Mammalucchi fa grandissima guerra al re di Narsinga, del qual diremo al tempo suo.
De lì partitomi, camminato per sette giornate in terra ferma, arrivai alla città che si chiama Decan.
7
Di Decan, città bellissima, e di molte e varie sue ricchezze e gioie.
Nella detta città di Decan signoreggia un re maumettano: il capitano sopradetto sta al soldo di questo re, insieme con li detti Mammalucchi. Questa città è bellissima e molto forte e abbondante di ogni cosa. Il re di quella, fra li Mammalucchi e altri del regno suo, fa ben venticinquemila persone fra a cavallo e a piede. In questa città è un bel palazzo, e ordinato di tal modo che, avanti che s’arrivi alla camera del re, vi sono 24 camere. Questa città è murata a usanza de’ cristiani e le case sono bellissime. Il re di detta città vive con gran superbia e pompa: una gran parte de’ suoi servitori portano nelle punte delle scarpe rubini e diamanti e altre gioie; pensate quante ne portano nelle dita delle mani e nell’orecchie. Nel regno suo è una montagna donde si cavano li diamanti, quattro miglia lontana da detta città: ed è murata intorno intorno e vi si fa grandissima guardia. Questo reame è abbondantissimo d’ogni cosa, come le sopradette città. Sono tutti maumettani. L’abito suo sono vesti di seta overo camicie bellissime, e in piede portano scarpe over borzacchin, con calzoni ad usanza de’ marinari; le donne portano tutto coperto il viso ad usanza di Damasco.
8
Della diligenzia del detto re cerca la milizia.
Il sopradetto re di Decan sta sempre in guerra col re di Narsinga, e tutto il suo paese è maumettano. La maggior parte de’ suoi soldati sono forestieri e uomini bianchi, e li nativi del regno sono di color leonato. Questo re è potentissimo e molto ricco e molto liberale, e tiene ancora molti navilii per mare, ed è grandissimo nimico de’ cristiani.
Di qui partendoci, andammo ad un’altra città chiamata Bathecala.
9
Di Bathecala, città d’India, e della fertilità sua in molte cose, massime in riso e zuccaro; e di Amiadiva.
Bathecala è una città d’India nobilissima e distante da Decan cinque giornate; il re di detta città è gentile ed è sottoposto al re di Narsinga. Questa città è murata e bellissima, e distante dal mare cerca un miglio; non ha porto di mare, salvo che si va per una fiumara piccola, la qual passa appresso le mura della città. Quivi stanno molti mercatanti mori, per esser terra di grandissimo tratto. Qui è gran quantità di riso e gran copia di zuccaro, massime di zuccaro candido ad usanza nostra; quivi ancora si comincia a trovar noci e fichi, ad usanza di Calicut. Queste generazioni sono idolatre pur al modo di Calicut, salvo li Mori, che vivono alla maumettana. Qui non si usano cavalli né muli né asini, ma vi sono vacche, buffali e capre. In questo paese non nasce grano né orzo né legumi, ma altri frutti bonissimi ad usanza d’India.
Di qui partitomi, andai ad un’isola chiamata Amiadiva, nella quale abitano certe sorti di genti che sono mori e gentili. Questa isola è distante da terra ferma mezzo miglio e ha circa venti miglia di circuito, e in essa non è troppo buono aere, né è molto fertile. Infra l’isola e terra ferma è un bonissimo porto, e in detta isola si trova bonissima acqua.
10
Di Centacola, di Onor e Mangolor, terre bonissime d’India.
Camminando per una giornata dalla detta isola, trovai una terra chiamata Centacola, la quale ha un signor molto ricco. Qui si trovano molte carni in gran quantità, riso assai e frutti buoni ad usanza d’India. In questa città sono molti mercatanti mori; il signor d’essa è gentile. Le genti sono di color leonato; vanno nudi e scalzi, senza niente in testa. Questo signore è suddito al re di Bathecala.
De lì andammo in due giornate ad un’altra terra detta Onor, il re della quale è gentile ed è suddito al re di Narsinga. Questo re è buon compagno, e tien sette overo otto navilii, che vanno di continuo in corso a danno di chi manco può, ed è grandissimo amico del re di Portogallo. L’abito di queste genti è che vanno tutte nude, salvo che portano un panno intorno alle parti inoneste. Qui si trova riso assai ad usanza d’India, e vi si trovano alcune sorti d’animali, cioè porci salvatichi, cervi, lupi, lioni e gran quantità di uccelli differenti dalli nostri, molti pavoni e pappagalli; sonovi ancora molte vacche, le quali sono rosse, e hanno gran copia di castrati. Rose, fiori e frutti qui si trovano tutto l’anno: l’aere di questo luoco è in tutta perfezione, e vivono quelle genti più di noi.
Appresso la detta terra di Onor è un’altra terra chiamata Mangolor, nella quale si cargano cinquanta overo sessanta navi di riso. Gli abitatori di essa sono gentili e mori; il viver, i costumi e l’abito è come di sopra dicemmo. De qui partitici, andammo ad un’altra città chiamata Canonor.
11
Di Canonor, città grandissima in India.
Canonor è una bella e grande città, nella quale il re di Portogallo tien un fortissimo castello. Il re di questa città è assai amico del re di Portogallo, ancora che egli sia gentile. Questo Canonor è il porto dove si scaricano li cavalli che vengono dalla Persia, ed è da sapere che ogni cavallo paga venticinque ducati per gabella, e poi vanno in terra ferma alla volta di Narsinga. In questa città stanno molti mercatanti mori. E quivi non nasce grano né uva né frutto alcuno ad usanza nostra, salvo cetrioli e zucche; qui non si mangia pane, cioè per li nativi della terra, ma mangiano riso, pesce, carne e noci del paese. Quando sarà tempo, diremo della lor fede e costumi, perché vivono ad usanza di Calicut. Qui cominciano a trovarsi le speziarie, cioè pepe, zenzero, cardamomo e mirabolani e alcuna poca di cassia. Questa terra non è murata intorno; le case son triste. E qui ancora si trovano molti frutti differenti dalli nostri, e sono assai migliori, e al suo luoco dirò della loro similitudine.
Il paese è forte da combattere, perché tutto è pieno di cave fatte per forza. Il re di questa terra fa cinquantamila Naeri, cioè gentiluomini, li quali per combattere usano spade, rotelle, lance, archi e artigliaria. E’ più vanno nudi e scalzi, con un panno intorno, senza niente in testa, salvo che quando vanno alla battaglia portano un cappelletto intorno alla testa, di color rosso, ligato con una fascia che li dà due volte intorno, e portano tutti la legatura ad un modo. Qui non si adoperano cavalli né muli né camelli né asini; adoperasi qualche elefante, ma non per combattere. E in altro luoco si dirà de una fortezza che ‘l re di Canonor fece contra i Portogallesi. Questa terra è di gran tratto, e ogni anno sogliono venire dugento navilii di diversi paesi.
Passati alquanti giorni, pigliammo il cammino verso il reame di Narsinga, e camminammo quindeci giornate per terra ferma alla volta di levante, e arrivammo ad una città chiamata Bisinagar.
12
Di Bisinagar, città fertilissima del reame di Narsinga in India.
La detta città di Bisinagar è del re di Narsinga, ed è grandissima e con forti muraglie, situata in una costa di monte e di circuito di sette miglia intorno, e ha tre cerchi di mura. È terra di gran mercanzia e molto fertile, dotata di tutte le gentilezze possibili ad essere. Ha il più bel sito e il più bello aere che mai si vedesse, con certi luochi da cacciagioni molto belli, e similmente da uccellare, di modo che pare un altro paradiso. Il re di detta città è gentile con tutto il suo reame, cioè idolatri, ed è potentissimo e tiene continuamente quarantamila uomini da cavallo. Ed è da sapere che uno cavallo vale almanco trecento, quattrocento e cinquecento pardai, e alcuni sono comprati ottocento pardai, perché li cavalli non nascono lì, e manco vi si trovano cavalle femine, perché quelli re che tengono li porti del mare non le lassano menare. Tiene ancora il prefato re quattrocento elefanti, quali gli adopera quando vuol far guerra, e molti camelli, dromedarii, che corrono molto velocemente in ogni bisogno del re.
13
Della natura degli elefanti.
E a questo proposito mi par luoco molto opportuno di narrar qualche cosa della natura degli elefanti, per la promessa ch’io ho fatta di sopra: e così io dico che ‘l detto animal è di tanto ingegno, discrezion e memoria, che vi manca poco ad esser animal razionale, e ha la maggior forza che animal che sia sopra la terra. Gl’Indiani, quando voglion andar alla guerra, mettono al detto animal una bardella, al modo che portano li muli del reame di Napoli, stretta di sotto con due catene di ferro: sopra la detta bardella porta per ogni banda una cassa grande di legno molto forte, e per ogni cassa vanno tre uomini. E infra le casse e il collo dell’elefante mettono un tavolone grosso mezzo palmo, e infra le casse e sopra il tavolone va un uomo a cavallo, il qual parla allo elefante, perché gli ha più sentimento e maggior memoria che animale che sia nel mondo, e intende tutto ciò che se li dice: e questo si cognosce vedendo il piacer che ‘l si prende di esser laudato. Sì che sono in tutto sette persone che vanno sopra detto elefante, e vanno armati con camicie di maglia e con archi e lance, spade e rotelle, e similmente armano l’elefante di maglia, massime la testa e la tromba, e alla tromba legano una spada lunga due braccia, grossa e larga quanto è la mano d’un uomo. E così combattono, e quello che li va sopra il collo li comanda: “Va’ innanzi”, o: “Torna indrieto”, “Da’ a questo”, “Da’ a quello”, “Non li dar più”, e questo intende come se fusse una persona umana. Ma se pur alcuna volta si mettano in rotta, non gli possono ritenere, e di questo n’è causa il fuoco, perché queste generazioni di genti sono grandissimi maestri di far fuochi artificiati, e questi animali temono molto il fuoco e per questo rispetto, come lo vedono, si mettono molto in fuga. Ma in ogni modo gli è il più discreto e più intelligente animal che sia nel mondo, e anco il più possente.
Io ho visto tre elefanti mettere una nave di mare in terra, in questo modo ch’io vi dirò. Essendo io in Canonor, alcuni mercatanti mori varorono una nave in terra in questo modo, ad usanza de’ cristiani. Varano la nave con la prova innanzi, e qui mettono il costato della nave innanzi, e sotto la detta nave mettono tre legni grandi: e dalla banda del mare viddi tre elefanti inginocchiarsi in terra e con la testa spinger la nave in secco. E perché molti dicono che l’elefante non ha giunture nelle gambe, e che per questo non possono inginocchiarsi, dico per certo che le hanno come cadaun altro animal, ma nella ultima parte della gamba. Vi dico più che la elefanta femina è molto più feroce e assai più superba che non il maschio, e alcune delle femine sono lunatiche.
Li detti elefanti sono grossi per tre buffali, e hanno il pelo buffalino e gli occhi porcini e la tromba lunga fino in terra: e con quella si mette il mangiare in bocca e similmente il bere, perché la bocca sua l’ha sotto la gola, e quasi come un porco overo sturione. E questa tromba è busa dentro, e con quella li ho più volte visto pigliare un quattrino di terra, e anco tirare una rama d’un arbore, la qual noi, che eravamo ventiquattro uomini, con una corda non la potevamo tirare a terra, e l’elefante la tirò a tre tirate. Li duoi denti che si veggono sono nella mascella di sopra; l’orecchie sono duoi palmi per ogni verso e in alcuni più, in alcuni manco. Le gambe sue sono quasi grandi di sotto come di sopra; li piedi sono rotondi, come un grandissimo tagliero da tagliar carne, e intorno al piede tiene cinque onghie e ciascuna è grande come una scorza di ostrega. La coda è lunga come quella d’un buffalo, cioè cerca tre palmi, e ha pochi peli e rari. La femina è più piccola che ‘l maschio. L’altezza dell’elefante è diversa, perché n’ho visto assai 13 e 14 palmi alti, e ne ho cavalcati alcuni di detta altezza, e dicono che se ne trovano di quindeci palmi e più d’altezza. Lo andar suo è molto lento, e chi non l’ha accostumato non li può stare a cavallo, perché fa voltare lo stomaco come se andasse per mare; gli elefanti piccoli vanno portanti come una mula ed è una gentilezza a cavalcarli. E quando si vuol cavalcar, esso elefante abbassa una gamba di drieto e per quella gamba si monta suso: pur bisogna che vi aiutiate o facciate aiutar al montare. Ed è da sapere che ‘l detto elefante non porta né briglia né cavezza, né cosa alcuna legata nella testa. Quando vuol congiungersi con la femina e generare, va in luoco secreto, cioè nell’acqua in certi paludi, mostrando la quasi vergogna di esser veduto: e si congiungono come fanno gli uomini e le donne, ancora che molti dicono che si congiungano al contrario uno con l’altro. E in alcuni paesi ho visto che ‘l più bel presente che si possi far ad un re è la verga d’un elefante, la quale il re mangia come cosa preziosa e di gran conto, perché in alcuni paesi un elefante vale cinquecento ducati e in altri val mille e duemila ducati. Sì per conclusione dico che ho visto alcuno elefante che ha più ingegno e più discrezione e sentimento che non han molte sorte di genti che ho ritrovato.
14
Del re di Narsinga, e delli costumi delli popoli a lui soggetti, e della moneta che ‘l fa battere.
Questo re di Narsinga è il più gran re che mai abbia sentito nominare, sì di tesoro come per molti regni a lui soggetti. Questa città è in bellezza e sito molto simile a Milano, ma quello è in piano e questa nella costa de un monte: quivi è il seggio del re e li reami suoi stanno intorno, come saria il reame di Napoli e come la città di Venezia, di modo ch’egli ha il mare da due bande. Dicono li suoi Bramini, cioè sacerdoti, ch’egli ha ogni giorno dodecimila pardai di entrata; ha sempre molta gente a ordine, perché combatte di continuo con diversi re mori e gentili. La fede sua è idolatra, e adorano il diavolo come fanno quelli di Calicut: quando sarà tempo, diremo in che modo l’adorano; loro vivono come gentili. L’abito suo è questo: gli uomini da conto portano una camicia curta, e in su la testa una tocca alla moresca di molti colori, e in piede non portano cosa alcuna; il popolo minuto vanno tutti nudi, salvo che intorno le parti inoneste portano un panno. Il re porta una berretta di brocato d’oro lunga duo palmi, e quando va in guerra porta una vesta imbottita di bombagio, e sopra questa porta un’altra vesta piena di piastre d’oro, e intorno è piena di gioie di più sorte. Il suo cavallo vale più che alcuna città delle nostre, per rispetto degli adornamenti ch’ei porta di gioie e altre pietre preziose. Quando cavalca a piacere over alla caccia, vanno sempre con lui tre over quattro re e molti signori, e 5 over 6 mila cavalli, per il che si può considerare costui esser potentissimo signore. La sua moneta sono pardai d’oro, come ho detto, di valuta circa di un ducato d’oro, e batte ancora moneta d’argento, chiamata fanon, qual val mezzo marcello d’argento in circa; ha moneta di rame detta cas, e sedeci di queste valeno per un fanon, che venirà un cas ad esser circa un quattrino d’Italia.
In questo reame si può andare securamente per tutto, ma bisogna guardarsi d’alcuni lioni che sono pel cammino. Del viver suo non vi dico al presente, perché lo dechiarirò quando saremo in Calicut, per esser un medesimo vivere. Questo re è grandissimo amico de’ cristiani, massime del re di Portogallo, perché d’altri cristiani non ha molta cognizione. Le terre sue fanno grandissimo onore a’ Portoghesi, quando vi arrivano.
Visto che avemmo per alcuni giorni questa città tanto nobile, tornammo alla volta di Canonor, e poi che vi fummo arrivati, de lì a tre giorni pigliammo il cammino per terra e andammo ad una altra città chiamata Tromapatan.
15
Di Tromapatan, città d’India, e di Pandarane e Capogatto.
Tromapatan è distante da Canonor dodici miglia, ed è signor di questa uno gentile. La terra non è molto ricca, ed è appresso al mare un miglio e ha una fiumara non molto grande: qui sono molti navilii di mercatanti mori. Le genti della terra vivono miseramente, e la maggior ricchezza che sia qui sono noci di India, e di queste mangiano con un poco di riso. Hanno abbondanzia assai di legname per far navi. In questa terra sono cerca quindecimila Mori, e sono sottoposti al soldano overo al signore gentile. Non vi dico il suo vivere al presente, perché in Calicut vi sarà descritto, per esser tutta una medesima fede. In questa città non sono troppo buone case, perché una casa val mezzo ducato, come vi dirò più avanti.
Qui stemmo duoi giorni, e poi partimmo e andammo ad una terra chiamata Pandarane, distante da questa una giornata, la qual è sottoposta al re di Calicut, ed è terra assai trista e non ha porto. A riscontro di detta città tre leghe in circa v’è una isoletta disabitata. Il viver e costumi di questa città sono ad usanza di Calicut, ed è città non piana, ma terra alta. Di qui ci partimmo e andammo ad un altro luoco chiamato Capogatto, il quale pur è sottoposto al re di Calicut. Questa terra ha un bellissimo palazzo fatto all’antica, e ha una fiumara piccola verso mezzodì, ed è appresso a Calicut quattro leghe. Qui non è cosa da dire, perché vanno pure alli costumi e stili di Calicut.
Di qui ci partimmo e andammo alla nobilissima città di Calicut. Io non vi ho scritto del vivere, costumi, fede, iustizia, abito e paese di Cevul e Dabul, di Bathicala, né del re di Onor, né di Mangalor, né di Canonor, e manco del re di Cocchin, del re di Caicolom, né di quello di Colan, e manco ho detto del re di Narsinga. Ora vi voglio dire qui in Calicut, perch’egli è il più degno re di tutti questi sopra detti, e chiamasi Samoryn, che vien a dire in lingua gentile “Dio in terra”.
II
1
Essendo noi arrivati a Calicut, che è il principal capo dell’India, cioè il luoco nel qual è posto la maggior dignità dell’India, n’ha parso por fine al primo libro e dar principio al sequente, sì per porgere ad ogni benigno lettore cose di maggior dignità e consolazione, come acciò che egli con la sua umanità ne dia favor e aiuto nel cammino di questo nostro viaggio, e il suo piacere accreschi le forze del nostro ingegno: pur sottomettendo ogni cosa che si dirà di ciò al giudicio di quegli uomini i quali forse hanno veduto più paesi di me.
2
Di Calicut, città grandissima d’India.
Calicut è in terra ferma e il mar batte nelle mura delle case. Qui non è porto, ma appresso un miglio dalla terra verso mezzogiorno v’è una fiumara, la quale è stretta al sboccare in mare e non ha più che cinque o sei palmi d’acqua: e questo per causa che la si divide in molti rami, quali si destendono per quelle pianure e adacquano molti campi e orti; volta poi la detta fiumara verso la città di Calicut e passa per mezzo di quello. Questa città non ha mura intorno, ma dura l’abitazione stretta cerca un miglio e poi sono le case larghe, cioè separate l’una dall’altra: e questo per paura del fuoco overo per non saper edificarle; e durano cerca sei miglia e sono molto triste, e le mura sono alte quanto un uomo a cavallo, e sono la maggior parte coperte di foglie e senza solaro. La causa è questa, che cavando la terra quattro o cinque palmi si trova l’acqua, la qual non lassa far li fondamenti che possino sostener muri grossi, e per questa cagione non si ponno far grandi le abitazioni. Pur una casa d’un mercatante vale 15 o 20 ducati; le case del popol minuto vagliono mezzo ducato l’una, un ducato e duoi ducati al più.
3
Del re di Calicut e della religione.
Il re di Calicut è gentile e adora il diavolo nel modo che intenderete. Loro confessano che un Dio ha creato il cielo e la terra e tutto il mondo, ed è la prima causa in tutte le cose; e dicono che s’ei volesse giudicare voi e me e il terzo e ‘l quarto, che non averia piacer alcuno d’esser signore, ma ch’egli ha mandato questo spirito suo, cioè il diavolo, in questo mondo a far giustizia, e a chi fa bene ei li fa bene, e a chi fa male ei li fa male: essi lo chiamano il Deumo e Dio lo chiamano Tamerani. E questo Deumo il re di Calicut lo tiene nella sua cappella in questo modo: la sua cappella è larga duoi passi per ogni quadro e alta 4 passi, con una porta di legno tutta intagliata di diavoli di rilievo; in mezzo di questa cappella v’è un diavolo fatto di metallo, qual siede in una sedia pur di metallo. Il detto diavolo tiene una corona fatta a modo del regno papale con tre corone, e tiene ancora quattro corna e quattro denti, con una grandissima bocca aperta, con naso brutto e occhi terribilissimi e che guardan crudelmente, e le mani sono incurvate a modo d’uno uncino, li piedi a modo d’un gallo: per modo che a vederlo è una cosa molto spaventosa. Intorno alla detta cappella le sue pitture sono tutte diavoli, e per ogni quadro di essa v’è uno satanas posto a sedere in una sedia, la qual è posta in una fiamma di fuoco, nel quale sta gran quantità di anime lunghe mezzo dito e uno dito della mano: il detto satanas con la man dritta tiene una anima in bocca mangiandola, e con l’altra mano ne piglia una altra dalla banda di sotto.
Ogni mattina li Bramini, cioè sacerdoti, vanno a lavare il detto idolo tutto quanto con acqua odorifera, e poi lo profumano e, come l’hanno profumato, l’adorano. E alcuna volta fra la settimana li fanno sacrificio in questo modo: hanno una certa tavoletta fatta e ornata in modo di uno altare, alta da terra tre palmi, larga quattro e lunga cinque, la qual tavola è molto bene ornata di rose, fiori e altre gentilezze odorifere, sopra la quale mettono sangue di gallo e carboni accesi in un vaso d’argento, con molti profumi di sopra; hanno poi un turibulo col quale incensano intorno al detto altare, e una campanella d’argento la qual sonano molto spesso. Tengono in mano un cortello d’argento, col quale hanno ammazzato il gallo, e quello intingono nel sangue, e lo mettono alcuna volta sopra il fuoco, e alcuna volta lo pigliano, e fanno alcuni atti come colui che vuol giocare di schirmia: e finalmente abbruciano tutto quel sangue, stando continuamente candele di cera accese. Il sacerdote che vuol fare il sacrificio mette alle braccia, alle mani e a’ piedi alcuni manigli d’argento, li quali fanno grandissimo romore, come sonagli, e porta al collo uno pentacolo (quello che si sia non so). E quando ha fornito di fare il sacrificio, piglia tutte due le mani piene di grano e si parte dall’altar e va all’indrieto, sempre guardando all’altare, infino che arrivi appresso a uno certo arbore: e quando è giunto all’arbore, ei getta quel grano per sopra la testa, alto tanto quanto può sopra dell’arbore, poi ritorna e lieva ogni cosa dell’altare.
4
Come è il mangiare del re di Calicut e le cerimonie che usano.
Il re di Calicut quando vuol mangiare usa questi costumi, che ‘l cibo che deve mangiare il re lo pigliano quattro Bramini delli principali e lo portano al diavolo, ma prima l’adorano in questo modo: alzano le mani gionte sopra la testa sua, e poi tirano le mani a sé con la man serrata e levano in su il dito grosso della mano, e poi li presentano quel mangiare qual si ha a dare al re e così stanno tanto quanto può mangiare una persona. E poi li detti Bramini portano quel cibo al re, e questo fanno solamente per far onore a quell’idolo, acciò che paia ch’el re non voglia mangiare se prima non è stato presentato al Deumo. Questo mangiare si pone in un bacino di legno, nel quale sta una grandissima foglia di arbore, e sopra questa foglia v’è posto il detto mangiare, che è riso e altre cose. Il re mangia in terra senza alcuna altra cosa e, quando mangia, li Bramini stanno in piedi tre o quattro passi lontani dal re con gran reverenzia, e stanno abbassati con le mani innanzi alla bocca e piegati in la schiena; e mentre che il re parla, nessun debbe parlare, e stanno con gran reverenzia ad ascoltare le sue parole. Fornito ch’ha il re di mangiare, li detti Bramini pigliano quel cibo che avanza al re e lo portano in un cortile e lo posano in terra, ed essi Bramini battono tre volte le mani insieme: e a questo sbattere viene una grandissima quantità di cornacchie negre a questo cibo e se lo mangiano. Queste cornacchie sono usate a questo, e sono libere e vanno dove vogliono e non gli è fatto male alcuno.
5
Delli Bramini, cioè sacerdoti di Calicut.
È cosa conveniente ancora e dilettevole intender chi sono questi Bramini: è da sapere che sono li principali della fede, come appresso de noi sono li sacerdoti. E quando il re piglia moglie, cerca il più degno e più onorato che sia di detti Bramini e fallo dormire la prima notte con la moglie sua, accioché la svergini: non crediate che ‘l Bramino vada volentieri a far tal opera, anzi bisogna che ‘l re paghi 400 over 500 ducati. E questo usa il re solo in Calicut, e non altra persona.
Ora diremo di quante sorti di genti sono in Calicut.
6
Delli gentili di Calicut e di quante sorti siano.
La prima sorte de gentili che sono in Calicut si chiaman Bramini, che sono come sacerdoti e di maggior estimazione che cadaun altro. La seconda Naeri, li quali sono come appresso di noi li gentiluomini: e questi sono obligati a portar la spada e la rotella, o archi o lance, quando vanno per la strada, e non portando l’arme non sariano più gentiluomini. La terza sorte de gentili si chiamano Tiva, che sono artigiani. La quarta si chiamano Mechor, e questi sono pescatori. La quinta si chiamano Poliar, li quali raccolgono il pepe, il vino e le noci. La sesta si chiamano Hitava: questi seminano e raccolgono il riso. Queste due ultime sorti di genti, cioè Poliar e Hitava, non si ponno accostar alli Naeri né alli Bramini a cinquanta passi, salvo se non fussero chiamati dalli detti. E sempre vanno per luochi occulti e per paduli, e quando vanno per li detti luochi sempre vanno gridando ad alta voce: e questo fanno per non scontrarsi con li Naeri overo con li Bramini, perché, non gridando, e andando alcuni de’ Naeri a veder li suoi frutti e scontrandosi con le dette generazioni, i prefati Naeri li possono ammazzare senza pena alcuna, e per questo rispetto sempre gridano. Sì che avete inteso le sei sorti de gentili.
7
Dell’abito del re e della regina e degli altri di Calicut, e del loro mangiare.
L’abito del re e della regina e di tutti gli altri nativi del paese è che vanno nudi e scalzi, e portano un panno di bombagio overo di seta intorno alle parti inoneste, senza altro in testa, salvo alcuni mercatanti mori, li quali portano una camisola curta fino alla centura: ma tutti li gentili vanno senza camicia, e similmente le donne vanno nude e scalze come gli uomini, e portano le treccie lunghe. Il mangiar del re e delli gentiluomini, non mangiano carne senza licenzia delli Bramini; ma l’altre sorti di genti mangiano d’ogni carne, eccetto carne di vacca, e quelli che si chiamano Hitava e Poliar mangiano sorici e pesce secco al sole.
8
De quelli che succedeno dopo la morte del re e delle cerimonie che si fanno.
Morto il re e avendo figliuoli maschi, overo nepoti da canto del fratello, non rimangono re li figliuoli né il fratello né li nepoti, ma resta erede, cioè re, il figliuolo di una sua sorella; e non vi essendo figliuoli di detta sorella, resta re il più congiunto al re: e questo perché li Bramini hanno la virginità della regina. E similmente, quando cavalca il re fuori della terra, li detti Bramini (se ben fusse di venti anni il Bramino) restano in casa a guardia della regina, e il re ha di somma grazia che detti Bramini usino con la regina quante volte li piace: per questo rispetto dicono che la sorella e lui è certo che sono nati tutti d’un corpo medemo, ed è più sicuro delli figliuoli di quella che delli figliuoli suoi, e per questa causa la eredità per li ordini del regno viene alli figliuoli della sorella.
Similmente, dapoi la morte del re, tutti quelli del regno si radono la barba e la testa, salvo pure alcune parti della testa e similmente della barba, secondo la volontà delle persone; e ancora li pescatori non possono pigliar pesce per otto giorni. E quando muore un parente stretto del re, similmente si osservano questi modi, e il re si piglia per devozione di non dormire per un anno con donna, overamente di non mangiar betole, le quali sono come foglie di aranzi, le quali usano loro di continuo a mangiare: e queste sono tanto a loro come a noi le confezioni, e le mangiano più per lussuriare che per alcuna altra cosa. E quando mangiano le dette foglie, mangiano con esse un certo frutto che si chiama coffolo, e l’arbore del detto coffolo si chiama areca, ed è fatto a modo d’un piede di dattalo e fa li frutti a quel modo; e similmente mangiano con le dette foglie certa calcina di scorze d’ostreghe, le quali loro chiamano cionama.
9
Come li gentili alcuna volta scambiano le loro mogli.
Li gentiluomini e mercatanti gentili hanno fra loro tal consuetudine, che, se alcuna volta sono duoi mercanti che siano molto amici e che si amino, e ciascun di loro abbia moglie, l’un mercante dice all’altro in questo modo: “Or non siamo stati noi lungo tempo amici?” L’altro risponde: “Veramente sì, che io son stato tanto tempo tuo amico, e con tanto amor che più non potria esser”. Dice il primo: “Di’ tu la verità, che sei veramente mio amico?” Risponde l’altro: “Sì, per certo”. Dice il primo: “Per Dio?” L’altro risponde: “Per Dio”. Dice il primo: “Cambiamo adunque la tua donna, che io ti darò la mia”. Risponde l’altro: “Di’ tu da senno?” Dice il primo: “Sì, per Dio”. Risponde quell’altro e dice: “Vieni a casa mia”. E poi ch’è arrivato a casa chiama la sua donna e le dice: “Donna, vien qua: va’ con questo, che egli è tuo marito”. Risponde la donna: “Perché? Di’ tu il vero, per Dio?” Risponde il marito: “Dico il vero”. Dice la donna: “Piacemi, io vado”. E così se ne va col suo compagno alla casa sua. Lo amico suo dice poi alla sua moglie che vada con quell’altro, e a questo modo cambiano le mogli, e li figliuoli rimangono a ciascuno li suoi. Fra le altre sorti di gentili una donna tiene cinque, sei e sette mariti, otto ancora, e un dorme con lei una notte, l’altro l’altra notte; e quando la donna fa figliuoli, ella dice qual è figliuol di questo e qual di quello, e così loro stanno al detto della donna.
10
Del vivere e della giustizia de’ gentili.
I detti gentili mangiano in terra in un bacino di metallo e per cucchiaro usano una foglia d’arbore, e mangiano di continuo riso e pesce e spezie e frutti. Le due sorti di villani mangiano con la mano nella pignatta, e quando pigliano il riso della pignatta, fanno di quel riso una pallotta e poi se la mettono in bocca.
Cerca la giustizia che si usa fra costoro, è che, se uno amazza un altro a tradimento, il re fa pigliare un palo lungo quattro passi, ben apuntato, e appresso la cima due palmi fa mettere duoi bastoni in croce nel detto palo, e poi fa mettere il detto legno in mezzo della schiena del malfattore, e passali il corpo, e vien a giacere sopra quella croce e in tal modo si muore: e questo martirio lo chiamano uncalver. E se alcuno dà delle ferite over bastonate a un altro, il re lo fa pagar danari e così lo assolve. E quando alcuno deve avere danari da un altro mercatante, apparendo alcuna scrittura delli scrittori del re, il quale ne tiene ben cento, tengono questo stile. Poniamo caso che uno mi abbia a dare venticinque ducati, e molte volte mi prometta di darli e non li dia: non volendo io più aspettare né farli termine alcuno, vado al principe delli Bramini, che son ben cento, qual, dapoi che si averà molto ben informato ch’è la verità che colui mi è debitore, mi dà una frasca verde in mano, e io vado pian piano drieto al debitore e con la detta frasca vedo di farli un cerchio in terra circondandolo; e se lo posso giugnere nel circolo, li dico tre volte queste parole: “Io ti comando, per la testa del maggior delli Bramini e del re, che non ti parti di qui se non mi paghi e mi contenti di quanto debbo avere”. Ed egli mi contenta, over morirà prima da fame in quel luoco, ancor che niuno lo guardi; e s’egli si partisse del detto circolo e non mi pagasse, il re lo faria morire.
11
Dello adorare delli gentili e del suo mangiare.
La mattina a buon’ora questi gentili si vanno a lavare ad uno tanco, il qual tanco è come una fossa d’acqua morta, e come sono lavati non possono toccare persona alcuna fin che non hanno fatto l’orazione all’idolo, e questo è in casa sua. E fannola in questo modo: stanno col corpo stesi in terra, e stanno molto secreti, e fanno certe arti diaboliche con gli occhi stravolti e con la bocca, movendola con certi atti spaventosi e brutti, e dura questo per un quarto d’ora. E poi vien l’ora del mangiare, e non possono mangiare se ‘l cucinato non è fatto per mano d’un gentiluomo, perché le donne non cucinano se non per loro. E per questo usano li gentiluomini di aver cura del mangiare, e le donne non attendono ad altro, né hanno altro pensiero, che di lavarsi e profumarsi per piacere agli uomini. E ogni volta ch’el marito vuol usar con la donna, ella subito si lava e profuma molto delicatamente; nondimeno vanno sempre odorifere e tutte piene di gioie, cioè alle mani, all’orecchie, alli piedi e alle braccia, che è cosa bella a vedere.
12
Del combattere di quelli di Calicut, e di diversi altri loro costumi, e di quante città e paesi vi si trovano mercanti in detta città.
Per ordinario ogni giorno si scrima con spade, rotelle e lance, e per questo hanno molti boni maestri scrimitori. E quando vanno in guerra, il re di Calicut tiene continuamente centomila persone a piedi, perché qui non si usano cavalli, ma vi sono alcuni elefanti deputati per la persona del re, alcuni altri per suoi gentiluomini. E tutte le genti portano una binda di seta legata in testa, di colore vermiglio, e portano spade, rotelle, lance e archi. Il stendardo over bandiera del re è non so che cosa rotonda fatta di foglie di arbore, tessute una con l’altra a modo di un fondo di botte: e lo portano in cima di una canna, e con quello vanno faccendo ombra alla testa del re. E quando sono in battaglia, e uno esercito è lontano dall’altro duoi tiri di balestra, il re dice alli Bramini: “Andate nel campo de’ nimici, e dite al re che venga con cento delli suoi Naeri, e io anderò con cento delli miei”. E così vengono l’uno e l’altro alla metà del cammino e cominciano a combattere in questo modo: se ben combattessero tre giorni, mai si dariano di ponta, ma sempre danno duoi mandritti alla testa e uno alle gambe. Quando sono morti quattro o sei d’una delle parti, li Bramini entrano nel mezzo e fanno ritornare l’una e l’altra parte al campo suo. E subito vanno agli eserciti d’ambe le parti e dicono: “Ne volete più?” Risponde il re: “No”, e così fa la parte adversa. E a questo modo combattono a cento per cento, e questo è il loro combattere.
Il re alcuna volta cavalca gli elefanti e alcuna volta lo portano li Naeri, e quando lo portano sempre vanno correndo, e sempre vanno avanti del detto re molti instrumenti sonando. E alli detti Naeri li dà per ciascuno di soldo quattro carlini al mese, e a tempo di guerra li dà mezzo ducato, e di questo soldo vivono. Queste genti hanno li denti negri, per rispetto di quelle foglie di betole che vi dissi che mangiano. Morti che sono li Naeri, gli fanno abbruciare in un luogo cavato con grandissima solennità, e alcuni salvano quella cenere; ma del popol minuto dapoi la morte, alcuni li sepelliscono dentro della porta della sua casa, e altri davanti alla casa sua, alcuni altri nelli loro più belli giardini. Le monete della detta città sono battute qui com’io vi dissi in Narsinga.
Nel tempo ch’io mi ritrovai in Calicut, vi stavano grandissima quantità di mercatanti di diversi reami e nazioni. Essendo pur desideroso di saper donde erano tante diverse persone, fummi detto che quivi erano infiniti mercatanti mori e di Malacca, di Banghalla e di Tarnassari, di Pego, di Giormandel, di Zeilam, e gran quantità dell’isola di Sumatra, di Colon e di Caicolon, assaissimi di Bathacala, di Dabuli, di Cevul, di Cambaia, di Guzerati, di Ormus e della Mecca; ve n’erano ancora della Persia e dell’Arabia Felice, parte della Soria e della Turchia, e alquanti dell’Etiopia e di Narsinga: di tutti questi reami v’erano mercatanti al tempo mio in Calicut. La gente natural di questa terra non navigano molto per il mondo, ma li Mori sono quelli che trattano le mercanzie, perché in Calicut sono ben quindecimila Mori, li quali sono per la maggior parte nativi della terra e fanno mercanzia.
13
Delle navi di Calicut e a che tempo navicano, e della diversità delle stagion dell’anno, e quante sorti di navilii hanno.
Parmi assai conveniente e a proposito il dichiararvi come navigano queste genti per la costa di Calicut, e in che tempo, e come facciano li suoi navilii. Costoro adunque fanno primamente li suoi navilii di quattrocento overo cinquecento botte l’uno, i quali non hanno coperta. E quando fanno li detti navilii, infra una tavola e l’altra non mettono stoppa in modo alcuno, ma congiungono tanto bene quelle tavole che tengono l’acqua benissimo; e poi mettono la pegola di fuori e vi mettono grandissima quantità di chiodi di ferro. Non crediate però che loro abbiano carestia di stoppa, anzi ve n’è portata in abbondanza d’altri paesi, ma non la costumano per navilii. Hanno costoro ancora buon legname come noi e in maggior abbondanza. Le vele di queste sue navi sono di bombagio, e portano al piede di dette vele un’altra antenna, e quella spingono fuori quando sono alla vela per pigliar più vento, sì che loro portano due antenne e noi ne portiamo una sola. Le sue ancore sono di marmo, cioè un pezzo di marmo lungo otto palmi e duoi per ogni verso, e il detto marmo porta due corde grosse attaccate, e queste sono le sue ancore.
Il tempo della navigazione è questo: dalla Persia in fino al capo di Cumeri, ch’è lontano da Calicut otto giornate per mare alla volta di mezzogiorno, si può navigar per mesi otto dell’anno, cioè da settembre infino per tutto aprile; e poi, dal primo dì di maggio per fino a mezzo agosto, bisogna guardarsi da questa costa, perché fa grandissima fortuna e gran controversia di mare. Ed è da sapere che in questo paese le stagion de’ tempi sono contrarie alle nostre, perché quando qui da noi per causa della gran forza del sole tutte le piante si seccano, allora in detto paese le sono verdi e fresche per la grande acqua che vi piove, perché maggio, giugno, luglio e agosto, notte e giorno sempre piove: non che piova continuamente, ma ogni notte e ogni giorno piove, e poco sole si vede in questo tempo. Gli altri sei mesi mai non piove. Alla fine d’aprile si partono dalla costa di Calicut e passano il capo di Cumeri, ed entrano in un’altra navigazione, la quale è secura per questi quattro mesi, e vanno con navilii piccoli per spezie minute.
Il nome delli suoi navilii: alcuni si chiamano zambuchi, e questi sono piani di sotto; alcuni altri che sono fatti al modo nostro, cioè di sotto, e si chiamano ciampane; alcuni altri navilii piccoli si chiamano parao, e sono legni di 10 passa l’uno. Tutti sono d’un pezzo e vanno con remi da canna, e l’arboro è ancor di canna. V’è un’altra sorte di barchette piccole chiamate almadie, e sono pur tutte d’un pezzo. Ancora v’è un altra sorte di navilii, i quali vanno a vela e remi e sono fatti tutti d’un pezzo, di lunghezza di dodici e tredici passa l’uno, hanno la bocca stretta (non vi possono andar 2 uomini a paro, ma convien andar uno innanzi all’altro) e sono aguzzi da tutte due le bande: i quali navilii si chiamano caturi, e vanno a vela e remi più che galea o fusta o brigantino. Questi tali che adoperano simil navilii sono corsari di mare, e questi caturi si fanno ad una isola qui appresso, detta Porcai.
14
Del palazzo del re di Calicut e del tesoro grande che ‘l tiene.
Il palazzo del re è circa un miglio di circuito. Le mura sono molto basse, come dissi di sopra, con tramezzi alle camere bellissimi di legname, intagliati di diavoli di rilievi. Il piano della casa è tutto imbrattato con sterco di vacche per onorificenzia, e ogni parte di questo palazzo val più di ducati 20. Già vi dissi la cagione che non si possono fondare le muraglie, per rispetto dell’acqua che cavando si trova subito. Non si potria stimare le gioie e perle che porta il re, benché nel tempo mio stava malcontento per rispetto ch’era in guerra col re di Portogallo, e ancora perch’egli avea il mal franzoso, e avealo nella gola. Nondimeno portava tante gioie nell’orecchie e nelle mani, nelle braccia, ne’ piedi e nelle gambe, che era cosa mirabile a vedere. Il tesoro suo sono due magazzeni di verghe d’oro e moneta stampata d’oro, le quali dicevano molti Bramini, che sono quelli che hanno la cura del governo e sanno tutti li secreti del re, che non lo portariano cento muli carichi; e dicono che questo tesoro è stato lasciato da 10 o 12 re passati, e hannolo lasciato per li bisogni e fortezza della republica e del suo regno. Dicesi ancora questo re di Calicut aver una cassetta, lunga tre palmi e alta un palmo e mezzo, piena di gioie di più sorti che valeano prezii inestimabili.
15
Del pepe, giengevo, mirabolani, che nascono in Calicut.
Nel territorio di Calicut si trovano molti arbori di pepe, e dentro della città ne sono ancora, ma non in molta quantità. Il piede di questi arbori è a modo d’una vite sottile, cioè piantata una pianta appresso qualche altro arbore, perché da se stesso non potria star dritto, sì come la vite. Questo arbore è molto simile e fa come l’edera, che si abbraccia e va tanto in alto quanto è il legno o arbore dove si possi abbrancare. La detta pianta fa gran quantità di rami, li quali sono di duoi o di tre palmi lunghi; le foglie di questi rami sono come quelle di aranci, ma sono più asciutte, e dal riverso sono piene di vene minute. E per ciascuno di questi rami sono cinque, sei e sette raspi lunghi un poco più d’un dito di uomo, e sono come è l’uva passa piccola, ma più assettati, e sono verdi com’è l’agresta. E del mese d’ottobre lo raccolgono così verde, e raccogliesi ancora del mese di novembre, e poi lo mettono al sole sopra certe stuore e lo lasciano al sole per tre o quattro giorni, e diventa così negro come si vedde quivi da noi, senza farli altra cosa. E dovete sapere che costoro non potano mai e manco zappano questo arboro che produce il pepe.
In questo luoco ancora nasce il zenzero, il quale è una radice, e di queste tal radici alcune se ne trovano di quattro e di otto e dodeci onze l’una: quando la cavano, il piede di detta radice è cerca tre o quattro palmi lungo, ed è fatta in modo d’alcune cannuzze. E quando raccolgono detto zenzero, in quel medesimo luogo pigliano uno occhio della detta radice, che è a modo di un occhio di canna, e piantanlo in quel buco dove hanno cavata quella radice e con quella medesima terra lo cuoprano: in capo dell’anno tornano a raccoglierlo e piantanlo pure al modo predetto. Questa radice nasce in terra rossa e in monte e in piano, come nascono li mirabolani, delli quali qui se ne trova di tutte le sorti: il piede suo è a modo d’un pero mezzano e cargano a modo del pepe.
16
Di molti frutti che nascono in Calicut e fra gli altri della ciccara, che in la India occidental chiamano pigne, e del melapolanda, che è quello che in Alessandria chiamano muse.
Una sorte di frutti trovai in Calicut che si chiama ciccara: il piede suo è a modo de una pianta grande spinosa, e il frutto è lungo duoi palmi over duoi e mezzo e grosso come la coscia dell’uomo. Questo frutto nasce nel tronco che è in mezzo della pianta, cioè sotto alle frasche e spine, e parte se ne fa a mezzo il piede. Il color del detto frutto è verde, ed è fatto come la pigna, ma il lavoro è più minuto; e quando comincia a maturare, la scorza vien negra e gialla e non dura troppo dapoi raccolta, che vien fracida. Questo frutto si raccoglie del mese di decembre e rende un odore suavissimo, e quando si mangia par che si mangino buoni melloni moscatelli pieni di succo, e ancora che assomigli ad un persico cotogno ben maturo: e tanta è la dilettazione e suavità nel gusto che par che si mangi d’un favo di mele, e si sente ancora il sapore d’uno arancio molto dolce. Per dentro del detto frutto vi sono alcune spoglie over telette come il pomo granato, e a mio giudicio questo è il miglior frutto che io mangiassi mai e il più eccellente.
È quivi un altro frutto che si chiama amba; il piede suo si chiama manga. Questo arboro è come un pero, e cargasi di frutti come il pero. È fatta questa amba al modo di una noce delle nostre: quando è il mese di agosto è a quella forma, e quando è matura è gialla e lustra. Questa ha un osso dentro come una mandola secca, ed è questo frutto molto migliore che ‘l pruno damasceno; e di questo, quando egli è verde, se ne fa conserva come facciamo noi delle olive, ma sono assai più perfetti.
Qui si trova un altro frutto a modo d’un mellone, e ha le fette pur a quel modo: e quando si taglia, si trovano dentro tre over quattro grani che paiono uva overo visciole, così agri. L’arboro di questo è di altezza d’un arboro di pomo cotogno, e fa la foglia in quel modo. Ed è questo frutto chiamato corcopal, il quale è ottimo da mangiare e perfetto per medicina. Trovai ancora quivi un altro frutto, il quale è proprio come il nespolo, ma è bianco come un pomo: non mi ricordo come si chiami il nome. Un’altra sorte ancora di frutti vi viddi, il qual era come una zucca di colore e lungo duoi palmi, e la più saporosa da mangiar, perché ha tre dita di polpa, ed è assai migliore che la zucca o il cedro per confettare, ed è una cosa molto singulare: e questo si chiama comolanga e nasce in terra a modo di melloni.
Nasce in questo paese ancora un altro frutto molto singulare, il quale si chiama melapolanda. Questa pianta è alta quanto un uomo o poco più, e fa quattro over cinque foglie, le quali sono rami e foglie: ciascuna di queste copre un uomo dall’acqua e dal sole. Nel mezzo di questo getta un certo ramo che fa li fiori a modo d’un piede di fave, e poi fa alcuni frutti che sono lunghi mezzo palmo e un palmo, e sono grossi com’è un’asta d’una zannetta. E quando si vuol raccogliere il detto frutto, non aspettano ch’el sia maturo, perché si matura in casa: e uno ramo di questi frutti ne farà dugento vel cerca, e tutti si toccano l’uno con l’altro. Di questi frutti se ne trova di tre sorti, e la prima sorte si chiamano ciancapalon: questi sono una cosa molto cordiale a mangiare; il color suo è un poco giallo e la scorza è molto sottile. La seconda sorte si chiama cadelapolon, e sono molto migliori degli altri; la terza sorte sono tristi. Queste due sorti sopradette sono buone a similitudine delli nostri fichi, ma sono più perfetti. La pianta di questi frutti produce una volta e poi si secca. La detta pianta tiene sempre intorno al piede cinquanta o sessanta figliuoli, e li padroni pigliano di mano in mano di detti figliuoli e trapiantano, e in capo dell’anno produce il suo frutto. E quando tagliano li detti rami che siano troppo verdi, mettono un poco di calcina sopra li detti frutti per farli maturar presto. E di tali frutti se ne trovano d’ogni tempo dell’anno in grandissima abbondanzia, e se ne dà venti al quattrino. Similmente qui si trovano tutti li giorni dell’anno rose e fiori singularissimi, cioè bianche, rosse e gialle.
17
Del più fruttifero arboro che sia al mondo, qual è quello che fa le noci d’India, che si chiamano cocos.
Un altro arboro vi voglio descrivere, il migliore che sia in tutto il mondo, il quale si chiama tenga ed è fatto a modo di un piede di dattalo. E di questo arboro se ne cavano molte utilità, cioè corde per navigare in mare, panni sottili, quali poi che sono tinti paiono di seta, noci per mangiare, vino, acqua, olio e zuccaro. E delle foglie che cascano, cioè quando casca alcun ramo, se ne coprono le case, e queste tengono l’acqua per mezzo l’anno. Se io non vi dechiarassi in che modo fa tante cose, voi non lo credereste e manco potreste intenderlo. E detto arbore fa le predette noci come saria un ramo di dattali, e ciascun arbore fa cento o dugento di queste noci, sopra le quali vi è una scorza, della quale se ne cava una certa cosa come bombagio o vero lino: e questo si dà acconciare alli maestri, e del fiore di questo lino ne fanno panni sottili come di seta, e di quel grosso lo filano e fanno corde piccole, e di piccole ne fanno grosse, e queste si adoperano per mare. Dell’altra scorza della detta noce se ne fa carbone perfetto. Dapoi la seconda scorza v’è la noce per mangiare: la grossezza del detto frutto è come il dito piccolo della mano, ed è miglior che la mandola. In mezzo della detta noce, come comincia a nascere, così si comincia a creare l’acqua dentro; e quando la noce ha la sua perfezione, allora è piena d’acqua, per modo che vi è tal noce che averà duoi bicchieri d’acqua, la quale è perfettissima e suavissima da bere, e quanto alcuna cosa che l’uomo si possi immaginare. Della detta noce se ne fa oglio perfettissimo. E così avete da questa sette utilità.
Quando l’arbore è grande, alcuni rami non lasciano che produchin noci, ma gli tagliano alla mità, dandoli una certa sfenditura con un coltello, e poi li mettono sotto una zucca o vaso, dove distilla un certo liquore: e raccogliono fra il dì e la notte mezo boccale, il qual beono, e alcuni lo pongono al fuoco e ne fanno di una, di due e tre cotte, in modo che pare una acquavita, la quale solo ad odorarla, non che a beverla, fa alterar il cervello dell’uomo. E di queste sorti è quel vino che si bee in questi paesi. Di un altro ramo di detto arbore cavano similmente questo sugo e lo fanno venire in zuccaro col fuoco, ma non è molto buono. Il detto arbore sempre ha frutti o verdi o secchi, e produce frutti in cinque anni; e di questi arbori se ne trovan infiniti in 200 miglia di paese e tutti hanno patroni. Per la eccellenzia e bontà di questo arbore, quando li re fanno guerra l’un con l’altro, e che sia così crudele che si ammazzino li figliuoli l’uno all’altro, pur alla fine fanno la pace; ma tagliando l’un re all’altro di questi arbori, non gli saria mai in eterno data la pace. E detto arbore vive 30 o 40 anni e molto più, e nasce in luogo arenoso, e piantasi quella noce, la quale come comincia a germugliare overo a nascere, è necessario che gli uomini ogni sera la vadino a scoprire, acciò che la rugiada della notte li dia sopra, e la mattina a buon’ora poi la tornino a coprire, perché il sole non la trovi così scoperta: e a questo modo la cresce e si fa grande arbore. Nel detto paese di Calicut si trova gran quantità di zerzelino, del quale ne fanno oglio perfettissimo.
18
Del modo che servano nel seminar del riso.
Gli uomini di Calicut, quando vogliono seminar il riso, servano questa usanza: la prima cosa arano la terra con li buoi a modo nostro, e allora che seminano il riso, nel campo, di continuo tengono tutti gli instrumenti della città sonando e faccendo allegrezza, e similmente tengono dieci o ver dodici uomini vestiti da diavoli, e questi con li sonatori fanno gran festa, acciò che ‘l diavolo produca assai frutto di quel riso.
19
Delli medici che visitano gli infermi in Calicut.
Essendo alcuno mercatante (cioè gentile) ammalato, e stia in estremo, vanno alcuni uomini a questo deputati, con gli instrumenti sopradetti e vestiti come diavoli, a visitarlo: e questi si chiamano medici, e vanno a due o tre ore di notte. E li detti portano il fuoco in bocca, e in ciascuna delle mani e de’ piedi portano due stampelle di legno che sono alte un passo: e così vanno cridando e sonando gli instrumenti, che veramente, se la persona non avesse male, vedendo queste bestie così brutte cascaria in terra stramortita. E questi sono li medici che vanno a vedere e visitare l’infermo. E pur quando si sentono lo stomaco ripieno infino alla bocca, pestano tre radici di zenzero e fanno una tazza di sugo e lo bevono, e in tre giorni non hanno più male alcuno. Sì che vivono proprio come le bestie.
20
Delli banchieri e cambiatori.
Li cambiatori e li banchieri di Calicut hanno alcuni pesi, cioè bilance, le quali sono tanto piccole che la scatola dove stanno e li pesi insieme non pesano mezza oncia, e sono tanto giusti che tirano un capello di capo. E quando vogliono toccare alcun pezzo d’oro, essi tengono li caratti d’oro come noi e hanno il parangone come noi e toccano pure alla usanza nostra. Quando il parangone è pieno d’oro, tengono una palla di certa composizione la quale è a modo di cera, e con questa palla, quando vogliono vedere se l’oro è buono o tristo, improntano il parangone, e levano via l’oro di detto parangone, e poi guardano in essa palla la bontà dell’oro e dicono: questo è buono e questo è tristo. E quando poi quella palla è piena d’oro, vanno a fonderla e cavano tutto quell’oro che hanno toccato nel parangone. Li detti cambiatori sono sottilissimi nell’arte sua.
Li mercatanti hanno questa usanza quando vogliono vendere o comprare le loro mercanzie, cioè in grosso, che sempre si vendono per mano del sensale. E quando il compratore e il venditore vogliano accordarsi, stanno tutti in un circulo, e il sensale piglia una tovaglia e con una mano la tiene publicamente, e con l’altra mano piglia la mano del venditore, cioè le due dita accanto il dito grosso, e poi copre con la detta tovaglia la man sua e quella del venditore; e toccandosi queste dita l’uno e l’altro, numerano da uno ducato infino a centomila secretamente, senza parlare: “Io voglio tanto e tanto”, e in toccare solo le giunture delle dita s’intendono del prezzo, e dicono no o sì, e il sensale risponde no o sì. E quando il sensale ha inteso la volontà del venditore, va al compratore col detto panno e piglia la mano in quel modo che è detto di sopra, e li dice con quel toccare: “Lui ne vuol tanto”; il compratore con il toccar le dita del sensale li dice: “Io voglio darli tanto”: e così in questo modo fanno il prezzo. Se la mercanzia di che si tratta fra loro fusse spezie, parlano a bahar, il qual bahar pesa libbre 640 alla sottile di Venezia; e una farazola pesa libbre 32 sottile di Venezia, e 20 farazole fanno un bahar.
21
Come li Poliar e Hitava nutriscono li loro figliuoli.
Le donne di queste due sorti di genti, cioè Poliari e Hitava, lattano i loro figliuoli cerca tre mesi, e poi li danno a mangiare latte di vacca overo di capra. Poi che li hanno empiuto il corpo per forza, senza lavarli il viso né la persona, lo gettano nell’arena, nella quale sta dalla mattina alla sera tutto involto dentro. E perché sono più negri che d’altro colore, non si conosce se gli è un buffalotto over orsetto, sì che pare una cosa contrafatta, e pare che ‘l diavolo li nutrisca. La sera poi la madre li dà il suo cibo. Questi, nutriti e allevati in questo modo, sono li più destri volteggiatori e corritori che siano al mondo.
22
Degli animali e uccelli che si trovano in Calicut.
Non mi par di trapassare il dechiararvi le molte sorti d’animali e di uccelli che si ritrovano in Calicut, e massime come sono lioni, porci salvatichi, caprioli, lupi, vacche, buffali, capre ed elefanti (quali però non nascono qui, ma vengono da altri luochi), gran quantità di pavoni salvatichi, pappagalli in grandissima copia, verdi e alcuni pezzati di rosso: e di questi pappagalli ve ne sono tanti che gli è necessario guardare il riso, che detti uccelli non lo mangino; e l’uno di questi pappagalli val duoi quattrini, e cantano benissimo. Viddi ancor qui un’altra sorte di uccelli, li quali si chiamano saru, e cantano meglio che non fanno li pappagalli, ma sono più piccoli. Qui sono molte altre sorti di uccelli differenti dalli nostri, e nel vero, per un ora la mattina e una la sera, non è tal piacere al mondo quanto è a sentire il canto di questi uccelli, talmente che pare stare in paradiso; e anche per esservi tanta moltitudine di arbori che sono sempre verdi, il che procede per esservi l’aere temperato, di modo che qui non si conosce gran freddo né troppo caldo.
In questo paese nasce gran quantità di gatti maimoni, e vagliono quattro casse l’uno, le qual casse vagliono un quattrin l’una; e danno grandissimo danno a quelli poveri uomini, li quali fanno il vino di quel arbore detto di sopra, che è a modo di dattalo, di qual si cava quel liquor a modo di vino, perché montano in cima di quella noce e bevono quel liquor, e poi riversano la pignatta, spargendo quel che non possono bere.
23
Delli serpenti che si trovano in Calicut.
Trovasi in questo paese di Calicut una sorte di serpenti, li quali sono così grandi e così grossi come un gran porco, e hanno la testa molto maggiore e più brutta che non ha il porco, e hanno quattro piedi, e sono lunghi quattro braccia, e nascono in certi paludi. Dicono questi del paese che non hanno tossico, ma che sono maligni animali e fanno dispiacere alle persone per forza di denti. Qui si trovano tre altre sorti di serpenti, li quali toccando un poco la persona, cioè faccendo sangue, subito casca morto in terra: il che è intravenuto più volte al tempo mio a molte persone, che furono tocche da questi animali. Delli quali se ne trovano di tre ragioni: la prima sono come aspidi sordi, l’altra son scorzoni, la terza sono maggiori tre volte che il scorzone. E di queste tre sorti ve n’è grandissima quantità, e la causa è questa, perché quando il re di Calicut sa dove sia la stanzia ferma di alcuni di questi brutti animali, per certa vana superstizion, li fa fare una casetta piccola con un solaretto di sopra, per rispetto che l’acqua crescente non gli annieghi. E se alcuna persona ammazzasse uno di questi animali, subito il re lo faria morire come se gli avesse morto un uomo; similmente, se alcuno ammazzasse una vacca, ancora lo faria morire. Dicono costoro che questi serpi sono spiriti di Dio, e che, se non fussero suoi spiriti, non gli averia data tal virtù che, mordendo un poco la persona, subito cascasse morta. E per questo rispetto v’è tanta copia di questi animali, che vanno per tutta la città e conoscono li gentili, li quali non si guardano da essi, e quelli non li fanno mal alcuno. Pur al tempo mio uno di questi serpi entrò una notte in una casa e mordette nove persone, e la mattina tutti furono ritrovati morti e infiati. Quando i detti gentili vanno in qualche viaggio, scontrando alcuni di questi animali, tengono aver buono augurio e che le cose li debbano succeder bene.
24
De’ lumi del re di Calicut, e delle cerimonie che fanno alli morti.
Nella casa del re di Calicut sono molte stanzie e camere, dove ardono infiniti lumi, ma nella sala principal dove sta il re, subito che viene la sera, hanno dieci over dodici vasi fatti a modo d’una fontana, li quali sono di metallo gettato e alti quanto una persona. Ciascuno di questi vasi ha tre luoghi per tener l’olio, alti da terra duoi palmi: e prima un vaso nel quale sta l’olio con stoppini di bambagio accesi intorno intorno, e sopra questo v’è un altro vaso più stretto pur con li detti lumi, e in cima del vaso secondo ve n’è un altro più piccolo pur con olio e lumi accesi. Il piè di questo vaso è fatto in triangolo e in ciascuna delle faccie, da piede, stanno tre diavoli di rilievo, e sono molto spaventosi a vederli: questi sono li scudieri che tengono li lumi innanzi al re.
Usa ancora questo re un altro costume, che quando muore uno che sia suo parente, finito che è l’anno del corruccio, manda ad invitare tutti li principali Bramini che sono nel suo regno, e alcuni ancora ne invita di altri paesi, e venuti che sono, fanno per tre giorni grandissimi conviti. Il mangiar loro è risi fatti in più modi, carne di porco salvatico e di cervo assai, perché sono gran cacciatori. In capo di tre giorni il detto re dà a ciascuno delli Bramini principali tre, quattro e cinque pardai, e poi ogniuno torna a casa sua, e tutti quelli del regno del re si radono la barba per allegrezza.
25
Come alli 25 di decembre viene gran numero di gente appresso a Calicut a pigliare il perdono.
Appresso a Calicut v’è un tempio in mezzo d’un tanco, cioè in mezzo d’una fossa d’acqua morta, il qual tempio è fatto all’antica con due mani di colonne, come è San Giovanni Fonte di Roma, nel qual tempio è uno altare di pietra dove si fa il sacrificio, e infra ciascuna delle colonne del circuito da basso sono alcune navicelle di pietra, le quali sono lunghe duo passi e sono piene d’un certo olio che si chiama enna. Intorno alla ripa del detto tanco v’è grandissima quantità di arbori tutti d’una sorte, né si potriano contar i lumi che a detti arbori sono accesi; sono similmente intorno al detto tempio lumi di olio in grandissima copia. E quando viene il dì di 25 del mese di decembre, tutto il popolo intorno a quindeci giornate, cioè li Naeri e Bramini e altri, vengono a far questo sacrificio per aver questa indulgenzia, e prima che facciano il sacrificio tutti si lavano nel tanco. E poi li Bramini principali del re montano a cavallo delle barchette di pietra sopradette, dove è l’olio, e tutto questo popolo viene alli detti Bramini, li quali a ciascuno ungono la testa di quell’olio; e poi fanno il sacrificio sul detto altare. In capo d’una banda di questo altare sta un grandissimo satanasso con una spaventevol faccia, il qual tutti buttati in terra vanno ad adorare, e poi ciascuno ritorna a casa sua. E in questo tempo la terra è libera e franca per tre giorni: li banditi e malfattori possono venir al perdon molto sicuramente, cioè che non si può far vendetta l’un con l’altro. In verità io non viddi mai in una volta tanta gente congiunta insieme, salvo quando io fui alla Mecca.
Parmi assai a sufficienza avervi dichiarato li costumi e il vivere, la religione e i sacrificii di Calicut; onde, partendomi di qui, descriverrovvi il resto del viaggio mio passo passo, insieme con tutte le occorrenzie in esso accadutemi.
III
1
Della città di Caicolon e Colon e di Chail.
Vedendo il mio compagno, chiamato Cazazionor, non poter vender la sua mercanzia per esser disfatto Calicut dal re di Portogallo, perché non v’erano e manco vi venivano li mercatanti che soleano venire (e la cagion che non venivano fu perché ‘l re consentitte alli Mori che ammazzassero quarantasei Portoghesi, li quali io viddi morti: e per questa causa il re di Portogallo vi fa di continuo guerra, e ne ha ammazzato e ammazza ogni giorno gran quantità, di sorte che è disfatta grandemente la città, e molti che vi abitavan si sono partiti e andati a star altrove), e però ancor noi ci partimmo, pigliando il nostro cammino per una fiumara, la qual è la più bella che mai vedessi, e arrivammo ad una città chiamata Caicolon, distante da Calicut cinquanta leghe. Il re di questa città è gentile e non è molto ricco; il vivere, l’abito e i costumi suoi sono ad usanza di Calicut. Qui arrivano molti mercatanti, per rispetto che in questo paese nasce pepe d’assai perfezione. In questa città trovammo alcuni cristiani di quelli di san Tommaso, che sono mercatanti e credono in Cristo come noi, e dicono che ogni tre anni viene uno sacerdote a battezzarli fino di Babilonia. Questi cristiani digiunano e fanno la quaresima e la Pasqua come noi, e hanno tutte quelle solennità e feste de’ santi che avemo noi, ma dicono la messa come i Greci, e nominano e accettano quattro nomi di santi sopra tutti gli altri: san Giovanni, san Iacopo, san Mattia e san Tommaso. È la detta città alla medesima maniera di Calicut, quanto all’aere temperato, sito della region e costumi delle genti.
In termine di tre giorni noi partimmo di qui, e andammo ad un’altra città chiamata Colon, distante dalla sopradetta venti miglia. Il re di questa città è gentile e molto possente, e tiene ventimila uomini a cavallo e molti arcieri, e di continuo sta in guerra con altri re. Questa terra ha un bel porto appresso alla marina; in essa non nasce grano, ma vi nascono ben tutti li frutti al modo di Calicut e pepe in assai copia. Il colore di questa gente, l’abito, il vivere e costumi pur come in Calicut. In quel tempo il re di questa città era fatto amico del re di Portogallo, e vedendo che ‘l stava con altri re in guerra, non ci parve tempo di dimorar qui, onde pigliammo il cammin nostro per mare e andammo ad una città chiamata Chail, pur del re. All’incontro di Colon, vedemmo uomini pescar le perle in mare, come già vi dichiarai che facevano in Ormus.
2
Di Cholmendel, città dell’India.
Passando più avanti, arrivammo ad una città chiamata Cholmendel, la qual è terra di marina ed è distante da Colon sette giornate per mare, e più e manco secondo il vento. Questa città è grandissima e non è murata intorno, ed è sottoposta al re di Narsinga; è posta a riscontro dell’isola di Zeilan, passato il capo di Cumeri. In questa terra si raccoglie gran quantità di riso, ed è scala di grandissimi paesi, e quivi sono molti mercatanti mori, i quali vanno e vengono per mercanzie. Qui non nascono spezie di sorte alcuna, ma frutti assai ad usanza di Calicut. Ritrovai in questa terra alcuni cristiani, che mi dissero che ‘l corpo di san Tommaso era dodeci miglia lontano di lì ed era in guardia di loro cristiani, quali non potevano più vivere in quel paese dapoi la venuta del re di Portogallo, perché il detto re ha morti molti Mori di quel paese, il qual tutto trema per paura di Portoghesi: e però li detti poveri cristiani non ponno più viver qui, ma sono scacciati e ammazzati secretamente, acciò non pervenga ad orecchie del re di Narsinga, il qual è grandissimo amico de’ cristiani e massime di Portoghesi. Ancora mi dissero d’uno grandissimo miracolo che i loro maggiori gli avean detto, come già cinquanta anni li Mori ebbero quistione con li cristiani e di una parte e l’altra ne furono feriti, ma un cristiano fra gli altri fu molto ferito in un braccio, ed egli andò alla sepultura di san Tommaso, e con quel braccio ferito toccò la sepoltura del detto santo e subito fu liberato. E che da quel tempo in qua il re di Narsinga sempre ha voluto bene alli cristiani.
Il mio compagno spacciò quivi alcune delle sue mercanzie, e perché si stava in guerra col re di Tarnassari, non stemmo se non alcuni pochi giorni qui, e poi pigliammo un navilio con alcuni altri mercatanti, la qual sorte di navilii si chiamano chiampane, che sono piane di sotto e dimandano poca acqua e portano roba assai. E passammo un golfo di dodeci over quindeci leghe, dove avemmo grandissimo pericolo, perché vi sono basse e scogli assai; pur arrivammo ad una isola chiamata Zeilan, la qual volta intorno cerca mille miglia, per relazion degli abitatori di essa.
3
Di Zeilan, dove nascono le gioie.
In questa isola di Zeilan sono quattro re, tutti gentili. Non vi scrivo le cose della detta isola tutte perché, essendo questi re in grandissima guerra tra loro, non potemmo star lì molto, e manco vedere o intendere le cose di quella. Pur, dimorativi alcuni pochi giorni, vedemmo quello che intenderete, e prima grandissima quantità di elefanti, quali nascono lì. E intendemmo che si truovan rubini duoi miglia appresso alla marina, dov’è una montagna grandissima e molto lunga, al piè della quale si truovano detti rubini. E quando uno mercante vuol trovar di queste gioie, bisogna parlar prima al re e comprar un braccio di detta terra per ogni verso, il qual braccio si chiama un molan, e compralo per cinque ducati. E quando poi cava detta terra, vi sta un uomo di continuo ad instanzia del re, e ritrovandosi alcune gioie che passino dieci caratti, il re le vuol per sé e tutto il resto glielo lascia franco. Quivi ancora appresso al detto monte, dov’è una grandissima fiumara, nasce molta quantità di granate, zafiri, iacinti e topacii. Nascono in questa isola li miglior frutti che mai abbia visto, e massime certi carciofoli migliori che li nostri, aranzi dolci, li migliori che siano al mondo, e altri frutti assai ad usanza di Calicut, ma molto più perfetti.
4
Dell’arboro della cannella, e del monte dove Adam stette a far penitenzia, e delli re di Zeilan e delli costumi e usanze loro.
L’arboro della cannella è proprio come il lauro, massime la foglia, e fa alcuni grani come il lauro, ma sono più piccoli e più bianchi. La detta cannella, over cinnamomo, è scorza di detto arboro, in questo modo: ogni tre anni tagliano li rami del detto arboro, poi levano la scorza di que’ rami, ma il piede non lo tagliano per niente. Di questi arbori ve ne sono in grandissima quantità, e quando raccolgono la cannella, non ha allora quella perfezione che ha di lì ad un mese.
Un Moro mercante ci disse che in cima di quella grandissima montagna è una caverna, alla quale una volta l’anno andavano tutti gli uomini di quel paese a far orazione, per rispetto che dicono che ‘l nostro primo padre Adam stette ivi dentro a piagnere e far penitenzia dapoi che ‘l peccò, e che Iddio li perdonò: e che ancora si veggono le pedate de’ suoi piedi, e che sono cerca duoi palmi lunghe.
In questo paese non nasce riso, ma li viene di terra ferma; li re di questa isola sono tributarii del re di Narsinga, per rispetto del riso che li viene di terra ferma. Quivi è buonissimo aere, e le genti sono di color lionato scuro, e non vi è troppo caldo né troppo freddo. L’abito suo è all’apostolica, portano certi panni di bombagio overo di seta e vanno pur scalzi. È posta questa isola lontana dalla linea equinoziale per sette in otto gradi, e gli abitanti suoi non sono molto bellicosi. Qui non si usa artiglierie, ma hanno alcune lance e spade, le qual lance sono di canna, e con quelle combattono fra loro: ma non se ne ammazzano troppo di essi, perché sono vili. Qui sono rose e fiori di ogni sorte tutto il tempo dell’anno, e le genti scampano più longamente di noi.
Essendo una sera nella nostra nave, venne uno uomo da parte del re al mio compagno e disse che li portasse li suoi coralli e zaffarano, che dell’uno e l’altro ne avea gran quantità. Udendo queste parole, uno mercatante di detta isola, il quale era moro, gli disse secretamente: “Non andate dal re, perché vi pagherà al modo suo le robbe vostre”. E questo disse con malizia, a fine che ‘l mio compagno si partisse, perch’egli avea la detta mercanzia. Pur fu risposto al messo del re che ‘l giorno seguente andaria a sua signoria, e la mattina prese un navilio e per forza di remi passammo in terra ferma.
5
Di Paleachate, terra dell’India.
Arrivammo ad una terra la qual si chiama Paleachate in tempo di tre giorni, la qual è sottoposta al re di Narsinga. Questa terra è di grandissimo traffico di mercanzie, e massime di gioie, perché qui vengono da Zeilan e da Pegu; vi stanno ancora molti gran mercatanti mori d’ogni sorte di speziarie. Noi alloggiammo in casa d’un dei detti mercatanti, e li dicemmo donde venivamo, e che noi avevamo molti coralli da vendere e zaffarano e molto velluto figurato e molti coltelli: il detto mercatante, intendendo noi avere tal mercanzie, ne prese gran piacere. Questa terra è abbondantissima d’ogni cosa a usanza d’India, ma non vi nasce grano; di riso che raccogliono ne hanno grande abbondanzia. La legge, il viver, l’abito e i costumi sono ad usanza di Calicut, e sono genti bellicose, ancora che non abbiano artigliaria alcuna. E perché questa terra era in gran guerra col re di Tarnassari, a noi non parve di dimorar molto tempo, ma stati che fummo certi pochi giorni, pigliammo poi il nostro cammino verso la città di Tarnassari, ch’è distante cento miglia di lì, alla qual arrivammo in quattordici giorni.
6
Di Tarnassari, città d’India.
La città di Tarnassari è posta presso al mare, ed è terra piana e ben murata, e ha un buon porto, cioè una fiumara, dalla banda verso tramontana. Il re di questa città è gentile ed è potentissimo signore, e di continuo combatte col re di Narsinga e col re di Banghalla. E ha costui cento elefanti armati, i quali sono maggiori che mai vedessi, e tiene di continuo centomila uomini, parte a piedi e parte a cavallo, per combattere. L’armatura sua sono spade piccole e alcune sorti di rotelle, delle quali alcune son fatte di scorze di testuggini e alcune ad usanza di Calicut; hanno gran quantità di archi e lance di canna, e alcune ancora di legno, e quando vanno in guerra portano addosso una vesta piena di bombagio, molto forte imbottita. Le case di questa città sono ben murate; il sito suo è bonissimo ad usanza de’ cristiani, e vi nasce ancora di buon grano e bombagio. Quivi ancora si fa seta in grandissima quantità; verzino vi si truova assai e frutti in gran copia, e alcuni a modo di pomi e peri nostri, e aranci, limoni, cedri e zucche abbondantemente. Qui si veggono giardini bellissimi, con molte gentilezze dentro.
7
Degli animali domestichi e salvatichi di Tarnassari.
In questo paese di Tarnassari sono buoi, vacche, pecore e capre in gran quantità, porci salvatichi, cervi, caprioli, lupi, gatti che fanno il zibetto, lioni, pavoni in gran moltitudine, falconi, astori, pappagalli bianchi e di un’altra sorte, che sono di sette colori bellissimi. Qui sono lepori, starne non al modo nostro. V’è ancora qui un’altra sorte di uccelli pur di rapina, assai più grandi che non è una aquila, del becco de’ quali, cioè della parte di sopra, se ne fanno manichi di spada e di coltelli: il qual becco è giallo e rosso, cosa molto bella da vedere; il color del detto uccello è negro e rosso, e ha alcuna penna bianca. Qui nascono le maggior galline e galli che mai abbia visto, in modo che una di quelle è maggior che tre delle nostre.
In questa terra in pochi giorni avessemo gran piacere di alcune cose che vedemmo, e massime che ogni giorno, nella strada dove stanno li mercatanti mori, si fanno combattere alcuni galli, e li patroni di quelli galli giuocano cento ducati a chi meglio combatterà. E vedemmo combattere a duoi cinque ore di continuo, in modo che alla fine tutti duoi rimason morti. Qui ancora si truova una sorte di capre molto maggior delle nostre, e sono assai più belle, le quali fanno sempre quattro capretti ad un parto. Si vendono qui dieci e dodeci castrati grandi buoni per uno ducato; vi si truova ancora un altra sorte di castrati, li quali hanno le corna a modo di un daino: questi sono maggiori delli nostri e combattono terribilmente. Qui sono buffali molto più deformi delli nostri, ed evvi gran quantità di pesci buoni ad usanza nostra; viddi pur qui un osso di pesce il qual passava più di dieci cantara
Quanto al vivere di questa città, li gentili mangiano d’ogni carne, eccetto bovina, e mangiano in terra senza tovaglia in alcuni vasi di legno bellissimi; il ber loro è acqua, inzuccarata chi può. Il dormir loro è alto da terra, in buoni letti di bombagio e coperte di seta o di bombagio. L’abito di costoro è questo: vanno all’apostolica, con un panno imbottito di bombagio overo di seta; alcuni mercatanti portano bellissime camicie di seta overo di bombagio. Generalmente non portano niente in capo, eccetto li Bramini, li quali portano una berretta di seta o vero ciambellotto, la quale è lunga duoi palmi. Nella detta berretta portano una cosa fatta a modo d’una ghianda, la quale è lavorata tutta intorno d’oro; portano ancora due stringhe di seta larghe più di duoi dita, le quali gli pendono sopra il collo, e portano l’orecchie piene di gioie, e in dita non ve ne portano alcuna. Il colore di detta generazione è mezzo bianco, perché qui è l’aere un poco più freddo che non è in Calicut, e la stagione è ad usanza nostra, e similmente le raccolte.
8
Come il re fa svirginare la sua moglie, e così tutti gli altri gentili della città.
Il re di detta città non fa sverginar la sua moglie alli Bramini come fa il re di Calicut, anzi la fa svirginare ad uomini bianchi, o siano cristiani o mori, pur che non siano gentili. I quali gentili ancor loro, innanzi che menino la sposa a casa sua, trovano un uomo bianco, sia di che lingua si voglia, e lo menano a casa loro pur a questo effetto, per far svirginare la moglie. E questo intravenne a noi quando arrivammo alla detta città. Per buona ventura scontrammo tre o 4 mercatanti, li quali cominciorono a parlare col mio compagno in questo modo: “Amico, sete voi forestiero?” Egli rispose: “Sì”. Dissero li mercatanti: “Quanti giorni sono che sete in questa terra?” Gli rispondemmo: “Sono quattro giorni che noi siamo venuti”. E così uno di quelli mercatanti disse: “Venite a casa mia, che noi siamo grandi amici di forestieri”; e noi udendo questo andammo con lui. Giunti che fummo a casa sua, egli ci dette da far collazione e poi ci disse: “Amici miei, da qui a venti giorni voglio menar la donna mia, e uno di voi dormirà con lei la prima notte e me la svirginerà”. Intendendo noi tal cosa, rimanemmo tutti vergognosi; disse allora il nostro turcimanno: “Non abbiate vergogna, che questa è l’usanza della terra”. Udendo questo, il mio compagno disse: “Non ci faccino altro male, che di questo noi ci contentaremo”. Pur pensavamo d’esser dileggiati. Il mercatante ci cognobbe che stavamo così sospesi, e disse: “O amici, non abbiate maninconia, che in questa terra si usa così”. Cognoscendo al fine noi che così era costume di questa terra, sì come ci affermava uno il quale era in nostra compagnia, e ne diceva che non avessimo paura, il mio compagno disse al mercatante che era contento di durar questa fatica. Qual gli disse: “Io voglio che stiate in casa mia e che voi e li compagni e robbe vostre alloggiate qui meco, infino a tanto che menerò la donna”. Finalmente, dopo il recusar nostro, per le tante carezze che ci faceva costui fummo astretti, 5 che eravamo, insieme con tutte le cose nostre, alloggiare in casa sua. Di lì a quindici giorni, questo mercatante menò la sposa e il compagno mio la prima notte dormitte con essa, la qual era una fanciulla bellissima di 15 anni, e servitte il mercatante di quanto gli avea richiesto. Ma dapoi la prima notte era pericolo della vita, e alla donna e a lui, se vi fusse tornato più: ben è vero che le donne nel suo intrinseco ariano voluto che la prima notte fusse durata un mese. Li mercatanti, poi che tal servigio ebbero ricevuto da noi, volentieri ci averian tenuto quattro e cinque mesi a spese loro, sì perché la robba val pochi danari, sì ancora perché sono liberalissimi e molto piacevoli uomini; pur spesso eravamo richiesti a simil servigi.
9
Come si servano li corpi morti in questa città.
Li Bramini tutti e li re dopo la morte sua si bruciano, e in quel tempo fanno un solenne sacrificio al diavolo, e poi servano quella cenere in certi vasi di terra sottili e invetriati, li quali vasi hanno la bocca stretta come una scodella piccola: e questo vaso con la cenere del corpo bruciato sotterrano poi nelle loro case. E quando fanno il detto sacrificio, lo fanno sotto alcuni arbori al modo di Calicut, e bruciando il corpo morto, accendono un fuoco delle più odoriferi cose che trovar si possono, com’è legno d’aloe, belzuì, sandalo, verzino, storace, ambra, incenso e alcuna bella grampa di coralli, le qual cose mettono sopra il corpo: il quale mentre che si brucia, tutti li sonatori della città quivi suonano con diversi instrumenti, e similmente vi sono quindeci o venti uomini vestiti a modo di diavoli, che fanno festa grandissima. E qui presente sta sempre la sua moglie, e non altra femina alcuna, faccendo grandissimi pianti e battendosi il petto. E questo si fa ad una o vero due ore di notte.
10
Come si brucia la donna viva dopo la morte del suo marito; e della prova che fa un giovene per dar ad intender che ama la sua innamorata.
In questa città di Tarnassari, poi che sono passati li quindeci giorni dapoi la morte del marito, la moglie sua fa un convito a tutti li suoi parenti e a tutti quelli del marito, e poi va con tutto il parentado dove fu bruciato il marito, pur a quella ora di notte. La detta donna si mette addosso tutte le sue gioie e altri lavori d’oro, tanto quanto val la robba sua. Dipoi li parenti suoi fanno far un pozzo alto quanto è alta la persona, e intorno al pozzo mettono quattro o cinque canne, intorno alle quali mettono un panno di seta, e nel detto pozzo fanno un fuoco delle sopradette cose che furono fatte al marito. E poi la detta donna, fornito ch’è il convito, mangia assai bietole, e ne mangia tante che la fanno uscire del sentimento. E vi sono di continuo li sonatori della città, che suonano con tutti gl’instrumenti, e sonvi ancora li sopradetti uomini vestiti da diavoli, li quali portano il fuoco in bocca, come già vi dissi in Calicut. E similmente fanno il sacrificio al Deumo, e poi la detta donna va molte volte in su e in giù ballando con le altre donne per quel luogo, e molte fiate si va a raccomandare alli detti uomini vestiti da diavoli, e gli dice che prieghino il Deumo che la voglia accettare per sua: e qui alla presenzia v’è gran quantità di donne, le quali sono sue parenti. Non crediate però che costei stia di mala voglia, anzi pare a lei che allora allora sia portata in cielo, e a qual modo volontarosamente se ne va correndo con furia, e dà delle mani nel panno predetto, e gettasi in mezzo di quel fuoco. E subito li parenti più congiunti le danno addosso con bastoni e con alcune palle di pegola, e questo fanno solo a fine che più presto muoia. E non faccendo questo, la detta donna saria tenuta fra loro come a noi una publica meretrice, e li parenti suoi la fariano morire. E in questo luogo, quando si fa tal cosa, sempre vi sta il re presente, imperoché chi fa tal morte sono li più gentili della terra, e non la fanno così tutti in generale.
Un altro costume poco manco orrendo del predetto ho veduto in questa città di Tarnassari. Sarà un giovane che parlerà con una donna di amore, e le vorrà dar ad intendere che con tutto il cuore le vuol bene e che non è cosa al mondo che per lei non facesse: e stando in questo ragionamento, piglierà una pezza ben bagnata nell’olio, e appicciali dentro il fuoco e se la pone sopra il braccio a carne nuda, e mentre che quella brucia, egli sta a parlare quietamente con quella donna e senza una minima perturbazione, non si curando che s’abbruci il braccio, per dimostrar a colei che gli vuol bene e che per lei è apparecchiato a fare ogni gran cosa.
11
Della giustizia che si osserva in Tarnassari e di molti altri costumi.
Chi ammazza altri in questo paese, lui è moro alla usanza di Calicut. Del dar poi e dell’avere, bisogna che appara per scrittura overo per testimonio, e lo scriver loro è in carta come la nostra, e non in foglio d’arboro come in Calicut: poi vanno al governatore della città, il qual fa ragion sommaria. Ma pur, quando muore alcun mercatante forestiero che non abbia moglie o figliuoli, non può lasciar la robba sua a chi li piace, perché ‘l re vuol esser lui erede. E in questa terra, cioè li nativi di lì, cominciando dal re, dapoi la morte sua il figliuolo riman erede. E quando muore alcun mercatante moro, si fa grandissima spesa in cose odorifere per conservare quel corpo, qual mettono in una cassa di legno e poi la sotterrano, ponendo la testa verso la Mecca, che viene ad esser verso ponente. E avendo il morto figliuoli, rimangono eredi.
12
Delli navilii che usano in Tarnassari.
Hanno queste genti in uso loro grandissimi navilii di più sorti, delli quali una parte sono fatti piani di sotto, perché quelli di tal sorte vanno in alcuni luoghi dove è poca acqua; un’altra sorte sono fatti con la pruova dinanzi e di drieto, e portano duoi timoni e duoi arbori, e sono senza coperta. V’è ancora un’altra sorte di navi grandi, le quali si chiamano giunchi, e queste sono di mille botte l’una, sopra le quali portano alcuni navilii piccoli, per poter andar ad una città chiamata Malacca, e vi vanno con que’ navilii piccoli per le spezie minute, come intenderete quando sarà tempo.
13
Della città Banghalla, e quanto è distante da Tarnassari, e delle mercanzie che in quella si trovano.
Torniamo al mio compagno, ch’egli e io avevamo desiderio di veder più avanti. Dapoi alquanti giorni che fummo stati in questa città, stracchi già di simil servizio che disopra avete inteso, e vendute alcune parti delle nostre mercanzie, pigliammo il cammino verso la città di Banghalla, la quale è distante da Tarnassari settecento miglia, alla quale noi arrivammo in undeci giornate per mare. Questa città è una delle migliori che ancora abbia visto e ha un grandissimo reame. Il soldano di questo luogo è moro e fa dugentomila uomini da combattere a piedi e a cavallo, e sono tutti maumettani, e combatte di continuo col re di Narsinga. Questo reame è il più abbondante di grano, di carni d’ogni sorte, di gran quantità di zuccari, similmente di zenzero e di molta copia di bombagio, più che terra del mondo, e qui sono i più ricchi mercatanti che mai abbia trovato. Si carica in questa terra ogni anno cinquanta navilii di panni di bombagio e di seta, li quali panni sono questi, cioè bairami, namone, lizari, ciantari, doazar e sinabaffi: questi tali panni vanno per tutta la Turchia, per la Soria e per la Persia, per l’Arabia Felice e per tutta l’India. Sono ancora quivi grandissimi mercatanti di gioie, le quali vengono d’altri paesi.
14
Di alcuni mercatanti cristiani in Banghalla.
Trovammo ancora qui alcuni mercatanti cristiani, che dicevano esser d’una città chiamata Sarnau, li quali avevano portato a vender panni di seta, legno d’aloe, verzino e muschio, li quali dicevano che nel paese suo erano molti signori pur cristiani, ma sono sottoposti al gran cane del Cataio. L’abito di questi cristiani era veste di ciambellotto, fatte con falde, e le maniche erano imbottite di bombagio, e in testa portavano una berretta lunga un palmo e mezzo, fatta di panno rosso. E questi tali sono bianchi come noi e confessano esser cristiani, e credono nella Trinità e similmente nelli dodeci apostoli, negli evangelisti, e ancora hanno il battesimo con acqua; ma loro scrivono al contrario di noi, cioè al modo di Armenia. E dicevano guardare la natività e passione di Cristo, e facevano la nostra quaresima e molte altre vigilie infra l’anno. Questi cristiani non portano scarpe, ma portano alcuni calzoni di seta fatti ad usanza di marinari, li quali calzoni sono tutti pieni di gioie, e nelle mani portano molte gioie. Costoro mangiano in tavola ad usanza nostra, e mangiano d’ogni sorte di carne. Dicevano ancora questi che alli confini de’ Rumi, cioè del gran Turco, vi sono grandissimi re cristiani
Dopo il molto ragionare con questi, alla fine il mio compagno mostrò loro la mercanzia sua, fra la quale v’erano certe belle grampe e grandi di coralli. Visto ch’ebbero quelle grampe, ne dissero che se volevamo andare ad una città, dove loro ne menariano, che li bastava l’animo farne avere diecimila ducati per quelle, overo tanti rubini che in Turchia valeriano centomila ducati. Rispose il mio compagno ch’era molto contento, pur che si partissero presto de lì. Dissero li cristiani: “Di qui a duoi giorni si parte una nave, la quale va alla volta di Pegu, e noi abbiamo ad andare con essa. Se voi volete venire, vi condurremo volentieri”. Udendo noi questo, ci mettemmo in ordine e montammo in nave con li detti cristiani e con alcuni altri mercatanti persiani. E perché avemmo notizia in questa città che quelli cristiani erano fidelissimi, prendemmo grandissima amicizia con loro; ma innanzi la partita nostra di Banghalla, vendemmo tutto il resto della mercanzia salvo li coralli e il zaffarano e due pezze di rosato di Fiorenza.
Lasciamo questa città, la qual credo che sia la migliore del mondo, cioè per vivere. Nella qual città la sorte delli panni che avete inteso di sopra non li filano le donne, ma li filano e tesseno gli uomini. Noi si partimmo di qui con li detti cristiani e andammo alla volta della detta città, che si chiama Pegu, distante da Banghalla cerca mille miglia; infra il qual viaggio passammo un colfo verso mezzogiorno, e così arrivammo alla città di Pegu.
15
Di Pegu, città d’India.
La città di Pegu è in terra ferma e appresso il mare. A man manca di questa, cioè verso levante, è una bellissima fiumara, per la quale vanno e vengono molti navilii. Il re di detta città è gentile. La fede, i costumi, il vivere e l’abito sono ad usanza di Tarnassari, ma del colore sono alquanto più bianchi, e qui ancora l’aere è alquanto più freddo; le stagioni loro sono al modo nostro. Questa città è murata e ha buone case e palazzi fatti di pietra con calcina. Il re è potentissimo d’uomini da piede e da cavallo, e tiene con lui più di mille cristiani del paese che disopra è stata fatta menzione; dà a ciascuno per soldo 6 pardai d’oro al mese e le spese. In questo paese è grande abbondanzia di grano, di carne d’ogni sorte, di frutti a usanza di Calicut. Non hanno costoro troppi elefanti, ma di tutti gli altri animali sono abbondanti; hanno ancora di tutte le sorti di uccelli che si truovano in Calicut, ma qui sono li più belli e li miglior pappagalli che mai abbia visto. Si truovano qui in gran quantità legnami lunghi, e li più grossi credo che sia possibile a trovare; similmente non so se al mondo si trovino le più grosse canne di quelle che qui si trovano, delle quali ne viddi alcuna che veramente era grossa quanto uno barile. Sono in questo paese grandissima copia di gatti di zibetto, delli quali se ne danno 3 o 4 al ducato. Le mercanzie di costoro sono solamente gioie, cioè rubini, li quali vengono da un’altra città verso levante chiamata Capellan, distante da questa 30 giornate: non però ch’io l’abbia vista, ma per relazion di mercatanti. Sappiate che in detta città vale più un diamante e perle grosse che non vagliono qui da noi, e similmente un smeraldo.
Quando arrivammo a questa terra, il re era 15 giornate lontano di lì a combattere con un altro, il qual si chiama re di Ava. Vedendo noi questo, deliberammo andar a trovar il re dove era, per darli quelli coralli, e così partimmo di qui con un navilio tutto d’un pezzo e lungo più di quindeci overo sedeci passi; li remi di questo navilio erano tutti di canna. Il modo veramente come siano fatti è questo: dove il remo piglia l’acqua è sfesso, e vi mettono una tavola cucita di corde, per modo ch’el detto navilio andava più forte che non va un brigantino; l’arboro suo era una canna grossa come un barile dove si mettono le alice. Noi arrivammo in tre giornate ad uno villaggio, dove trovammo certi mercatanti li quali non avevano potuto entrare nella detta città di Ava, per rispetto della guerra. Intendendo noi questo, insieme con loro tornammo a Pegu. De lì a cinque giorni tornò il re alla detta città, il quale aveva avuto vettoria del suo nimico. Il secondo giorno dapoi ritornato il re, li nostri compagni cristiani ne menorono a parlare con lui.
16
L’abito del re di Pegu, e della liberalità sua che gli usò in comprar alcuni coralli.
Non crediate che ‘l re di Pegu stia in tanta riputazione come sta il re di Calicut, anzi è tanto umano e domestico che un fanciullo li potria parlare. Porta più pietre preziose e massimamente rubini adosso che non vale una città grandissima, conciosiacosaché ve ne siano in tutte le dita de’ piedi, e nelle gambe porta alcuni manigli d’oro grossi, tutti pieni di bellissimi rubini e perle. Similmente le braccia e le dita delle mani tutte sono piene, le orecchie pendono mezzo palmo per il contrapeso di tanti gioie che vi sono attaccate, per modo che, vedendo la persona del re al lume di notte, luce che pare un sole.
Li detti cristiani parlorono con lui e li dissero della mercanzia nostra; il re li rispose che tornassimo a lui passato il dì seguente, perché avea da far sacrificio al diavolo per la vettoria conseguita. Passato il detto tempo, subito che ebbe mangiato, il re mandò per li detti cristiani e per il compagno mio, che li portasse la sua mercanzia. Questo re, veduta tanta bellezza di coralli, rimase stupefatto e fu molto contento, perché veramente, infra gli altri coralli, ve n’erano due branche che mai non andorono in India le simili. Dimandò il re che gente eravamo; risposero li cristiani: “Signore, questi sono Persiani”. Disse il re al turcimanno: “Dimandagli se vogliono vendere questa roba”. Il mio compagno rispose che la roba era al comando di sua signoria. Allora il re cominciò a dire che era stato duoi anni in guerra col re di Ava e che per questo rispetto non si trovava danari, ma che, se volevamo barattar in tanti rubini, che ‘l ne contentaria molto bene. Li facemmo dire per quei cristiani che non volevamo altra cosa da lui salvo l’amicizia sua, e che pigliasse la roba e facesse quanto li piaceva. Li cristiani gli riferirono quanto li aveva imposto il compagno, con dire al re che pigliasse li coralli senza danari e senza gioie. Intendendo egli questa liberalità, rispose: “Io so ben che li Persiani sono liberalissimi, ma non viddi mai un tanto liberale quanto è costui”. E giurò per Dio e per il diavolo che ‘l voleva vedere chi saria più liberale, o egli o il Persiano, e comandò subito ad un suo schiavo che portasse una certa cassetta, la qual era lunga e larga duoi palmi, lavorata d’oro intorno intorno, ed era piena di rubini dentro e fuori. E aperta che l’ebbe, vi stavano sei tramezzate stanzie, tutte piene di diversi rubini grandi e piccoli, finissimi, e posela innanzi a noi, dicendo che pigliassemo quelli che volevamo. Rispose il mio compagno: “O signor benigno, tu mi usi tanta gentilezza che, per la fede ch’io porto a Macometto, io ti fo un presente di tutta questa roba; e sappi, signore, ch’io non vo per il mondo per acquistar roba, ma solo per veder varie genti e varii costumi”. Rispose il re: “Io non ti posso vincere di liberalità, ma piglia questo ch’io ti do”. E così pigliò un buon pugno di rubini per ciascuna di quelle stanzie della cassetta e gliene donò: questi rubini potevano esser cerca dugento; e dandogliene gli disse: “Piglia questi, per la liberalità che mi hai usato”. E similmente donò alli detti cristiani duoi rubini per ciascuno, li quali furono stimati mille ducati; e quelli del mio compagno furono stimati cerca centomila ducati, onde a questo si può considerare costui essere il più liberale re che sia nel mondo. E ha ogni anno cerca un milion d’oro di rendita, e questo perché nel suo paese si trova molta lacca, molto sandolo, assai verzino, bombagio e seta in gran quantità: e tutte le sue entrate dona a’ soldati. Le genti in questo paese sono molto lussuriose.
Passati alquanti giorni, li detti cristiani pigliorono licenzia per loro e per noi. Il re comandò che ci fusse data una stanzia fornita di ciò che bisognava, insino a tanto che noi volevamo star lì: e così fu fatto. Noi stemmo in detta stanzia cinque giorni. In questo tempo venne nuova ch’el re Ava veniva con grande esercito per far guerra con lui, il quale, intendendo questo, volse andar a trovarlo alla metà del cammino con molta gente a cavallo e a piedi. Il dì dipoi vedemmo abbruciare due donne vive volontariamente, in quel modo ch’io vi dichiarai in Tarnassari.
17
Della città Malacha e di Gaza fiumara, che alcuni pensano sia Ganges, e della inumanità di quegli uomini.
L’altro giorno montammo su una nave e andammo ad una città chiamata Malacha, qual è posta alla volta di sirocco levante: e vi arrivammo in otto giorni. Appresso alla detta città trovammo una grandissima fiumara, della quale mai non vedemmo la maggiore, e chiamasi Gaza, e mostra esser larga più di quindeci miglia. E a riscontro alla detta fiumara è una grandissima isola chiamata Sumatra: dicono gli abitatori di questa isola ch’ella volta intorno quattromila e cinquecento miglia; quando sarà tempo vi dirò della sua condizione.
Arrivati che fummo a Malacha, subito fummo appresentati al soldano, il qual è moro, e similmente tutto il suo regno. La detta città è in terra ferma e paga tributo al re delle Cine, il qual fece edificar questa terra già cerca settanta anni, per esser ivi buon porto, il qual è il principale che sia nel mare Oceano: e veramente credo che qui arrivano più navilii che in terra del mondo, e massime perché qui vengono tutte le sorti di spezie e altre mercanzie assaissime. Questo paese non è molto fertile: pur vi nasce grano, carne, poche legne, uccelli al modo di Calicut. Qui si trova gran quantità di sandolo e di stagno; vi sono ancora elefanti assai, cavalli, pecore, vacche e buffali, leopardi e pavoni in molta copia, frutti pochi ad usanza di Zeilam. Non bisogna far traffico qui di cosa alcuna, salvo che di speziarie e panni di seta. Queste genti sono di colore olivastro e portano i capelli longhi; l’abito suo è al modo del Cairo. Hanno costoro il viso largo, l’occhio tondo, il naso ammaccato. Qui non si può andar per la terra come è notte, perché si ammazzano a modo di cani, e tutti li mercatanti che arrivano qui vanno a dormire nelli loro navilii. Gli abitatori di questa città sono di nazione e origine di quelli della Giava. Il re tiene un governatore per far ragione a’ forestieri, ma quelli della terra si fan ragione a posta loro, e sono la peggior generazione e dei più pessimi costumi che sia credo al mondo; e sono tanto superbi e crudeli che, se alcuna volta il re gli vuol punire, essi dicono che disabiteranno la terra, perché sono uomini di mare e facilmente passariano sopra qualche isola. L’aere quivi è assai temperato.
Li cristiani ch’erano in nostra compagnia ci fecero intendere che qui non era troppo da stare, per esser così mala gente: per tanto pigliammo un giunco e andammo alla volta di Sumatra, ad una città chiamata Pedir, la qual è distante da terra ferma ottanta leghe in cerca.
18
Di Sumatra isola, la qual anticamente si chiamava Taprobana, e di Pedir, porto e città in Sumatra.
In questa terra dicono che v’è il miglior porto di tutta l’isola, qual già vi dissi che volge intorno 4 mila e cinquecento miglia. Al parer mio (come ancor molti dicono) credo che sia la isola Taprobana, nella quale sono tre re di corona, li quali sono gentili: e la fede loro, il viver, l’abito e i costumi sono propriamente come in Tarnassari, e così si bruciano le donne vive. Gli abitanti in questa isola sono di colore quasi bianchi, e hanno il viso largo, gli occhi tondi e verdi, i capelli lunghi, il naso largo ammaccato, e piccoli di statura. Qui si fa grandissima giustizia al modo di Calicut. Le sue monete sono oro, argento e stagno, tutte stampate: e la moneta d’oro ha da una faccia un diavolo e dall’altra v’è a modo d’un carro tirato da elefanti, e similmente le monete d’argento e di stagno. Di quelle d’argento ne vanno dieci al ducato e di quelle di stagno ne vanno venticinque. Qui nasce grandissima quantità di elefanti, li quali sono li maggiori che mai vedessi. Queste genti non sono bellicose, ma attendono alle sue mercanzie, e sono molto amici de’ forestieri.
19
D’un’altra sorte di pepe e di seta e di belzuì, li quali nascono nella detta città di Pedir.
In questo paese di Pedir nasce grandissima quantità di pepe, qual è lungo, che chiamano molaga. La sorte del detto pepe è più grosso di questo che vien qui da noi, ed è più bianco assai, e di dentro è vano, ed è tanto mordente come questo nostro e pesa molto poco: e vendesi qui a misura, come da noi si vende la biava. Ed è da sapere che in questo porto se ne carga ogni anno 18 over venti navi, le quali tutte vanno alla volta del Cataio, dove si vende molto bene, perché dicono che là cominciano a far grandissimi freddi. L’arboro che produce questo pepe lungo ha le viti più grosse, e la foglia più larga e più pastosa, che non ha quello che nasce in Calicut. Si fa in questa terra assaissima seta, e fassene ancor fuori per li vermi ne’ boschi sopra gli arbori, senza esser nutriti dalle persone: vero è che questa seta non è molto buona. Trovasi ancora qui gran quantità di belzuì, il quale è gomma d’arbori: dicono alcuni (perché io non l’ho visto) che nasce molto distante dalla marina, in terra ferma.
20
Di tre sorti di legno d’aloe.
Perché la verità delle cose è quella che più diletta e invita l’uomo sì a leggere come ancora ad intendere, però mi ha parso soggiunger questo, di che io per esperienza ne ho certezza: per tanto sappiate che né belzuì né legno d’aloe che sia eccellente non vien troppo nelle parti de’ cristiani, conciosiacosaché sono tre sorti di legno d’aloe. La prima sorte, che è la più perfetta, si chiama calampat, il quale non nasce in questa isola, ma viene da una chiamata Sarnau, la quale (sì come dicevano li cristiani nostri compagni) è appresso la città loro: e ivi nasce questa prima sorte. La seconda sorte si chiama loban, il qual viene da una fiumara; il nome della terza si chiama bochor. Ci dissero ancora li detti cristiani la cagione perché non viene da noi il detto calampat, la qual è questa, che nel gran Cataio e nel reame delle Cine e Macini e Sarnau e Giava vi è molto più abbondanzia d’oro che appresso noi, e similmente vi sono più gran signori che non sono nelle bande nostre di qua, quali si dilettano molto più che noi di queste due sorti di profumi, di modo che, doppo la morte loro, spendono grandissima quantità d’oro in essi profumi: e per questa tal causa non vengono nelle nostre parti queste sorti così perfette. E vale in Sarnau dieci ducati la libbra, perché se ne trova poco di questo.
21
Della esperienza di detti legni aloe e belzuì.
Li prefati cristiani ci fecero vedere la esperienza di ambedue le sorti di profumi: l’uno di essi avea un poco dell’una e l’altra sorte. Il calampat era cerca due once, e fecelo tenere in mano al mio compagno tanto quanto si diria quattro volte il Miserere, tenendolo stretto in mano; dipoi li fece aprir la mano: veramente non senti’ mai simil odore quanto era quello, il qual passava tutti i nostri profumi. Poi prese tanto belzuì quanto saria una noce, e poi di quello che nasce in Sarnau circa mezza libbra, e fecelo mettere in due camere in vasi con fuoco dentro: in verità vi dico che quel poco fece più odore e maggior suavità e dolcezza che non fariano due libbre d’altra sorte. Non si potria dir la bontà di quelle due sorti di odori e de profumi. Sì che avete inteso la ragione perché le dette cose non vengono alle parti nostre. Nasce ancora qui grandissima quantità di lacca per far color rosso, e l’arboro di questa è fatto come li nostri arbori che producono le noci.
22
Delli lavori che si fanno in Sumatra, e delli costumi degli abitatori, e della sorte de’ navilii loro.
In questa terra viddi li più belli lavori che mai abbia visto, cioè alcune casse lavorate d’oro, le quali davano per duoi ducati l’una, che in verità da noi saria stimata cento ducati. Quivi ancora viddi in una strada cerca cinquecento cambiatori di monete, e questo perché vengono grandissima quantità di mercatanti in questa città, dove si fanno assaissimi traffichi. Il dormir di queste genti sono buoni letti di bombagio, le coperte di seta e lenzuoli di bombagio. Hanno in questa isola abbondanzia grandissima di legnami, e qui fanno gran navi, le quali chiamano giunchi, e portano tre arbori, e hanno la prova davanti e di drieto, con duoi timoni davanti e duoi di drieto. E quando navigano per alcuno arcipelago, perché qui è gran pelago a modo d’un canale, andando a vela alcuna volta li viene il vento davanti: subito amainano la vela e prestamente, senza voltare, fanno vela all’altro arboro e tornano adrieto. E sappiate che sono li più presti uomini che mai abbia veduto, e ancora sono grandissimi notatori e maestri eccellentissimi di far fuochi artificiati.
23
Come cuoprono le case in Sumatra; e di duoi navilii che comprorono per andar all’isole delle spezierie, e de varii ragionamenti che ebbero insieme.
Le abitazioni del detto luogo sono case murate di pietra, e non sono molto alte, e gran parte d’esse sono coperte di scorze di tartaruche di mare, cioè bisce scodellaie, perché qui se ne ritruova gran quantità: e nel tempo mio viddi pesarne una che pesava cento e tre libbre. Ancora viddi duoi denti di elefanti, li quali pesavano trecento e venticinque libbre; e viddi pur in questa isola serpenti maggiori assai che non sono quelli di Calicut.
Torniamo alli nostri compagni cristiani, li quali erano desiderosi di tornare alla sua patria, perché ne dimandorono che intenzione era la nostra, se noi volevamo restar qui o andar più avanti overo ritornar indrieto. Li rispose il mio compagno: “Dapoi ch’io son condotto dove nascono le speziarie, vorrei vederne alcune sorti avanti ch’io ritornasse indrieto”. Loro li dissero: “Qui non nascono altre spezie, salvo quelle che avete veduto”. Ed egli dimandò: “Dove nascono le noci moscate e li garofani?” Li risposero che le noci moscate e macis nascono ad una isola distante de qui per trecento miglia. Li dimandammo allora se si poteva andare a quella isola sicuramente, cioè securi da ladri o corsari; li cristiani risposero che securi da ladri potevamo andare, ma dalla fortuna da mare no, e dissero che con queste navi grandi non si poteva andare alla detta isola. “Che rimedio adunque vi saria, – disse il mio compagno, – per andare a questa isola?” Ci risposero che bisognava comprare una ciampana, cioè un navilio piccolo, delli quali se ne trovano qui assai. Il mio compagno li pregò che ne facessero venir dua, che li compraria. Subito li cristiani ne trovorono duoi forniti di genti che li avevano a guidare, con tutte le cose necessarie e opportune a far tal viaggio, e fecero mercato di detti navilii con gli uomini e cose bisognose in quattrocento pardai, li quali allora furono pagati dal compagno mio. Il quale poi cominciò a dire alli cristiani: “O amici miei carissimi, benché io non sia di vostra generazione, nondimeno tutti siamo figliuoli di Adam ed Eva: volete voi abbandonar me e questo altro mio compagno, il quale è nasciuto nella vostra fede?” “Come nella nostra fede? – dissero li cristiani: – Questo vostro compagno non è persiano?” Rispose egli: “Adesso sì ch’è persiano, perché fu comprato alla città di Ierusalem”. Sentendo li cristiani nominare Ierusalem, subito levorono le mani al cielo e poi baciorono tre volte la terra, e dimandorono di che tempo era quando fui venduto in Ierusalem. Li risposi che io avea cerca quindici anni. “Adunque, – dissero costoro, – egli si debbe ricordare del suo paese”. “Sì ben, – disse il mio compagno, – ch’ei si ricorda, anzi non ho avuto altro piacere, già sono molti mesi, se non d’intendere delle cose di quel suo paese, ed egli m’ha insegnato come si chiama dalli cristiani tutti li membri della persona, e il nome delle cose da mangiare”. Udendo questo, li cristiani dissero: “La volontà nostra era di ritornare alla patria, la qual è tremila miglia lontana di qui; ma per amor vostro e di questo vostro compagno volemo venire dove voi anderete, e volendo restare il vostro compagno con noi, lo farem ricco, e se vorrà servare la legge persiana, sarà in sua libertà”. Rispose il mio compagno: “Io son molto contento della compagnia vostra, ma non v’è ordine che costui resti con voi, perché io gli ho dato una mia nipote per moglie, per l’amor ch’io li porto: si che, se volete venir in nostra compagnia, voglio prima che pigliate questo presente ch’io vi do, altrimenti non restaria mai contento”. Li buoni cristiani risposero ch’ei facesse quello che a lui piaceva, che di tutto si contentavano, e così lui li donò mezza curia, cioè mezza oncia di rubini, delli quali ve ne erano dieci di valore di cinquecento pardai. De lì a due giorni furono apparecchiate le dette chiampane, e ponemmovi dentro di molte robe da mangiare, massime delli migliori frutti che mai abbia gustato, e così pigliammo il nostro cammino per levante verso l’isola chiamata Bandan.
24
Dell’isola di Bandan, dove nascono le noci moscate e macis.
Infra il detto cammino trovammo cerca venti isole, parte abitate e parte no, e in spazio di quindici giorni arrivammo alla detta isola, la qual è molto brutta e trista; è di circuito cerca cento miglia ed è terra molto bassa e piana. Qui non v’è né re né governatore, ma vi sono alcuni villani quasi come bestie, senza alcun ingegno. Le case di questa isola sono di legname, molto triste e basse. L’abito di costoro è che vanno in camicia, scalzi, senza alcuna cosa in testa; portano li capelli lunghi, il viso loro è largo e tondo, il suo colore è bianco e sono piccoli di statura. La sua fede è gentile, ma sono di quella sorte che sono li più tristi di Calicut, chiamati Poliar e Hitava; sono molto debili d’ingegno e di forza, non hanno alcuna virtù, ma vivono come bestie. Qui non nasce altre cose che noci moscate: il piede della noce moscata è fatto a modo di uno arboro persico e fa la foglia in quel modo, ma sono più strette, e avanti che la noce abbia la sua perfezione, li macis stanno intorno come una rosa aperta, e quando la noce è matura il macis l’abbraccia. E così la colgono del mese di settembre, perché in questa isola va la stagione come a noi; e ciascun uomo raccoglie più che può, perché tutte sono comuni, e a detti arbori non si dura fatica alcuna, ma lasciano fare alla natura. Queste noci si vendono a misura, la qual pesa ventisei libbre, per prezzo di mezzo carlino: la moneta corre qui ad usanza di Calicut. Qui non bisogna far ragione, perché la gente è tanto grossa che, volendo, non saperiano far male.
E in termine di duoi giorni disse il mio compagno alli cristiani: “Li garofani dove nascono?” Risposero che nascevano lontano da qui sei giornate, in una isola chiamata Maluch, e che le genti di quella sono più bestiali e più vili e dappoche che non sono queste di Bandan. Alla fine deliberammo di andar a quell’isola, fussero le genti come si volessero, e così facemmo vela e in dodici giorni arrivammo alla detta isola.
25
Dell’isola di Maluch, dove nascono li garofani.
Smontammo in questa isola di Maluch, la qual è molto più piccola di Bandan, ma la gente è peggiore, e vivono pur a quel modo, e sono più bianchi, e l’aere è un poco più freddo. Qui nascono li garofani e in molte altre isole circonvicine, ma sono piccole e disabitate. L’arboro delli garofani è proprio come l’arboro del busso, cioè così folto, e la sua foglia è quasi come quella della cannella, ma un poco più tonda, ed è di quel colore come già vi dissi in Zeilan, la qual è quasi come la foglia del lauro. Quando sono maturi, li detti uomini sbattono li garofani con le canne, e mettono sotto al detto arbore alcune stuore per raccoglierli. La terra dove sono questi arbori è come arena, cioè di quel medesimo colore, non però che sia arena. Il paese è volto verso mezzodì, e di qui non si vede la stella tramontana.
Veduto che avemmo questa isola e questa gente, dimandammo alli cristiani se altro v’era da vedere. Ci risposero: “Vediamo un poco in che modo vendono questi garofani”. Trovammo che si vendevano il doppio più che le noci moscate, pure a misura, perché quelle persone non intendono pesi.
26
Della isola Bornei.
Volontarosi eravamo di mutar paese, pur tuttavia per imparar cose nove. Allora dissero li cristiani: “O caro compagno, dapoi che Dio ci ha condotti fin qui a salvamento, se vi piace andiamo a vedere la più grande isola del mondo e la più ricca, e vedrete cosa che mai non avete vista. Ma bisogna che andiamo prima ad un’altra isola che si chiama Bornei, dov’è mestieri pigliar una nave grande, perché il mare è più grosso”. Rispose egli: “Io son molto contento di far quel che volete”. E così pigliammo il cammino verso la detta isola, alla qual sempre si va al mezzogiorno. Andando in questo cammino, continuamente li detti cristiani, notte e giorno, non aveano altro piacere se non di parlar con meco delle cose de’ cristiani e della fede nostra. Quando io li dissi del volto santo che sta in Santo Pietro, e delle teste di santo Pietro e di santo Paulo e di molti altri santi, mi dissero secretamente che s’io voleva andar con essi, ch’io saria grandissimo signore, per aver visto queste cose. Io dubitava che, poi che me avessero condotto là, non arei potuto mai più tornar alla patria mia, e per questo restai di andarvi.
Arrivati che fummo all’isola di Bornei, la qual è distante da Maluch cerca dugento miglia, trovammo ch’è alquanto maggiore che la sopradetta e molto più bassa. Le genti di questa sono gentili e sono uomini da bene; il color suo è più bianco che d’altra sorte, l’abito loro è una camicia di bombagio e alcuni vanno vestiti di ciambellotto; alcuni portano berrette rosse. In questa isola si fa grandissima iustizia. E ogni anno si carica assaissima quantità di canfora, la qual dicono che nasce ivi e che è gomma di arbori: se così è io non l’ho vista, però non l’affermo. Quivi il mio compagno noleggiò una navetta per cento ducati.
27
In che modo li marinari si governano, navigando verso l’isola Giava.
Fornita che fu la noleggiata nave di vettovaglia, pigliammo il nostro cammino verso la bella isola chiamata Giava, alla quale arrivammo in cinque giorni, navigando pure verso mezzogiorno. Il padrone di detta nave portava la bussola con la calamita ad usanza nostra, e aveva una carta, la qual era tutta rigata per lungo e per traverso. Dimandò il mio compagno alli cristiani: “Poi che noi abbiamo perso la tramontana, come si governa costui? Evvi altra stella tramontana che questa, con la qual noi navighiamo?” Li cristiani ricercorono il padron della nave questa medesima cosa, ed egli ci mostrò quattro o cinque stelle bellissime, infra le quali ve n’era una qual disse ch’era all’incontro della nostra tramontana, e ch’egli navigando seguiva quella, perché la calamita era acconcia e tirava alla tramontana nostra. Ci disse ancora che dall’altra banda di detta isola verso mezzogiorno vi sono alcune genti, le quali navigano con le dette quattro o cinque stelle che sono per mezza la nostra tramontana; e più ci disse che di là dalla detta isola si naviga tanto che trovano che il giorno non dura più che quattro ore, e che ivi era maggior freddo che in luogo del mondo. Udendo questo, noi restammo molto contenti e satisfatti.
28
Della isola Giava, della fede, del vivere e costumi suoi e delle cose che ivi nascono.
Seguendo adunque il camin nostro, in cinque giorni arrivammo a questa isola Giava, nella quale sono molti reami, li re delli quali sono gentili. La fede loro è questa: alcuni adorano gl’idoli come fanno in Calicut, e alcuni sono che adorano il sole, altri la luna; molti adorano il bue, gran parte la prima cosa che scontrano la mattina, e altri adorano il diavolo al modo che già vi dissi. Questa isola produce grandissima quantità di seta, parte al modo nostro e parte nei boschi, sopra gli arbori salvatichi. Qui si truovano li migliori e più fini smeraldi del mondo, e oro e rame in gran quantità, grano assaissimo al modo nostro e frutti bonissimi ad usanza di Calicut. Si truovano in questo paese carni di tutte le sorti ad usanza nostra. Credo che questi abitanti siano i più fedeli uomini del mondo; sono bianchi e di altezza come noi, ma hanno il viso assai più largo di noi, gli occhi grandi e verdi, il naso molto ammaccato e li capelli lunghi. Qui sono uccelli in grandissima moltitudine e tutti differenti dalli nostri, eccetto li pavoni, tortore e cornacchie negre, le quali tre sorti sono come le nostre. Fra queste genti si fa grandissima giustizia. E vanno vestiti all’apostolica, di panni di seta, ciambellotto e di bombagio. E non usano troppe armature, perché non combattono, salvo quelli che vanno per mare, i quali portano alcuni archi e la maggior parte freccie di canna. Accostumano ancora alcune cerbottane, con le quali tirano freccie attossicate: e le tirano con la bocca, e ogni poco che faccino di sangue, muore la persona. Qui non si usa artiglieria di sorte alcuna, e manco le sanno fare. Questi mangiano pane di grano; alcuni altri ancora mangiano carne di castrati o di cervo o vero di porco salvatico, e altri mangiano pesci e frutti.
29
Come in questa isola li vecchi si vendono da’ figliuoli overo da’ parenti, e poi se li mangiano.
Vi sono uomini in questa isola che mangiano carne umana. Hanno questo costume, che essendo il padre vecchio, di modo che non possi far più esercizio alcuno, li figliuoli over li parenti lo mettono in piazza a vendere, e quelli che lo comprano l’ammazzano e poi se lo mangiano cotto. E se alcun giovane venisse in grande infirmità, che paresse alli suoi che ‘l fusse per morire di quella, il padre overo fratello dell’infermo l’amazzano, e non aspettano che ‘l muora: e poi che l’hanno morto, lo vendono ad altre persone per mangiare. Stupefatti noi di simil cose, ci fu detto da alcuni mercatanti del paese: “O poveri Persiani, perché tanto bella carne lasciate mangiar alli vermi”? Inteso questo, subito il mio compagno disse: “Presto, presto, andiamo alla nostra nave, che costoro più non mi giungeranno in terra”.
30
Dove nel mese di giugno nel mezzogiorno in l’isola della Giava il sole faceva ombra; e come si partirono.
Dissero li cristiani al mio compagno: “O amico mio, portate questa novella di tanta crudeltà alla patria vostra, e portateli ancora questa altra che vi mostraremo”. E dissero: “Guardate qui, adesso che è mezzogiorno, voltate il viso dove tramonta il sole”. E alzando noi gli occhi, vedemmo il sole che ne faceva ombra a man sinistra più d’un palmo, e a questo comprendemmo che eravamo molto distanti dalla patria nostra, per il che restammo molto maravigliati. E secondo che diceva il mio compagno, credo che questo fu il mese di giugno, perché io aveva perduto li nostri mesi e alcuna volta il nome del giorno. È da sapere che qui è poca differenzia dal nostro freddo al loro.
Avendo noi visto li costumi di questa isola, ne parve non esser molto da dimorare in essa, perché ne bisognava star tutta la notte a far la guardia, per paura di alcun tristo che non ci venisse a pigliare per mangiarne. Onde, chiamati li cristiani, li dicemmo che al più presto potessero ritornassimo verso la patria nostra. Ma pur, avanti che si partissimo, il mio compagno comprò duoi smeraldi per mille pardai, e comprò duoi fanciulli per dugento pardai, li quali non aveano natura né testicoli, perché in questa isola vi sono mercatanti di tal sorte, che non fanno altra mercanzia se non di comprar fanciulli piccoli, alli quali fanno tagliare in puerizia ogni cosa, e rimangono come donne.
31
Come l’auttore si partì dalla Giava e venne per mare a Malacha, dove prese combiato dalli suoi compagni cristiani, e dapoi, avendo toccato in diversi luoghi, giunse finalmente in Calicut.
Essendo noi in tutto dimorati quattordici giorni in detta isola di Giava, perché, parte per paura della crudeltà nel mangiar gli uomini, parte ancora per li gran freddi, non ardivamo andar più avanti, e ancor perché a questi nostri compagni non era luogo alcun avanti più cognito, deliberammo tornar indrieto. Onde noleggiammo una nave grossa, cioè un giunco, e pigliammo il nostro cammino dalla banda di fuori dell’isole verso levante, perché da quella banda non è arcipelago, e navigasi più sicuramente. Navigammo quindici giornate e arrivammo alla città di Malacha, e qui stemmo tre giorni, dove rimasero li nostri compagni cristiani, li pianti e lamenti de’ quali non si potrian con brieve parlar raccontare, di sorte che, s’io non avessi avuto moglie e figliuoli, sarei andato con loro. E similmente dicevano loro, se avessero saputo di tornar a salvamento, che sariano venuti con noi. E credo ancor che ‘l mio compagno li confortassi che non venissero, acciò non avessero causa di dar notizia a’ cristiani di tanti signori che sono nel paese loro, che pur son cristiani e hanno infinite ricchezze. Sì che loro restorno, dicendo che volevano tornare in Sarnau, e noi andammo con la nostra nave alla volta di Coromandel.
Diceva il padrone della nave che intorno alla isola di Giava e intorno all’isola Sumatra erano più di ottomila isole. Qui in Melacha il mio compagno comprò cinquemila pardai di spezie minute e panni di seta e cose odorifere. Navigammo quindici giornate e arrivammo alla detta città di Coromandel, e qui fu scaricato il giunco noleggiato in Giava. Stemmo dapoi cerca venti giorni in questa terra, e al fine pigliammo una ciampana e andammo alla volta di Colon, dove trovai dodici cristiani portoghesi. Per la qual cosa io ebbi grandissima volontà di fuggire, ma restai, perché erano pochi e temeva delli Mori, conciosiacosaché vi erano alcuni mercatanti con noi, che sapevano ch’io era stato alla Mecca e dove è il corpo di Macometto, e avea paura che loro non dubitassero ch’io scoprissi le loro ipocrisie: per questo restai di fuggire. Di lì a 12 giorni pigliammo il nostro cammino verso Calicut, cioè per la fiumara, e arrivammo lì in spazio di dieci giorni.
32
Come l’auttor trovò in Calicut duoi Milanesi che facevan artegliarie al re, e come gli persuase che fuggissero, e come egli finse di esser santo.
Dapoi il lungo discorso di tanti e così varii paesi come di sopra abbiamo narrato, ad ogni benigno lettor è facil cosa cognoscere quanto già mi cominciava a pesare l’esser passato tanto avanti, in così largo cammino e navigazione, sì per li diversi e inequali temperamenti dell’aere, come per le molte differenzie e varietà di costumi, e sopratutto di quelli così crudeli e inumani uomini, veramente non dissimili dalle bestie. E per tanto, essendo con il mio compagno fastidito, deliberammo ritornarcene verso li nostri natii paesi. E conciosiacosaché nel ritorno m’intravenissero molte cose degne di memoria, non sarà fuor di proposito se quelle brievemente dirò: e penso, anzi tengo per certo, che non sarà infructuosa la narrazione di molti miei travagli, sì in raffrenar l’insaziabil appetito di molte persone, che senza pensarvi molto sopra si lasciano trasportar dal desiderio di veder diverse parti del mondo, come che, trovandosi sopraggiunti in un punto da qualche inopinato caso o pericolo, dove è bisogno che l’ingegno lavori, si saperranno con prudenzia governare e riuscirne a salvamento.
Essendo adunque arrivati in Calicut di ritorno, secondo che poco avanti avevamo scritto, trovammo duoi cristiani, li quali erano milanesi: uno si chiamava Giovanmaria, l’altro Pietroantonio, ed erano venuti di Portogallo con la nave de’ Portoghesi, per comprar gioie ad instanzia del re, e quando furno giunti in Cocchin, se ne fuggirno in Calicut. Vedendo questi duoi cristiani, veramente mai non ebbi la maggior allegrezza. Essi e io andavamo nudi ad usanza del paese. Io li dimandai s’erano cristiani; rispose Giovanmaria: “Sì, semo ben noi”, e poi Pietroantonio dimandò a me s’io era cristiano. Gli risposi di sì, laudato sia Dio: allora mi prese per la mano e menommi in casa sua, dove giunti cominciammo ad abbracciarci l’un l’altro e baciarci e piagnere. Veramente io non poteva parlar cristiano, e mi parea aver la lingua grossa e impedita, perché io era stato quattro anni che non avea parlato con cristiani. Quella notte stetti con loro, né mai alcun di noi poté mangiare e manco dormire, solamente per la tanta grande allegrezza che avevamo: pensate che noi aressemo voluto che quella notte avesse durato un anno, per ragionare insieme di diverse cose. Fra le quali io gli dimandai se essi erano amici del re di Calicut; mi risposero che erano delli primi uomini ch’egli avesse e ogni giorno parlavano con lui. Gli dimandai ancora che intenzione era la loro; mi dissero che volentieri sariano tornati alla patria, ma non sapevano per qual via. Io risposi loro: “Tornate per la via che sete venuti”. Essi dissero che non era possibile, perché erano fuggitivi dalli Portoghesi, e che ‘l re di Calicut gli avea fatti far gran quantità di artiglierie contra sua volontà, e per questo rispetto non voleano tornare per quella via, e dissero che presto si aspettava l’armata del re di Portogallo. Io li risposi che, se Dio mi facea tanta grazia ch’io potessi fuggir in Canonor, quando fusse venuta l’armata, ch’io farei tanto che ‘l capitano del re li perdonaria; e dissigli che ad essi non era possibile fuggire per altra via, perché si sapea per molti reami che essi facevano artiglierie, e molti re aveano volontà di averli nelle mani per la virtù loro: e però non era possibile fuggire per altro modo. E mi dissero che ne aveano fatto cerca quattrocento in cinquecento bocche fra grandi e piccole, in modo che conclusero che aveano grandissima paura de’ Portoghesi: e invero era ragion d’averla, perché, non ostante che essi facevano le artiglierie, le insegnavano ancor fare alli gentili; e più mi dissero che aveano insegnato a tirar le spingarde a venticinque criati del re. E nel tempo ch’io stetti qui, essi dettero il disegno e la forma ad uno gentile per far una bombarda, la qual pesò cento e cinquanta cantara, ed era di metallo. Vi era ancora un giudeo che avea fatto una galea molto bella, e avea fatto quattro bombarde di ferro: il detto giudeo, andando a lavarsi ad una fossa di acqua, si affogò.
Torniamo alli detti Milanesi. Dio sa quello li dissi, esortandoli che non volessero far tal cosa contra li cristiani: Pietroantonio di continuo piangeva, e Giovanmaria diceva che tanto gli era a morire in Calicut quanto in Roma, e che Dio avea ordinato quello dovea essere. La mattina seguente tornai a trovare il mio compagno, il qual fece gran lamentazione, perché dubitava ch’io fussi stato morto. Io gli dissi ch’era stato a dormire in una moschea de’ Mori, a ringraziar Dio e Maumetto del beneficio ricevuto, ch’eravamo tornati a salvamento: e di questo lui ne fu molto sodisfatto. E per poter io saper li fatti della terra, gli dissi ch’io voleva star a dormire nella moschea e ch’io non voleva robba, ma che sempre voleva esser povero. E per voler io fuggire da loro, pensai di non li poter ingannare salvo che con la ipocrisia, perché i Mori son la più grossa gente del mondo: per modo ch’ei fu contento. E questo faceva io per poter spesso parlar alli cristiani, perché essi sapevano ogni cosa di giorno in giorno della corte del re. Io cominciai ad usare la ipocrisia: finsi di esser Moro santo, né mai volsi mangiar carne, salvo che in casa di Giovanmaria, che ogni notte mangiavamo duoi para di galline, e mai più non volsi praticare con mercatanti, e manco uomo alcuno mi vidde mai ridere. E tutto il giorno stavo nella moschea, salvo quando el mio compagno mandava per me ch’io andassi a mangiare, e gridavami perché io non voleva mangiar carne: io li rispondeva che ‘l troppo mangiare conduce l’uomo a molti peccati. E a questo modo cominciai ad esser Moro santo, e beato era quello che mi poteva baciar la mano, e alcuno le ginocchia.
33
Come finse di esser medico e guaritte un Moro.
Accadendo che uno mercatante moro si ammalò di gravissima infirmità e, non potendo per alcun modo usar il beneficio del corpo, mandò dal mio compagno, il qual era molto suo amico, per intendere s’egli overo alcun altro di casa sua gli sapesse dar qualche rimedio, gli rispose che l’anderia a visitare e mi meneria seco. E così egli e io insieme andammo a casa dell’ammalato, e dimandandoli del suo male, disse: “Io mi sento molto male al stomaco e al corpo”. Io gli dimandai se aveva avuto qualche freddo, per il qual fusse causato questo male; rispose che non poteva esser freddo, perché non seppe mai che cosa si fusse. Allora il mio compagno si voltò a me e dissemi: “O Lodovico, sapresti tu qualche rimedio per questo mio amico?” Io risposi che mio padre era medico alla patria mia, e che quello ch’io sapeva lo sapea per pratica, ch’egli mi avea insegnato. Disse il mio compagno: “Orsù, vediamo se con qualche rimedio si può liberare questo mercatante, che è tanto mio amico”. Allora gli presi la mano e, toccandoli il polso, trovai ch’avea grandissima febbre, e lo dimandai se li doleva la testa; rispose: “Sì, che la mi duol forte”. Poi li dimandai se andava del corpo; mi disse ch’erano tre giorni che non era ito. Io subito pensai: “Questo uomo ha carico lo stomaco per troppo mangiare, e per aiutarlo ha bisogno d’alcun serviziale”; e dicendolo al mio compagno, ei mi rispose: “Fate quello vi piace, pur che ‘l sia sano”. Allora io detti ordine al serviziale in questo modo: pigliai zuccaro, ova e sale, e per la decozione pigliai certe erbe, le quali fecero più mal che bene; le dette erbe erano come foglie di noci. E con queste tal cose in un dì e una notte li feci cinque serviziali, e niuno giovava, per rispetto delle erbe che erano contrarie, a tale che volentieri arei voluto non essermi impacciato di far tal esercizio.
Alla fine, vedendo che ei non poteva andar del corpo per difetto dell’erbe triste, pigliai un buon fascio di porcellane e feci cerca mezzo boccale di sugo, e vi misi altrotanto olio e molto sale e zuccaro: poi colai ogni cosa molto bene. E qui feci un altro errore, che mi scordai di scaldarlo, ma ve lo messi così freddo. Fatto che fu il serviziale, gli attaccai una corda alli piedi e lo tirammo suso, alto tanto ch’egli toccava terra con le mani e con la testa, e lo tenemmo così alto per spazio di mezzo quarto d’ora. Diceva il mio compagno: “O Lodovico, costumasi così alla patria vostra?” Io risposi: “Quando l’infermo sta in estremo”. Diss’egli che era buona ragione, che stando così spiccaria meglio la materia. Il povero ammalato gridava e diceva: “Non più, non più, ch’io son morto”. E così, stando noi a confortarlo, o che fusse Dio o la natura, cominciò a far del corpo suo come una fontana. E subito lo calammo giuso, ed egli andò del corpo veramente mezzo barile di robba, e rimase tutto contento. Il dì seguente non avea né febbre né doglia di testa né di stomaco, e dipoi andò molte volte del corpo. L’altra mattina disse che li dolevano un poco i fianchi; io feci pigliar butiro di vacca, o vero di buffalo, e fecilo ugnere e infasciare con stoppa di canapo. Poi li dissi che, s’ei voleva risanarsi, bisognava ch’ei mangiasse due volte al giorno, e innanzi mangiare volevo che camminasse un miglio a piedi. Egli mi rispose: “Se non volete ch’io mangi più di due volte il dì, presto presto io sarò morto”, perché loro mangiano otto e dieci volte al giorno. Pareva a lui questo ordine molto aspro, pur finalmente egli si risanò benissimo, e questo dette gran credito alla mia ipocrisia: dicevano poi ch’io era amico di Dio. Questo mercatante mi volse dare dieci ducati, e io non volsi cosa alcuna, anzi detti tre ducati ch’io aveva alli poveri: e questo feci publicamente, perché essi conoscessero ch’io non voleva robba né danari.
Doppo questo, beato quello che mi poteva menare a casa sua a mangiare, beato era chi mi baciava le mani e li piedi. E quando alcuno mi baciava le mani, io stava saldo in continenzia, per darli ad intendere ch’ei faceva cosa la qual io meritava per esser santo. Ma sopra tutto il mio compagno era quello che mi dava credito, perché ancora egli mi credeva e diceva ch’io non mangiava carne, e che ‘l mi aveva veduto alla Mecca e al corpo di Maumetto, e ch’io era andato sempre in sua compagnia e conosceva li costumi miei, e che veramente io era santo e, conoscendomi di buona e santa vita, ei mi avea dato una sua nipote per moglie: sì che per questo ogni uomo mi voleva bene. E io ogni notte andava secretamente a parlare alli Milanesi, li quali mi dissero una volta ch’erano venute dodici navi di Portoghesi in Canonor. Allora dissi: “Questo è il tempo ch’io scampo di mano de’ cani”, e pensammo insieme otto giorni in che modo io potea fuggire. Essi mi consigliorono ch’io fuggissi per terra, e a me non bastava l’animo, per paura di non esser morto dalli Mori, per esser io bianco e loro negri.
34
Della nuova di XII navi de Portoghesi, quali vennero in Calicut.
Un giorno, stando a mangiare col mio compagno, vennero duoi mercatanti persiani di Canonor, quali subito li chiamò a mangiare con lui. Risposero loro: “Noi non abbiamo voglia di mangiare, e portiamo una mala novella”. Li dimandò: “Che parole son queste che voi dite?” Dissero costoro: “Sono venute dodici navi di Portoghesi, le quali abbiamo vedute con gli occhi nostri”. Dimandò il mio compagno: “Che genti sono?” Risposero li Persiani: “Sono cristiani, e tutti sono armati d’arme bianche, e hanno cominciato a fare un fortissimo castello in Canonor”. Voltossi a me il mio compagno e dimandommi: “O Lodovico, che genti sono questi Portoghesi?” Io gli risposi: “Non mi parlar di tal generazione, che tutti sono ladri e corsari di mare: io li vorrei veder tutti convertiti alla fede nostra maumettana”. Udendo egli questo rimase di mala voglia, e io molto contento nel cuor mio.
35
Del modo come li Mori chiamano il popolo alla moschea per far orazione; e come l’auttore venne in Canonor.
Il giorno seguente, intesa la nuova, tutti li Mori andorono alla moschea a far orazione. Ma prima alcuni a questo deputati salirono su la torre della loro moschea, come fra essi è usanza di andarvi tre o quattro volte il giorno, e con alta voce cominciorono in scambio di campane a chiamar gli altri alla medesima orazione, tenendo di continuo un dito nell’orecchia e dicendo: “Dio è grande, Dio è grande, venite alla moschea, venite alla moschea a laudar Dio, venite a laudar Dio. Dio è grande, Dio è grande. Dio fu, Dio sarà, Maumet messaggiero di Dio resusciterà”. E menorono ancora me con loro, dicendomi che io volessi pregar Dio per li Mori, e così publicamente mi posi a far la orazione, la qual è così fra loro comune com’è a noi il Pater nostro e l’Ave Maria. Stanno li Mori tutti alla fila, ma sono molte file, e hanno un sacerdote come da noi un prete, li quali, dipoi che sono molto ben lavati, cominciano a far la orazione secondo l’usanza loro: e così feci ancora io, in presenzia di tutto il popolo, e poi tornai a casa col mio compagno.
Il giorno seguente finsi d’esser molto ammalato, e stetti circa otto giorni che mai non volsi mangiar con lui, ma ogni notte andava a mangiar con li Milanesi. Egli molto si maravigliava e dimandavami perché non volevo mangiare; io gli rispondeva ch’io mi sentiva molto male e che mi pareva aver la testa molto grossa e carica, e dicevali che mi pareva che procedesse da quell’aere, che non fusse buono per me. Costui, per l’amor singulare che mi portava, aria fatto ogni cosa per compiacermi, onde, intendendo che l’aere di Calicut mi facea male, dissemi: “Andatevene a stare in Canonor per fino a tanto che torniamo nella Persia, e io vi indrizzarò ad uno amico mio, il qual vi darà tutto quello che vi bisogna”. Io li risposi che volentieri anderia in Canonor, ma che dubitavo di quelli cristiani. Disse lui: “Non dubitate né abbiate paura alcuna di loro, perché voi starete di continuo nella città”. Alla fine, avendo io veduto tutta l’armata che si faceva in Calicut, e tutta l’artiglieria e l’esercito che si preparava contra cristiani, mi misi in viaggio per darli aviso e per salvarmi dalle man de’ cani.
36
Con quanto pericolo l’auttor si partì di Calicut, e come giunse in Canonor.
Un giorno avanti ch’io mi partissi, ordinai tutto quello che avea da fare con li duoi Milanesi, e poi il mio compagno mi mise in compagnia di quelli duoi Persiani che portorono la nuova di Portoghesi, e pigliammo una barchetta piccola. Ora intenderete in quanto pericolo mi posi, perché qui stavano ventiquattro mercatanti persiani, soriani e turchi, li quali tutti mi conoscevano e mi portavano grandissimo amore, e sapevano che cosa era lo ingegno del cristiano. Dubitavomi, se li domandava licenzia, che loro pensariano che io volessi fuggire alli Portoghesi, e se mi partivo senza parlarli, e per avventura io fussi scoperto, che loro mi ariano detto: “Perché non parlavi a noi?” E stavo in questo pensiero. Pur deliberai di partirmi senza parlar ad alcuno, salvo al mio compagno.
Lo giovedì da mattina, adì 3 di decembre, mi parti’ con li duoi Persiani per mare; e quando fummo un tiro di balestra in mare, vennero quattro Naeri alla riva del mare, i quali chiamorono il padron del navilio, e subito tornammo in terra. Li Naeri dissero al padrone: “Perché levate questo uomo senza licenzia del re?” Li Persiani risposero: “Costui è uomo santo, e andiamo a Canonor”. “Sapemo ben, – dissero li Naeri, – che è Moro santo, ma ei sa la lingua de’ Portoghesi e dirà tutto quello che facciamo qui”, perché si faceva grandissima armata. E comandorono al padron del navilio che per niente non mi levasse, e così fece. Restammo nella spiaggia del mare, e li Naeri tornorono alla casa del re. Disse uno delli Persiani: “Andiamo a casa nostra”, cioè in Calicut. Io risposi: “Non andate, perché perderete queste cinque sinabafi (che sono pezze di tela che portavano), però che non avete pagato il dretto al re”. Disse l’altro Persiano: “O signore, che faremo?” Io risposi: “Andiamo per questa spiaggia, per fino a tanto che noi trovaremo un parao”, cioè una barchetta piccola. E così furono contenti, e pigliammo il cammino per 12 miglia, sempre per terra, caricati delle dette robbe: pensate che cuore era il mio a vedermi in tanto pericolo. All’ultimo trovammo un parao, il qual ci portò fino a Canonor.
Il sabbato a sera giugnemmo a Canonor e subito portammo una lettera, la qual m’avea fatta il mio compagno, ad un mercatante suo amico, il tenor della quale diceva che mi facesse tanto quanto alla sua persona, per fino a tanto ch’egli venisse qui, e dicevali come io era santo, e il parentado che era fra lui e me. Il mercatante, subito ch’ebbe letta la lettera, se la pose sopra il capo e disse ch’io staria sicuro sopra la sua testa; e subito fece far molto ben da cena, con molte galline e piccioni. Quando li Persiani viddero venir galline, dissero: “Oimè, che fate voi? Costui non mangia carne”, e subito vennero altre robbe. Fornito che avemmo da mangiare, li detti Persiani dissero a me: “Andiamo un poco alla marina a piacere”, e così andammo dove stavano le navi di Portoghesi. Pensate, o lettori, quanta fu l’allegrezza ch’io ebbi nel cuore: andando un poco più avanti, viddi alla porta d’una certa casa bassa tre botteghe vote, per le quali pensai che lì dovea esser la fattoria de’ cristiani. Allora, alquanto rallegrato, ebbi volontà di fuggire dentro alla detta porta, ma considerai che, facendo tal cosa nella loro presenzia, la terra tutta si metteria a rumore; e io, non potendo sicuramente fuggire, notai il luoco dove si faceva il castello de’ cristiani e deliberai di aspettar il giorno seguente.
37
Come l’auttore si fuggì di Canonor alla fortezza de’ Portoghesi, e come li duoi Milanesi furono morti in Calicut.
La domenica mattina mi levai a buon’ora e dissi ch’io voleva andar un poco a sollazzo. Risposero li compagni: “Andate dove vi piace”, e così pigliai il cammino secondo la fantasia mia, e andai dove si faceva il castello de’ cristiani. E quando fui un pezzo lontano dalli compagni, passeggiando sopra la spiaggia del mare, mi scontrai in duoi cristiani portoghesi e dissi loro: “Signori, dove è la fortezza de’ Portoghesi?” E dissero quelli duo cristiani: “Sei tu per ventura cristiano?” Io risposi: “Sì signor, laudato sia Dio”, e lor dissero: “Donde venite voi?” Risposi io: “Vengo di Calicut”. Allora disse l’un all’altro de’ duoi compagni: “Andate voi alla fattoria, ch’io voglio menar quest’uomo a don Lorenzo”, cioè al figliuol del vice re. E così mi menò al detto castello, il qual è distante dalla terra mezzo miglio, e quando arrivammo al detto castello, il signor don Lorenzo stava mangiando. Subito m’inginocchiai alli piedi di sua signoria e dissigli: “Signore, mi raccomando a V.S. che mi salvi, perché son cristiano”. Stando in questo modo, sentimmo la terra levarsi a rumore perché io era fuggito, e subito furono chiamati li bombardieri che caricassero tutte le artegliarie, dubitando che quelli della terra non venissero al castello a combattere. Allora, vedendo il capitano che quelli della terra non facevano altro movimento, mi prese per la mano e menommi in una sala, pur interrogandomi delle cose di Calicut, e mi tenne tre giorni a parlar con lui; e io, desideroso della vittoria de’ cristiani, gli diedi tutto l’aviso dell’armata che si faceva in Calicut. Forniti questi parlamenti, mi mandò con una galea dal vice re suo padre in Cochin, della qual era capitano un cavaliere chiamato Ioan Serrano.
Il vice re, giunto ch’io fui, ebbe grandissimo piacere e fecemi grande onore, perché li detti aviso di quanto si faceva in Calicut, e ancora li dissi che se sua signoria voleva perdonare a Giovanmaria e Pietroantonio, li quali facevano artegliaria in Calicut, e darmi sicurtà per loro, ch’io li faria tornare, e non fariano contra cristiani quel danno che fanno, benché contra la volontà loro, e che loro aveano paura di tornare senza salvocondotto. Il vice re n’ebbe grandissimo piacere e fu molto contento, e fecemi il salvocondotto; e il capitano della galea con la qual io venni promise per il vice re, e in termine di tre giorni mi rimandò con la detta galea a Canonor, e dettemi una lettera la qual andava al figliuolo, che mi desse tanti danari quanti mi bisognava per pagar le spie da mandar in Calicut.
Arrivati che fummo in Canonor, trovai un gentile il qual mi dette la moglie e li figliuoli in pegno, ed esso lo mandai con mie lettere in Calicut a Giovanmaria e Pietroantonio, per le quali io gli avisava come il vice re avea lor perdonato e che venissero sicuramente. Sappiate che li mandai cinque volte la spia innanzi e indrieto, e sempre scrivea che si guardassero e non si fidassero delle femmine né del loro schiavo, perché ciascun di essi avea una femmina, e Giovanmaria avea un figliuolo e uno schiavo: loro sempre rispondevano che volentieri verriano. Finalmente nell’ultima lettera mi dissero così: “Ludovico mio, noi avemo dato tutte le robe nostre a questa spia; venite voi la tal notte con una galea, over bregantino, dove stanno li pescatori e dove non v’è mai guardia, perché piacendo a Dio verremo noi duoi e tutta la brigata”. Sappiate ch’io scriveva che venissero loro soli e che lassassero le femmine, il figliuolo, la roba e il schiavo, ma che portassero solo le gioie e li danari, imperoché avevano un diamante che pesava 32 caratti, il qual dicevano che valeva quindecimila ducati, e una perla che pesava 24 caratti, e duemila rubini li quali pesavano un caratto e un caratto e mezzo l’uno, e aveano 64 anelli con gioie legate e 1400 pardai. E volendo, oltre le sopradette cose, salvare anche sette spingarde e tre gatti maimoni e duoi gatti da zibetto e la rota da conciar gioie, per questa miseria loro furon causa della lor morte, perché ‘l schiavo suo, qual era di Calicut, avedendosi che volevano fuggire, se n’andò subito al re e dissegli ogni cosa. Il re non gli credeva; nientedimeno mandò 5 Naeri a casa a star in sua compagnia. Vedendo il schiavo che ‘l re non li voleva far morire, se n’andò al cadì della fede de’ Mori e dissegli quelle medesime parole che avea detto al re, e più gli disse che tutto quello che si faceva in Calicut loro avisavano li cristiani.
Il cadì moro fece un consiglio con tutti li mercatanti mori, fra li quali adunarono cento ducati, li quali portarono al re di Giogha, il qual si trovava allora in Calicut con tremila Gioghi. Al quale ditti Mori dissero: “Signore, tu sai, gli altri anni, quando tu vieni qui, noi ti facciamo molto bene e più onore che non facciamo adesso. La causa è questa: che sono qui duo cristiani nimici della fede nostra e vostra, li quali avisano li Portoghesi di tutto quello che si fa in questa terra. Per questo ti pregamo che tu gli ammazzi: e piglia questi cento ducati”. Subito il re di Giogha mandò ducento uomini ad ammazzar li detti duoi Milanesi: e quando andarono alla sua casa, cominciarono a dieci a dieci a sonar cornetti e domandar elemosina. E quando li Milanesi viddero multiplicare tanta gente, dissero: “Questi vogliono altro che lemosina”, e cominciorono a combattere, per modo che essi duoi ne ammazzarono sei di coloro e ne ferirono più di quaranta. All’ultimo questi Gioghi li tirarono una sorte di lor armi, che è un circolo di ferro grosso due dita, che ha il taglio di fora via come un rasoro, e dettero a Giovanmaria nella testa e a Pietroantonio nella coscia, per modo che tutti duoi cascarono in terra, e poi li corsero addosso, e li tagliorno le canne della gola con le mani e beverono il lor sangue.
La femmina di Giovanmaria se ne fuggì col figliuolo in Canonor, e io comprai il figliuolo per 8 ducati d’oro, il qual feci battezzare il dì di san Lorenzo, e posigli nome Lorenzo, perché lo battezzai quel dì proprio. E in termine d’un anno, in quel dì medesimo, moritte di malfranzoso: e sappiate che di questa infirmità io ne ho visto ammalati, di là da Calicut, più di tremila migliaia, e chiamasi pua, e dicono che sono circa XVII anni ch’ella cominciò, ed è assai più cattiva in quelli paesi che nelli nostri.
38
Dell’armata di Calicut che venne contra quella de’ Portoghesi e della crudel battaglia che fecero insieme.
A’ XII dì di marzo MDVI venne questa nova delli cristiani morti; in questo giorno medesimo si partì la grandissima armata di Pannani, di Calicut, di Capogat e da Pandarane e da Tromapatan. Tutta questa armata erano ducento e nove vele, delle quali ottantaquattro erano navi grosse e lo resto navilii da remi, cioè parao: nella quale erano infiniti Mori armati, e portavano certe veste rosse di tele imbottite di bombagio, con certe berrette grandi in testa imbottite, e similmente alle braccia braccialetti e guanti tutti imbottiti, e archi assaissimi e lanze, spade, rotelle e artegliaria grossa e minuta ad usanza nostra.
Quando noi vedemmo questa armata, che fu adì XVI del mese sopradetto, veramente, a veder tanti navilii insieme, parea che si vedesse un grandissimo bosco, per li arbori grandi delle navi. Noi cristiani veramente sempre speravamo che Dio ci avesse da aiutare a confondere la fede pagana. E il valentissimo cavaliere capitano dell’armata, figliuolo di don Francesco de Almeida, vice re dell’India, era qui con undeci navi, fra le quali erano due galee e uno bergantino; e come vidde tanta moltitudine de navi, avendo avanti gli occhi le valorose imprese de’ suoi antecessori, non volendo punto degenerare da quelli, chiamati a sé tutti li cavalieri e uomini di dette navi, gli cominciò ad esortar e pregar che volessero, per l’amor di Dio e della fede cristiana, esponersi volentieri a patir la morte, dicendo in questo modo: “O signori, o fratelli, oggi è quel giorno che tutti ci dobbiamo ricordar della passione di Cristo, e quanta pena portò per redimer noi peccatori. Oggi è quel giorno che ne saranno scancellati tutti li nostri peccati e che Dio ne riceverà nella sua santa gloria. Per questo vi prego che vogliate andar vigorosamente contra questi cani, perché spero che Dio ne darà vittoria e non vorrà che la fede sua manchi”. Immediate un santo padre spirituale, che stava sopra la poppe della nave del detto capitano, alzò con grandissima devozione un crucifisso con le sue mani, che tutte le genti lo potevano vedere, e fece un bel sermone, esortandone a far quel ch’eravamo obligati per la fede cristiana. Poi fece l’assoluzione di pena e di colpa, e disse: “Orsù, figliuoli mei, andiamo a combattere tutti volentieri, che Dio sarà con noi”. E seppe tanto ben dire, e con parole tanto pietose ed efficaci, che tutti piangevamo e pregavamo Dio che ci facesse morire in quella battaglia.
In questo mezzo veniva la grandissima armata de’ Mori alla volta nostra per passare, e il nostro capitano si partì con due navi e andossene alla volta loro, e passò fra due navi, le quali erano le maggiori che fossero nell’armata de’ Mori: e quando passò per mezzo le dette navi, ci salutarono l’una e l’altra parte con grandissimi tiri d’artegliaria. E questo fece il nostro capitano per conoscer la forza di queste due navi e che modo teneano, perché queste aveano grandissime bandiere ed erano capitane di tutta l’armata. Per quel giorno non fu fatta altra cosa. La mattina seguente a buon’ora li Mori cominciarono tutti a far vela e venir verso la città di Canonor, e mandorono a dire al nostro capitano che gli lassasse passare e andar al viaggio loro, che essi non voleano combattere con cristiani. Il capitano gli mandò a dire che li Mori di Calicut non lassarono tornare li cristiani che stavano in Calicut sopra la sua fede, ma a tradimento ne ammazzarono quarantaotto, e li robarono più di quattromila ducati infra robba e danari. E poi li disse: “Passate, se potete passare. Ma prima cognoscerete la forza e cuore ch’è nelli cristiani”. Li Mori risposero: “Già che la cosa è così, Maumetto nostro ci defenderà da voi cristiani”. E così tutti cominciorono a far vela e con grandissima furia a voler passare, sempre navigando appresso terra otto o dieci miglia. E il nostro capitano gli volse lasciar venire a riscontro la città di Canonor, perché ‘l re di Canonor stava a vedere, per mostrarli quanto era l’animo de’ cristiani.
In questo mezzo il capitan comandò che tutti mangiassero, e poi che ebbero mangiato, il vento cominciò un poco a rinfrescare. Il capitano disse: “Orsù, fratelli, adesso è il tempo che tutti siamo buoni cavalieri”, e cominciò andar alla volta di queste due grandissime navi. Non vi potrei dire la sorte degl’infiniti instrumenti che sonavano ad usanza loro, che pareva che ‘l mondo venisse a fine. Il capitano valentemente s’incatenò con una delle navi de’ Mori, cioè con la più grossa, e li Mori tre volte gittorono via la nostra catena: alla quarta volta rimasero attaccati, e subito li cristiani saltorono nella detta nave, dov’erano seicento Mori. Qui a spada per spada si venne alle mani, e fu fatta crudelissima battaglia con grandissima effusione di sangue, per modo che di questa nave non scampò alcuno, ma tutti rimasero morti. Poi il nostro capitano andò a trovar l’altra nave grande de’ Mori, la quale stava già incatenata con un’altra delle nostre navi, e qui ancora si combatté terribilmente, e vi morirono cinquecento Mori. Quando queste due navi grosse furon prese, tutto il resto dell’armata de’ Mori si mise alla disperata e circondò le nostre undici vele, per modo che era tal nave delle nostre ch’avea intorno quindici e venti di quelle de’ Mori a combattere. Qui fu un bel veder menar le mani ad uno valentissimo capitano chiamato Giovan Serrano, il qual fece con una galea tanta crudeltà de’ Mori che non si potria dire: e fu volta ch’egli avea intorno alla sua galea cinquanta navilii da remi e da vela, tutti con artigliaria, e per grazia di Dio si prevalse e non furono morti de’ cristiani se non pochi, cioè VIII o X, ma feriti infiniti. E durò tutto quel giorno il combattere, fino all’oscura notte.
Il bregantin dove io era si allungò un poco dalle navi, e subito fu messo in mezzo da quattro navilii de’ Mori, e si combattette molto aspramente: e fu ora che stavano sopra il bregantino quindici Mori, per modo che li cristiani s’erano retirati tutti alla poppa. E quando il valente capitano chiamato Simon Martin vidde esser tanti Mori sopra il bregantino, saltò infra que’ cani e disse: “O Iesù Cristo, dacci vittoria, aiuta la tua fede”, e con la spada in mano tagliò la testa a sei o ver sette; tutti gli altri Mori si gittorno nel mare e fuggirono chi qua chi là. Quando i Mori viddero che ‘l bregantino avea avuto vittoria, mandorono quattro altri navilii a soccorrer li suoi. Il capitano del bregantino, vedendo venire li detti navilii, subitamente prese un barile dove era stata la polvere e vi messe nella bocca un pezzo di vela, che parea che fosse una pietra di bombarda, poi mise un pugno di polvere sopra il barile e, stando col fuoco in mano, mostrava di voler scaricare una bombarda. Li Mori, vedendo questo, credettero che ‘l detto barile fosse una bombarda e subito voltorono indrieto: e il detto capitano si ritirò dove stavano li cristiani, col suo bregantino vittorioso. Il nostro capitano poi si mise fra tutti quei cani, de’ quali furono prese sette navi cariche parte di spezie e parte d’altre mercanzie, e nove o ver dieci ne furono gittate a fondo per forza d’artegliaria, infra le quali ve n’era una carica d’elefanti. Quando li Mori viddero tutto il mare pieno di sangue e tanti di loro morti, e ch’erano prese le due navi capitane dell’armata e altri navilii, subito si misero in rotta a fuggire chi qua chi là, notando verso terra, e chi in porto e chi a traverso la spiaggia. Alla fine, vedendo il nostro capitano tutti li navilii nostri salvi, disse: “Lodato sia Iesù Cristo, seguitiamo la vittoria contra questi cani”, e così tutti insieme si misero a seguitarli. Veramente, chi gli avesse allora veduti fuggire, gli parebbe che avessero drieto un’armata di cento navi. E questo combattere cominciò da l’ora del mangiare e durò per fino alla sera, e poi tutta la notte furono seguitati, sì che tutta questa armata fu sbarrattata con la morte di pochi di nostri, ma infiniti ne furon feriti.
L’altro giorno li nostri navilii che restarono qui seguitorono un’altra nave grossa, che viddero andar alla volta del mare; all’ultimo furon sì valenti che la investiron, in modo che tutti li Mori si gittorono a notare, e noi continuamente li seguitammo col schiffo, e con le balestre e lanze ammazzando e ferendo di loro in fino in terra. Ma alquanti si salvarono per forza di notare, e questi erano da ducento persone, le quali notarono più di 5 miglia, quando sotto e quando sopra l’acque: e alcuna volta credevamo che fussero morti, e quelli sorgevano lontano un tiro di balestra da noi, e giunti ch’eravamo appresso di loro per amazzarli, credendo che fussero stracchi, di nuovo si metteano sotto l’acqua, per modo che parea che fosse un miracolo grandissimo che costoro tanto durassero a notare. Pur al fine la maggior parte morirono e la nave se ne andò al fondo per li colpi delle artegliarie.
La mattina seguente il nostro capitano mandò le galee e il bregantino con alcuni altri navilii a canto la costa, a vedere li corpi che se potevano contare: trovorono, fra quelli ch’erano in spiaggia morti e per il mare e quelli delle navi prese, 3600 corpi morti; molti più ancora ne furono morti quando si misero in fuga, li quali si gittarono in mare. Il re di Canonor, veduta tutta questa battaglia, disse: “Questi cristiani sono molto animosi e valenti uomini”, e cominciò a volerne molto bene e averne cari. E veramente, per dir la verità, io mi sono trovato in qualche guerra alli miei giorni e ho veduto combattere terribilmente, ma non viddi mai li più animosi di questi Portoghesi. Il giorno seguente tornammo al nostro vice re, il qual era a Cochin, dove si vidde la grande allegrezza del re di Cocchin, il quale era vero amico del re di Portogallo, vedendoci tornar vittoriosi.
39
Come l’auttore fu rimandato per il vice re in Canonor e creato fattore.
Lasciamo l’armata del re di Calicut e torniamo al fatto mio. Passati tre mesi, il vice re per sua grazia mi dette un certo officio, quale era la fattoria delli mercatanti: e in questo officio stetti circa un anno e mezzo. De lì ad alcuni mesi il detto signore mi mandò sopra una nave a Canonor, perché molti mercatanti di Calicut andavano in Canonor e pigliavano il salvocondutto da’ cristiani, con darli ad intendere che erano da Canonor e che volevano passar con mercanzie delle navi di Canonor, il che non era il vero: però il vice re mi mandò per conoscer questi mercatanti e intender queste fraudi. Avenne in questo tempo che ‘l re di Canonor moritte, e l’altro che fu fatto fu molto nimico nostro, perché ‘l re di Calicut lo fece per forza di danari e prestogli ventitre bocche di fuoco.
40
Della guerra che cominciò in Canonor, dove era la fortezza de’ Portoghesi, e come alla fin fecero pace.
Nel MDVII, cominciò la grandissima guerra alli XXVII d’aprile e durò per fino a’ XXVII di agosto. Ora intenderete che cosa è la nostra fede cristiana e che uomini sono li Portoghesi. Andando un giorno li cristiani per pigliar acqua, li Mori gli assaltarono, per molto odio che ci portavano; li nostri si ritirarono nella fortezza, la qual già stava in buoni termini, e per quel giorno non fecion male alcuno. Il nostro capitano, qual si chiamava Lorenzo de Britte, mandò a far intendere questa novità al vice re, ch’era in Cochin: e subito vi venne il signor don Lorenzo, con una caravella fornita di tutto quel ch’era bisogno, e dopo quattro giorni il detto don Lorenzo si tornò in Cochin e noi restammo a combattere con questi cani, e non eravamo più che dugento uomini. Il mangiar nostro era sol riso, zuccaro e noci, e non avevamo acqua per bere dentro nel castello, ma ci era forza due volte la settimana andar a pigliar acqua ad un certo pozzo, il qual era lontano dal castello un tiro di balestra: e ogni volta che andavamo per acqua sempre ci bisognava pigliarla per forza d’arme, e sempre si scaramuzzava con loro. La manco gente che venisse erano ventiquattromila, e alcuna volta furono trenta, quaranta e cinquantamila persone, li quali aveano archi, lanze, spade e rotelle, con più di cento e quaranta bocche d’artegliaria infra grosse e minute, e aveano le medesime armature indosso, come vi ho detto nell’armata di Calicut. Il combattere loro era in questo modo: venivano due o tremila alla volta, e portavano tante sorti di suoni di diversi instrumenti e tanti fuochi artificiati, e poi con tanta furia correvano, che veramente averiano fatto paura a diecimila persone. Ma li valentissimi cristiani andavano a trovarli di là dal pozzo, e mai non s’accostarono alla fortezza a duo tiri di pietra, e ne bisognava ben guardarci davanti e da drieto, perché alcuna volta venivano di questi Mori per mare con LX parao per pigliarci in mezzo. Nondimeno ogni giorno di battaglia ne ammazzavamo dieci e quindeci e venti di loro, e non più, perché, come vedevano alcuno delli suoi morto, subito si mettevano in fuga; pur una volta fra l’altre una bombarda, chiamata la serpe, in un tiro ne ammazzò XVII, ed essi mai per la grazia di Dio non ammazzorono alcuno di noi: dicevano che noi tenevamo il diavolo che ci defendeva.
Questa guerra durò dalli 27 di aprile fin alli 27 d’agosto, perché allora venne l’armata di Portogallo, della quale era capitano il valentissimo cavaliere il signor Tristan da Cugna. Come egli giunse per mezzo Canonor, noi facemmo segno che stavamo in guerra, e subito il prudente fece armar tutti li battelli delle navi ed entrarvi dentro trecento cavalieri armati d’arme bianche, in modo che, se non fosse stato il nostro capitano che ci ritenne, subito smontati in terra noi volevamo andar a bruciar la città di Canonor. Pensate, o benigni lettori, che allegrezza fu la nostra quando vedemmo tal soccorso, perché in vero eravamo tanto stracchi che non potevamo più durare, e appresso la maggior parte feriti. Quando li Mori viddero la nostra armata così in ordine, subito mandorono un imbasciatore, il qual si chiamava Mamal Maricar, ch’era il più ricco della terra: e venne a dimandarne pace, per la qual cosa fu mandato al vice re, ch’era in Cochin, ad intendere quel che si aveva da fare. Il vice re ordinò che si facesse la pace, e questo fece egli solamente per poter caricare le navi e mandarle in Portogallo.
Passati quattro giorni, vennero duo mercanti di Canonor, li quali erano amici miei prima che fosse fatto guerra, e parlarono meco in questo modo che intenderete: “O fattore, mostrane un uomo il qual è più grande d’ogniun di voi un braccio, il quale ogni giorno ha ammazzato X, XV e XX di noi, e li Naeri erano alcuna volta quattrocento e cinquecento a tirare a lui, né mai una fiata lo poterono toccare”. Io gli risposi: “Quell’uomo non è qui, ma è andato a Cochin”. Poi pensai che quello era altro che cristiano e dissigli: “Amico mio, vien qua, quel cavaliere che hai visto non è portoghese, ma è il Dio de’ Portoghesi e di tutto il mondo”. Egli rispose: “Per Dio, che tu di’ la verità, perché tutti li Naeri dicevano che quello non era portoghese, ma che gli era lo Dio loro, e che era meglio lo Dio de’ cristiani ch’il suo, e loro non lo conoscevano: sì che a tutti parve che fosse miracolo di Dio”. Guardate che genti sono costoro e che ingegno è il loro, ch’alcuna volta stavano dieci e dodici uomini a veder sonare la nostra campana e la guardavano com’una cosa miracolosa, e poi che la campana non sonava più, dicevano in questo modo: “Questi toccano quella campana ed essa parla; come non la toccano, essa non parla più. Questo Dio di Portogallo è molto buono”. E ancora stavano alcuni di questi Mori alla nostra messa, e quando era mostrato il corpo di Cristo, io gli diceva: “Quello è il Dio di Portogallo e di gentili e di tutto il mondo”; e loro dicevano: “Voi dite la verità, ma noi non lo conosciamo”, onde si può comprendere che lor pecchino semplicemente. Si trovano però alcuni di questi che sono grandissimi incantatori: noi gli abbiamo visti constringer serpenti, li quali quando toccano alcuno subito casca morto in terra. Dicovi ancora che sono li maggiori e li più destri atteggiatori che credo siano in tutto il mondo.
41
Degli assalti che fecero li Portoghesi contra Pannani.
Finalmente approssimandosi il tempo di ritornare alla patria, imperoché il capitano dell’armata cominciava a caricare le navi per ritornarsene alla volta di Portogallo, e per esser io stato sette anni fuori di casa mia, e per l’amore e benivolenza verso la patria, e ancora per portarle notizia di gran parte del mondo, fui constretto a dimandar licenzia al signor vice re, il qual per sua grazia me la dette, e disse che prima voleva ch’io andassi con lui dove intenderete. E così lui e tutta la compagnia ci mettemmo in ordine d’arme bianche, per modo che poca gente rimase in Cochin, e a’ ventiquattro di novembre dell’anno sopradetto facemmo l’assalto dentro dal porto di Pannani: in questo giorno noi sorgemmo davanti la città di Pannani. La mattina seguente, due ore avanti giorno, il vice re si fece venir tutti li battelli delle navi con tutta la gente dell’armata, e dissegli come quella terra era quella che faceva guerra a noi più che terra alcuna dell’India, e per questo pregava tutti che volessero andare di buona voglia per espugnar questo luoco, il qual veramente è il più forte che sia in quella costa. Dapoi ch’ebbe parlato il vice re, il padre spirituale fece un sermone, che ogni uomo piangeva e molti dicevano per amor di Dio voler morir in quel luoco.
Un poco avanti giorno cominciammo la mortalissima guerra contra questi cani, li quali erano ottomila, e noi eravamo cerca seicento: che le due galee poco si adoperarono, perché non si potevano così accostar alla terra come li battelli. Il primo cavalier che saltasse in terra fu il valente signor don Lorenzo, figliuolo del vice re; il secondo battello fu quello del vice re, nel qual io mi ritrovai. E nel primo assalto fu fatta una crudel battaglia, perché qui la bocca della fiumara era molto stretta, e nella riva della terra stava gran quantità di bombarde, delle quali noi ne pigliammo quaranta bocche. In questo assalto furono presi sessantaquattro Mori, li quali aveano giurato o di voler morir in quel loco o vero esser vittoriosi, perché ciascun di loro era padron di nave e aveano molte mercanzie, che vedevan esser perse se noi eravamo vittoriosi. E così nel primo assalto scaricorono molte bombarde sopra di noi, ma Dio ci aiutò, che qui non morirono alcuni de’ nostri, ma di loro ne morirono cerca cento e sessanta. Il signor don Lorenzo ne ammazzò sei in mia presenza, ed egli ebbe due ferite, e molti altri ne furono feriti. Per un poco di spazio fu aspra la battaglia, ma poi che le nostre galee furono in terra, quelli cani cominciorono a tirarsi indrieto. E perché l’acqua cominciava a calare, noi non volemmo seguitargli più avanti, e quelli cani cominciorono a crescere: e per questo appicciammo il foco nelle lor navi, delle quali se ne abbruciorono tredeci, e la maggior parte nuove e grandi. Dapoi il vice re fece tirar tutta la gente nella punta, dove si stava sicuramente, e qui fece alquanti cavalieri, fra li quali per sua grazia fece ancor me, e il valentissimo capitano il signor Tristan da Cugna fu mio patrigno. Fatto questo, il vice re cominciò a far imbarcar genti, pur continuamente faccendo brusciar molte case del detto luoco, per modo che con la grazia di Dio, senza morte d’alcuno di noi, pigliammo il cammino verso Canonor, e subito il capitano nostro fece fornir le navi di vettovaglia, per ritornarsene verso la patria tanto da noi desiderata.
Etiopia
1
Nessuna cosa è più necessaria a quelli che, per utilità commune e per fare immortal il suo nome, scrivono istorie o ver narrano li siti delle regioni e paesi del mondo, che di tener avanti gli occhi e aver sempre fisse nella memoria le cose che nelli libri superiori hanno (per non esservi l’occasione) pretermesso di dire, acciò che, dimenticandosi di alcuna di esse, non diano causa a’ curiosi lettori di accusarli di negligenzia e di oblivione. E perché nel principio di questo libro, dove si trattò dell’Etiopia, non mi par che fosse a bastanza detto di quella, però nel fine di questa mia faticosa peregrinazione, essendo il luogo opportuno, si narrerà di molti luoghi e isole che nel ritorno mio si viddono, non pretermettendo li pericoli e le fortune ch’io passai.
2
Di varie isole nel mar Oceano meridional della Etiopia.
Alli 6 di decembre pigliammo il nostro cammino verso l’Etiopia, e passammo il colfo, che sono circa tremila miglia di passaggio, e arrivammo all’isola di Monzambich, la qual è del re di Portogallo. E innanzi che arrivassimo alla detta isola, vedemmo molte terre le quali sono sottoposte al serenissimo re di Portogallo, nelle qual città il re tiene buone fortezze, e massime in Melinde, ch’è reame, e Mombaza, la qual il vice re la messe a fuoco e fiamma; in Chiloa vi tiene una fortezza e una se ne faceva in Monzambich; in Ceffalla v’è un’altra fortezza. Io non vi scrivo quel che fece il valente capitano il signor Tristan da Cugna, ch’al venire che fece in India prese Goa e Pate città, e Brava isola fortissima, e Zacotara bonissima, nella quale tien il prefato re buone fortezze: la guerra che fu fatta non vi scrivo, perché non mi vi ritrovai. Taccio ancora molte belle isole che trovammo pel cammino, fra le quali v’è l’isola del Cumere, con sei altre isole d’intorno, dove nasce molto zenzero e molto zuccaro, e molti frutti singulari, e carne d’ogni sorte in abbondanza. Ancora vi dico d’un’altra bella isola chiamata Penda, la qual è amica del re di Portogallo ed è fertilissima d’ogni cosa.
3
Di Monzambich isola, e degli abitatori nella terra ferma sopra la Etiopia.
Torniamo a Monzambich, dove il re di Portogallo (come ancora in Ceffalla isola) cava grandissima quantità d’oro e d’avolio, il qual vien portato da terra ferma. Noi stemmo in questa isola cerca 15 giorni, e la trovammo esser piccola. Gli abitatori della quale sono negri e poveri, e hanno qui poco da mangiare, ma il tutto li vien da terra ferma, la qual è molto prossima; nondimeno qui è bonissimo porto.
Alcuna volta noi andavamo a piacere per la terra ferma, per vedere il paese, dove trovammo alcune generazioni di genti tutte negre e tutte nude, salvo che gli uomini portano il membro nascoso in una scorza di legno, e le donne portano una foglia davanti e una di drieto. E questi tali hanno li capelli ricci e corti, le labbra della bocca grosse due dita, il viso grande, li denti grandi e bianchi come la neve. Sono costoro molto timidi, massime quando veggono gli uomini armati: vedendo noi queste bestie esser pochi e vili, ci mettemmo insieme circa cinque o sei compagni, molto ben armati con schioppi, e pigliammo una guida nella detta isola che ci menò per il paese, e andammo una buona giornata in terra ferma. Per questo cammino trovammo molti elefanti in frotta, e colui che ci guidava, per rispetto di questi elefanti, ci fece portar certi legni secchi accesi di fuoco, li quali sempre faceano fiamma: e quando gli elefanti vedevano il fuoco fuggivano, salvo una volta che trovammo tre elefante femine le quali aveano li figliuoli drieto, che ci dettero la caccia per fino ad un monte, dove ci salvammo. E camminammo per il detto monte ben dieci miglia, poi discendemmo giuso dall’altra banda e trovammo alquante caverne, dove si riducevano li detti Negri, li quali parlano in un modo che a gran fatica ve lo saperò dar ad intendere: pur sforzarommi di dirvelo meglio che potrò con esempio. Quando li mulattieri vanno drieto alli muli in Sicilia e vogliono cacciarli innanzi, posta la lingua sotto il palato fanno un certo verso stranio e un certo strepito, col qual fanno camminar li muli: così è il parlare di queste genti e con atti assai in tanto se intendono.
La nostra guida ne dimandò se volevamo comperar qualche vacche e buoi, che ne faria aver buon mercato; noi respondemmo che non avevamo danari, dubitando che non s’intendesse con quelle bestie e farne robare. Disse costui: “Non vi bisogna danari in questa cosa, che loro hanno più oro e argento che voi, perché qui appresso lo vanno a trovar dove nasce”. Dimandammo noi la guida: “Che vorriano adunque essi?” Disse: “Loro amano alcuna forficetta piccola e un poco di panno per ligarselo intorno; hanno molto caro ancora qualche sonaglio piccolo per li suoi figliuoli e qualche rasoio”. Rispondemmo: “Noi gli daremo parte di queste cose, pur che ci vogliano condurre le vacche alla montagna”. La guida disse: “Io farò che ve le condurranno per fino in cima della montagna, e non più oltra, però ch’elli non passano mai più avanti. Ditemi pur ciò che gli volete dare”. Un nostro compagno bombardiero disse: “Io li darò un buon rasoio e un sonaglio piccolo”; e io, per aver carne, mi cavai la camicia e dissi che li daria quella. Allora la guida, vedendo quello che volevamo dare, disse: “Chi condurrà poi tanto bestiame alla marina?” Rispondemmogli tanto ci dessero quanto ne condurremmo, e la guida pigliò le cose sopradette e dettele a cinque o sei di quegli uomini, e dimandolli trenta vacche per esse. Costoro, che son come animali, fecero segnale che volevano dar quindeci vacche; noi dicemmo che le pigliasse, ch’erano assai, pur che non ci gabbassero. Subito li Negri ci condussero fino in cima della montagna quindeci vacche; ma, quando fummo un pezzo dilungati da loro, quelli che eran restati nelle caverne cominciarono a far rumore, e noi, dubitando che non fossen per venirne drieto, lassammo le vacche e tutti ci mettemmo in arme. Li duoi Negri che conducevano le vacche ci mostravano che non avessimo paura con certi suo’ segni, e la nostra guida disse che doveano far questione, perché ciascuno aria voluto quel sonaglio. Noi ripigliammo le vacche e andammo per fin in cima del monte, e li due Negri poi tornorono al suo cammino. Al dismontar nostro per venire alla marina, passammo per un boschetto di cubebe cerca cinque miglia, e scontrammo parte di quegli elefanti che trovammo all’andare, li quali ci misero tanta paura che fu forza lasciar parte delle vacche, le quali fuggirono alla volta delli Negri; e noi tornammo alla nostra isola.
E quando fu fornita la nostra armata di quanto gli era bisogno, pigliammo il cammino verso il capo di Buona Speranza, e passammo infra l’isola di S. Lorenzo, la qual è distante da terra ferma LXXX leghe: e presto credo che ne sarà signore il re di Portogallo, perché ne hanno già pigliate due terre e messe a fuoco e fiamma. Per quello ch’io ho visto dell’India e dell’Etiopia, a me par che ‘l re di Portogallo (piacendo a Dio e avendo vittoria come ha avuto per il passato) sarà il più ricco re che sia al mondo. E veramente egli merita ogni bene, perché nell’India, e massime in Cochin, ogni giorno di festa si battezzano X e XII gentili e mori alla fede cristiana, la qual ogni giorno per causa di detto re si va aumentando: e per questo è credibile che Dio gli abbia dato vittoria, e per l’avenire continuamente lo prospererà.
4
Del capo di Buona Speranza.
Torniamo al nostro cammino. Passammo il capo di Buona Speranza, e cerca dugento miglia lontani dal detto capo si levò una gran fortuna di vento, e questo perché v’è a man manca l’isola di San Lorenzo e molt’altre isole, dalle quali suol nascer grandissima furia di venti: e questa fortuna durò per sei giorni, pure con la grazia di Dio la scampammo. Passato che avemmo poi dugento leghe, ancora avemmo grandissima fortuna per altri sei giorni, dove si perdette tutta l’armata un dall’altro, e chi andò in qua e chi in là. Cessata la fortuna, pigliammo il nostro cammino e per fino in Portogallo non ci vedemmo più.
Io andava nella nave di Bartolomeo Marchioni, Fiorentino abitante in Lisbona, la qual nave si addimandava San Vicenzo e portava settemila cantara di spezie d’ogni sorte. E passammo appresso d’un’altra isola chiamata Santa Elena, dove vedemmo duoi pesci che ciascun di loro era grande come una gran casa, li quali, ogni volta che veniano sopra l’acqua con la bocca aperta, parea che discoprisseno il viso e che alzassino le sopraciglie della fronte, a modo di uomo armato quando alza la visiera, e quella poi abbassavano quando volevan camminare sotto acqua, la qual fronte era larga quasi tre passa. Dall’empito de’ quali ne l’andare sotto acqua fummo tutti spaventati, in modo che scaricammo tutta l’artiglieria per farli dipartire di quel luogo. Poi trovammo un’altra isola chiamata l’Ascensione, nella quale trovammo certi uccelli grossi come anitre, li quali si posano sopra la nave, ed erano tanto semplici e puri che si lasciavano pigliare con le mani; ma quando erano presi, parevano molto bravi e feroci, e prima che fussero presi guardavano noi come una cosa miracolosa: e questo era per non aver mai più visto uomini, perché in questa isola non v’è altro che pesce e acqua e questi uccelli.
Passata la detta isola, navigando alquanti giorni, cominciammo a vedere la stella tramontana. E nondimeno molti dicono che, non vedendosi la tramontana, non si può navigare se non col polo antartico: lassateli dire, noi navigammo sempre con la tramontana, e ben che non si veda la detta stella, nientedimeno la calamita fa sempre l’officio suo e tira al polo artico. Dapoi alcuni giorni arrivammo in un bel paese, cioè all’isole degli Astori, le quali sono del serenissimo re di Portogallo; e prima vedemmo l’isola del Pico e quella di San Giorgio, l’isola dei Fiori, quella del Corvo, la Graziosa, l’isola del Faial, e poi arrivammo all’isola Terziera, nella qual stemmo duoi giorni: queste isole sono molto abbondanti.
Poi partimmo de qui e andammo alla volta di Portogallo, e in sette giorni arrivammo alla nobile città di Lisbona, la quale è una delle nobili e buone ch’io abbia visto. Lo piacere e l’alleggrezza ch’io ebbi, giunto ch’io fui in terra ferma, lo lasso pensar a voi, o miei lettori benigni. E perché il re non era in Lisbona, subitamente mi posi in cammino e andai a trovarlo in un suo luoco, chiamato Almada, a riscontro della quale è Lisbona. Dove arrivato, fui a basciar la mano a sua Maestà, la qual mi fece molto carezze e tennemi alquanti giorni alla sua corte, per saper le cose dell’India. Passati alquanti giorni, mostrai a sua Maestà la carta di cavalleria, la qual me avea fatta il vice re in India, pregandola (se le piaceva) de volermela confirmare e signar di sua mano, mettendovi il suo sigillo. Visto ch’ebbe detta carta, disse che era contento, e così mi fece fare un privilegio in carta membrana, signato di sua mano col suo sigillo e registrato. E pigliata che ebbi licenzia da sua Maestà, me ne venni alla volta della città di Roma.



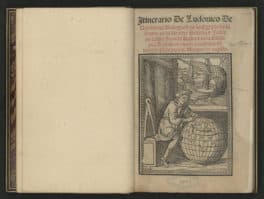
 VARTHEMA, L
VARTHEMA, L
![20101212060805880[1]](https://beyondthirtynine.com/wp-content/uploads/2017/02/201012120608058801-264x132.jpg)